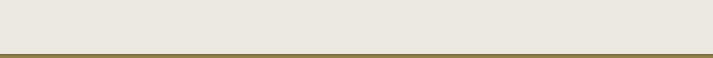|
Homepage personale diOctavio Paz |
(Articolo di Massimo Barile pubblicato sulla rivista Il Club degli autori 181-182-183 Maggio 2008)
Octavio Paz
«La sfida poetica al tempo
Quando inizio a leggere una buona parte di opere dello scrittore o del poeta prescelto per l’articolo della rivista, mi prefiggo di seguire una linea di condotta, un personale canovaccio, cerco di fissare nella mia mente alcune direttive. Poi, immancabilmente, mi rendo conto che è fondamentale “entrare” nelle parole e, ancor più, nelle intenzioni che hanno scaturito la nascita di quelle parole, fino a scoperchiare ciò che non è esplicito, estrarre dalla polvere che ha ricoperto le pagine anche solo un bagliore che riconduca alla sostanza autentica di ciò che lo scrittore voleva conservare nel tempo. Ecco allora che sembra di vivere la stessa emozione d’un archeologo che scava nella terra, nel passato, nell’oscurità del tempo, per riportare alla luce ciò che era sepolto, sedimentato, dimenticato, celato sotto un sottile velo o qualche metro di terra. Capita sovente di far rivivere alcune parole che hanno effetti assai diversi, a seconda della personalità del lettore, miscelando visioni positive ed evidenze negative.
Non vi sono codici d’avvicinamento, traiettorie sicure, considerazioni valide per tutte le stagioni: questa è la magia d’ogni nuova lettura, dell’ultimo saggio scritto in un momento di creatività. Questo è il sussulto inebriante che offre la nuova impresa.
Tutto si consuma, nell’eterna lotta contro la morte, e anche Octavio Paz scrive che i linguaggi «nascono e muoiono, tutti i significati un giorno cessano di avere significato»: non rimane che arrendersi all’evidenza, alla cessazione del significato. Le sue parole non si fermano e arrivano alla constatazione che il testo poetico è «come quei nudi femminili della pittura tedesca che simbolizzano la vittoria della morte: monumenti vivi della corruzione della carne».
La visione si spinge oltre, fino a definire la figura stessa del poeta: «Non è poeta chi non abbia sentito la tentazione di distruggere il linguaggio o di crearne un altro, chi non abbia provato il fascino della non-significazione e quello, non meno terrificante, della significazione indicibile».
Octavio Paz è il poeta che scrive queste sconvolgenti parole: «L’opera non è fine a se stessa né possiede esistenza propria: l’opera è una parte, una mediazione. La critica del soggetto comporta la distruzione, non del poeta o dell’artista, ma della nozione stessa d’autore. Per i Romantici, la voce del poeta era quella di “tutti”; per noi è rigorosamente quella di nessuno. Ad uguale distanza dall’autore e dal suo Io, nessuno e tutti si equivalgono. Il poeta non è un piccolo dio…».
Ecco allora che si abbandonano le seduzioni e «il poeta scompare dietro la propria voce, una voce sua perché voce del linguaggio, di tutti e di nessuno. Qualsivoglia nome diamo a quella voce – ispirazione, inconscio, azzardo, accidente, rivelazione – essa rimane sempre voce di ciò che è “altro“».
Nella poesia di Octavio Paz tutto può essere una “porta” che si apre, basta una lieve pressione e qualcosa può accadere: la città si può aprire “come un cuore”, la notte può aprirsi in una “costellazione di segni”, l’autunno vacillare oltre “il muro verdigno”, il desiderio di incarnarsi in un nuovo corpo.
Tutto diventa un “ponte” che congiunge, che permette di oltrepassare un luogo, che unisce e tiene distante nello stesso tempo: si può guardare lo scorrere del fiume della vita, una ragazza col cappotto color fragola, osservare lucertole sui muri di mattoni, il mormorio d’incerti fogliami, le vie deserte, la luce di una lampada, le torri di sabbia che si sgretolano e la luce che s’inabissa come una stella caduta nei cerchi del basalto.
Il nome antico del fuoco, l’antidoto che apre un nuovo spazio nello spazio, altro tempo nel tempo, il corpo immerso in una luce crudele, sostanza del tempo e invenzioni in un giardino che non è più un “luogo” ma fluisce nella notte: in questa sfida poetica al tempo, il poeta si posiziona «prima della storia, ma non all’infuori della stessa. Prima in quanto realtà archetipa che è impossibile datare, inizio assoluto, tempo totale e autosufficiente. Dentro nella storia – meglio, storia anch’egli – perché vive soltanto incarnato, ri-generandosi, ripetendosi nell’attimo della comunione poetica. «Senza la storia – senza gli uomini che sono origine, sostanza e fine della storia – il poema non potrebbe nascere né incarnarsi; e senza il poema non ci sarebbe nemmeno storia, perché non ci sarebbero né origine né inizio» così scrive Octavio Paz in L’arco e la lira nel lontano 1972.
Nella sfida poetica al tempo c‘è il silenzio della scrittura che “canta”, ci sono le parole udite da qualcuno, le parole dette da qualcuno, la verità del desiderio, echi in labirinti e i tentativi di conservare le parole come “tesoro ardente” plasmato nella roccia, grani di energia sotterrati, spiragli all’interno d’un granito dormiente.
«La vita non comincia senza il sangue/ senza la brace del sacrificio» e il sangue stilla come gocce di rubino e pare incandescente: poi si assiste all’addensamento, alla sublimazione, all’evaporazione del sangue stesso. Così l’attività poetica «nasce dalla disperazione di fronte all’impotenza delle parole e termina nel riconoscimento dell’onnipotenza del silenzio». E ci si trova davanti ad un mondo sulfureo, a volte, quasi pietrificato, eppure vibrante, in una dilatazione dello spazio, sospeso in una riconciliazione possibile proprio come la salamandra che diventa un “ponte sospeso tra le ere”, un ponte di sangue freddo, una “fiamma nera”.
E proprio quel nero, colore dell’infinito, ritorna come parola chiave, come visione cosmica: ecco allora che il “nero persistente” diventa simbolico come il “sole nero”, gli “alberi neri”, il “panno nero di lacrime”, la “piccola lingua nera”, “l’altare nero”, la stella nera, la pietra nera, la montagna nera, il “pensiero nero”, reiterati ossessivamente come terra nera che si sgretola mentre i “lamenti svaniscono” nel deserto immenso, alla ricerca d’una fonte segreta. «Scorpione che si conficca nel mio petto/ sigillo di sangue sui miei anni d’uomo»: la parola diventa la sola rivelazione, il simbolo umano del continuo errare in terre sconosciute per cercare, nell’ultimo disperato tentativo, di accedere al regno perduto. Octavio Paz sente nel profondo tale tensione e la vive completamente: non a caso può essere definito poeta, saggista, favolista, monaco, esploratore e ricercatore della parola. Senza limitazioni, oltre la forma, come ad inglobare la realtà della parola con l’immersione nell’immaginario, nella visione atemporale.
Proprio nel momento in cui si porta la negazione al suo limite, ecco la contemplazione, la disincarnazione del linguaggio, la trasparenza in un mondo che è invenzione dello spirito. E Octavio Paz riporta questa negazione con parole che non lasciano spazio a fraintendimenti: «Alla fine ci attende il gioco: festa, consumazione dell’opera, incarnazione momentanea e dispersione». Su questo fragile ponte di parole, il poeta rende partecipi della sua visione «L’ora m’innalza/fame d’incarnazione patisce il tempo/Oltre me stesso/in qualche luogo attendo il mio arrivo» come si legge nella chiusa della lirica Il balcone. In una lenta costruzione d’una architettura del silenzio, nelle ondulazioni continue, nelle vibrazioni dello spazio, v‘è il costante zampillo di segni, una incessante marea di “imminenti apparizioni” fino alla presa d’atto finale «Il quadro è volge su se stesso e si sotterra / nel giorno di pietra / Acqua non c‘è ma gli occhi brillano».
Tutto «frana in silenzio sulla pagina», come a vedere tutto e vedere nulla, essere padroni della notte e, allo stesso tempo, preda delle tenebre: in fondo esiste solo l’unico grande film che è la vita.
E la parola è in primo piano, sugli occhi del poeta, un piano sequenza unico che dura all’infinito: per reinventare tutto. Nei frammenti dello spazio, nel superamento dell’Io, fissare la visione poetica spirituale, luce nella notte in una continua esegesi cosmica. Ecco le evidenze dei periodi trascorsi in Oriente negli anni Cinquanta e Sessanta e l’attrazione del pensiero orientale.
Le figurazioni e i “resti delle scintille”, così come i luoghi e le sospensioni, le combinazioni e gli occhi riflessi, non sono altro che le modulazioni d’un occhio unico, nascosto dietro il suo manto di trasparenze, messe di meraviglie: dal colore alla forma, dalla forma all’incendio.
La voce umana è una “scia dell’anima che si disincarna” e l’estensione poetica si tramuta in una trasparenza che “regge le cose”.
Non è possibile limitare la capacità di espansione letteraria e culturale di Octavio Paz con una semplice definizione di poeta ma piuttosto viene spontaneo constatare la formidabile energia che sprigiona la sua Parola, il suono poetico che si riesce a catturare, la volontà di superare il confine reale e terreno. «Capire una poesia vuol dire, in primo luogo, udirne il suono» questo è ciò che afferma il poeta proprio perché «le parole entrano dall’orecchio, appaiono davanti agli occhi, spariscono nella contemplazione». L’attenzione si sposta sul suono delle parole, sulle immagini che si creano e ricreano davanti ai nostri occhi: in fin dei conti, possiamo immaginare, fantasticare e illuderci mentre ascoltiamo una poesia. «Leggere una poesia è udirla con gli occhi, udirla è un corpo/avvolto solo nel suo enigma nudo».
Octavio Paz pare avere come intenzione quella di provocare il lettore: costringerlo a udire, a “udirsi”.
In Versante est il poeta scrive «ignorando l’esito di ciò che scrive», come ad avventurarsi tra le righe, la sua immagine è «la lampada accesa nel pieno della notte»: un saltimbanco tra i suoi “pensieri in fuga”, nel flusso della marea della memoria, nella lacerazione e nel vortice, tra l’assoluto e il confine terreno, fino all’ultimo pensiero «ho fame di vita e anche di morte / Conosco ciò in cui credo e lo scrivo», per giungere all’ultimo atto «movimento in cui si conforma / e si sfalda l’essere intero / Mani e coscienza per cogliere il tempo / sono una storia / una memoria che s’inventa / Mai sono solo / parlo sempre con te / parli sempre con me / Cammino nel buio e pianto dei segni».
Le evidenze della realtà e la sostanza stessa del tempo vengono vivisezionate: «Le pietre sono tempo / Il vento / secoli di vento / Gli alberi sono tempo / gli uomini sono pietre / Il vento / si avvederla con gli orecchi».
«Leggendo, ascoltando una poesia, non sentiamo, non assaporiamo non tocchiamo le parole. Tutte queste sensazioni sono immagini mentali. Per sentire un testo poetico occorre capirlo; per capirlo ascoltarlo, vederlo contemplarlo: convertirlo in eco ombra nulla. La comprensione è un esercizio spirituale».
La poesia è la nostra unica istanza contro il tempo rettilineo, contro il progresso.
La morale dello scrittore non è nei suoi temi, nelle sue intenzioni, ma nella sua condotta davanti al linguaggio. Octavio Paz riporta alla mente dell’essere umano che la poesia è la «sola rivelazione dello stato di cose attuale».
«Attraverso le parole possiamo accedere al regno perduto e così recuperare gli antichi poteri. Quei poteri che non ci appartengono» e poi, quasi a ricercare una rivelazione, ecco la constatazione finale che diventa inesorabile presa d’atto «l’uomo ispirato, colui che davvero parla, non dice nulla di suo; per la sua bocca parla il linguaggio».
Octavio Paz, fin dall’inizio del suo percorso letterario, si è impegnato in una indagine profonda e in una continua penetrazione per avvicinarsi all’essenza poetica: una sintesi estrema, quasi una scarnificazione testuale, in una operazione di riduzione piuttosto che di incremento poetico. Octavio Paz “sente” nel profondo il testo fino a viverlo completamente, fino a raggiungere una simbiosi tra l’efficacia delle parole e l’immersione nell’immaginario.
Un continuo errare attraverso le immagini, le creature, gli elementi naturali, le simbologie, e “l’altra faccia dell’essere”, l’altra faccia del tempo, il rovescio della vita, quando la bellezza non è più leggibile, quando la presenza diventa terribile, quando il visibile diventa invisibile, quando il tempo si ferma, quando «il luogo solitario è il punto di convegno».
Tra quiete e movimento, tra cicatrici cosparse di sale e l’uragano che «s‘è piantato in mezzo all’anima». La vita come un lento avanzare tra precipizi, tra turbine e vuoto, in lotta con i sogni, ogni volta più in fondo nel corpo, nel delirio, nella ferita, «nel mondo che si chiude come un anello», nell’onda che rinasce…
Concepire lo spirito fuori del dramma della vita eppure assaporare l’amarezza diabolica che esaurisce il contenuto, la realtà corporea: incanalare la sconvolgente passione per dimenticare tutto, per sfuggire alla coscienza. Nell’istante dell’ultimo pensiero e dell’ultimo abbandono ci si ritrova davanti al dilemma: o esplodere in una deflagrazione definitiva e ammettere il trionfo del non essere o vivere la rivelazione del tempo, sentirsi invasi dalla vita e scaldarsi alla fonte luminosa del proprio essere. E forse pervenire al valore assoluto del primigenio suono, della divina voce, della prima parola.
Massimo Barile