
Né angeli né demonidiRosa Maria Corti |
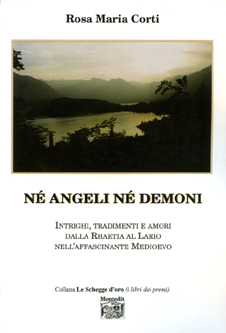
Collana "Le Schegge d'Oro" - I libri dei Premi - Narrativa
14x20,5 - pp. 158 - Euro 13,50
ISBN 978-88-6037-5896
Clicca qui per acquistare questo libro
Prefazione
“Né angeli, né demoni”, nuova opera di Rosa Maria Corti Terragni, chiude la trilogia iniziata con “Mistero all’Abbazia” e “La Colombera” come a suggello d’una lunga rivisitazione storica che l’autrice conduce al suo epilogo sempre confermando la capacità narrativa di rendere “vivo” ciò che racconta e l’estrema attenzione al giusto dosaggio delle raffigurazioni dei protagonisti, dei riferimenti storici e culturali nonché dell’abilità nel ricreare atmosfere antiche che sono meravigliosamente “vere”.
Gli avvenimenti vengono riportati nel diario della conversa Gertrude Vols, vicende conosciute e avventure di cui fu anche protagonista, che racconta della sua devozione per la nobile monaca Ildegarda dalla quale aveva ricevuto numerosi insegnamenti, potendo sempre contare sulla sua protezione amorevole e su un rapporto che si basava sulla totale fiducia.
Nel silenzio del monastero St. Johann, in un freddo inverno che ghiacciava l’acqua, la conversa Gertrude si avvia al suo calefatorium, e i suoi pensieri vagano tra i ricordi che rivivono il suo lungo peregrinare al seguito di Ildegarda, ora divenuta badessa; quindi l’arrivo, nel febbraio del 1262, al monastero benedettino di San Faustino e Giovita, in Tremezzina, sulle rive del lago di Como; e poi, nell’hospitalis della Carolza, sui monti di Casasco, dove cercavano di mettersi al sicuro dai tragici eventi che si prospettavano anche se poi Ildegarda si era dovuta nascondere e Gertrude era rimasta in attesa di ricongiungersi con lei, incontro che avverrà nel Tirolo e, subito dopo, il trasferimento al monastero di St. Johann e una nuova partenza per una missione affidatale da Ildegarda per conto dell’amato fratello Ulrico, accompagnata da Ludwig che l’avrebbe aiutata ad affrontare la nuova pericolosa impresa.
Ora, il Signore di Tarasp, l’avido e vendicativo Reichemberg, aveva deciso di maritare la figlia Matilde anche per accrescere gli appoggi politici e incrementare la sua forza grazie all’unione delle due famiglie che si riunivano, i Reichemberg e i Planta.
Da questa decisione scaturirà un susseguirsi di eventi inaspettati: il rapimento della figlia Matilde, il ritorno del conte Ulrico, fratello della badessa Ildegarda, che aiuterà Matilde a fuggire e, dopo averla salvata, si innamorerà di lei; seguiranno poi lunghe traversie e vicissitudini d’ogni sorta, e, alla fine, la giovane Matilde sarà liberata dal padre e il suo destino, ormai già segnato, la condurrà in convento.
Rosa Maria Corti Terragni, in una continua miscela di riferimenti storici, di brevi spaccati di vita quotidiana, di contese e conflitti tra feudatari, di alleanze e tradimenti, di precarietà quotidiana, che vedono come sfondo le atmosfere d’un carosello medioevale, rese nel pieno della loro efficacia, riesce ad alimentare in continuazione, immettendovi sempre nuova linfa, questo nuovo libro che chiude la trilogia sopra accennata, mai dimenticando di ammantare le vicende con una narrazione densa di eventi che coinvolgono fino all’ultima pagina.
Di sicuro, si deve prendere atto d’una precisione e perizia nelle descrizioni storiche, nella rappresentazione dei personaggi, nelle raffigurazioni dei luoghi del lago lariano e d’una innegabile capacità, da parte di Rosa Maria Corti Terragni, di fissare sulle pagine di “Né angeli né demoni”, una fedele fotografia del tempo in cui si snodano gli eventi, accompagnata da una scrittura precisa che diventa un appassionato abbraccio alle storie della sua terra.
Massimo Barile
Note dell’Autrice
La società del Basso Medioevo, con le sue luci e le sue ombre, ha sempre esercitato un fascino particolare su di me. Con “Né angeli, né demoni”, che segue “Mistero all’Abbazia” e la “Colombera”, si chiude la trilogia dedicata a quel particolare periodo storico che vide sorgere sul territorio in oggetto, (ovvero quello che si estende dall’alta Rhaetia al lago di Como, lungo un importante itinerario medioevale molto frequentato da pellegrini e mercanti), ospizi e xenodochi, chiese ed abbazie, castelli e torri, monumenti in parte ancor oggi visibili grazie alla popolazione e alle autorità locali che hanno voluto e saputo conservarli proteggendoli dagli oltraggi del tempo.
Il mio lavoro, che miscela l’invenzione con il vero, personaggi di fantasia con personaggi reali, vuole essere prima ancora che un piccolo contributo alla conoscenza del passato, nella convinzione che l’avvenire è sempre alimentato da quest’ultimo, un omaggio all’operosità dei nostri antenati, dall’importante “magister” all’umile apprendista, nella speranza che il lettore, ripercorrendo quelle antiche vie, possa non soltanto ammirare un paesaggio naturale quanto mai vario ed emozionante ma soprattutto scoprire, o riscoprire, veri e propri capolavori architettonici e ritrovare anche quella volontà di conoscere e di fraternizzare che animò uomini di ogni categoria sociale mentre si recavano da uno sperduto villaggio di montagna, da un anonimo mercato di provincia, da una minuscola chiesa di campagna verso le grandi città, le importanti fiere internazionali, le spettacolari cattedrali delle sante mete.
Né angeli né demoni
Intrighi, tradimenti e amori
dalla Rhaetia al Lario
nell’affascinante Medioevo
Ai Gaddi,
mia “radice” e “Magistri” fiorentini
O voi ch’avete ‘ntelletti sani
mirate la dottrina che s’asconde
sotto ‘l velame de li versi strani.
Dante, Inferno, XI, 61-63
IL SEGNALE: AUTUNNO 1273
Nel cuore del monastero di St. Johann regnava il silenzio.
La notte, in quel primo giorno di novembre, era stata particolarmente rigida tanto che nel dormitorio comune l’acqua per le abluzioni mattutine era quasi ghiacciata nella brocca. Le monache se n’erano accorte quando, dopo un sonno inquieto, fra le due e le tre s’erano levate come sempre per recitare l’ufficio divino. Dopo prima1 il freddo era ancora intenso e la conversa Gertrude, abbandonato il mandatum2 dove s’era recata per la preghiera personale, rabbrividì nella sua tonaca leggera mentre si avviava verso il calefactorium, il solo locale del monastero, a parte la cucina, ad essere riscaldato, dove avrebbe atteso ad uno dei suoi numerosi compiti, quello relativo alla preparazione degli inchiostri e dei colori per le miniature. Adesso il suo pensiero vagava libero oscillando fra i ricordi di un passato non ancora lontano ed il tema della nuova miniatura che avrebbe abbellito la pagina di un inno dei vespri.
Quel piccolo dipinto avrebbe dovuto parlare a tutti, anche ai più umili, attraverso figure e simboli che richiamassero la presenza di Dio, la sua signoria sul mondo. L’universo visibile, infatti, è un segno di ciò che non si vede ma che sta all’origine di tutto. La conversa decise che per quella volta non avrebbe raffigurato draghi, grifi e altre creature mostruose, ovvero i simboli di quelle forze diaboliche che senza sosta cercano di far cadere l’uomo nella tentazione e nel peccato, bensì foglie, fiori, rami e frutti, insomma tutte quelle forme vegetali che la riportavano ad un Eden non solo immaginario ma anche reale, all’immagine di un lago dove le chiese sono numerose come le piante di melograno, alloro e ulivo, dove la primavera sembra non avere mai fine e la luce pare scomporsi in mille riflessi argentati.
In un attimo rivisse il suo lungo peregrinare al seguito di Ildegarda, la nobile monaca ora divenuta badessa, rivide il loro arrivo nel febbraio del 1262 al monastero benedettino di San Faustino e Giovita nell’incantevole Tremezzina, sulla riviera del lago di Como. Da lì, con la sua signora, si era incamminata verso l’hospitalis della Carolza sui monti di Casasco, una meta che avrebbe dovuto metterle al sicuro dai tragici eventi che si andavano prospettando.
Così però non era stato. Gli eventi erano precipitati e Ildegarda si era dovuta nascondere ancora per evitare il peggio. Gertrude invano l’aveva attesa, poi, sola e senza denaro, aveva abbandonato il rifugio sui monti per cercarla. Come in un caleidoscopio nella sua mente si avvicendavano il suo purtroppo breve matrimonio con un umile pescatore della Tremezzina, l’arrivo in Como, il pellegrinaggio a Santiago, l’esperienza del beghinaggio nel sud della Francia, il ritorno nella sua adorata patria, il Tirolo, dove s’era finalmente potuta ricongiungere con Ildegarda, il successivo trasferimento nel monastero di St. Johann, l’ennesima partenza per un’importante missione che le era stata affidata dalla sua signora per conto dell’amato fratello, il nobile Ulrico dei conti di Tures e di Tirolo.
In quel nuovo periglioso cammino, durante il quale s’era confrontata con uomini e donne, umili e potenti, pellegrini ed eremiti, artigiani e mercanti, cavalieri templari ed abati, era stata accompagnata da Ludwig, il giovane ed ambizioso scudiero di Ulrico.
Smanioso di libertà, desideroso di affrancarsi dall’autorità del suo signore, quest’ultimo aveva trovato il coraggio d’inseguire un sogno, quello di una terra promessa e aveva abbandonato tutto intenzionato a raggiungere Venezia, la nobile e superba città dove si diceva non dimorassero “né Patari, né Catari, nullo usuriere, né micidiale, né ladrone, né rubatore”.
“Stadtluft macht frei”, “L’aria della città rende liberi”, recitava un noto detto e, in effetti, erano in molti a tentare la fuga in città.
“Avrà raggiunto la sua meta Ludwig?”
Questo si stava chiedendo Gertrude quando il ripetuto e martellante suono di una campanella la riscosse dai ricordi.
Superato l’armarium, il piccolo locale adibito a biblioteca e attraversata l’ala orientale del chiostro che fungeva da corridoio, la conversa si diresse con la massima sollecitudine verso la torre riservata all’abitazione della badessa. Non era ora d’Ufficio divino e quel segnale reiterato lasciava intendere che qualcosa di grave doveva essere capitato.
1. Prima. Preghiera delle sette. Altre ore canoniche: Mattutino (al sorgere del sole); Terza (circa le nove); Sesta (a mezzogiorno); Nona (circa le quindici); Vespri (al tramonto); Compieta (al crepuscolo, al compimento della giornata).
2. Mandatum. Lato nord del chiostro.
LA PROMESSA DI MATRIMONIO
Il Reichenberg, signore di Tarasp, abbandonato il suo castello, un’imponente costruzione che come una bianca sentinella si ergeva su uno sperone roccioso alto un centinaio di metri a dominare magnificamente la Bassa Engadina, con l’unica figlia e l’effeminato nipote Joanne si accinse a salire verso Zuoz, nell’alta valle, per sottoscrivere un importante accordo con Pompejus Planta.
I Planta, distinti nei rami di Zuoz, Zernez, Samedan e Coira, erano un’importante famiglia originaria di Zuoz con possedimenti anche in Val Bregaglia e a Pompejus il vescovo di Coira aveva già da tempo conferito il diritto di cancelleria, ovvero le funzioni di notaio, in tutta la valle.
A giudicare dalle sopracciglia leggermente inarcate, un pensiero sembrava infastidire il vigoroso feudatario. Avrebbe voluto, infatti, evitarsi il fastidio di trovare un marito per la figlia che cavalcava accanto a lui ma, avendo quest’ultima già festeggiato il suo diciassettesimo compleanno, era ora che si maritasse visto che le ragazze già a quindici anni erano considerate pronte per sposarsi.
La giovane, che si chiamava Matilde, guardava ostinatamente davanti a sé. Aveva la carnagione brunita dal sole e i capelli, raccolti in una morbida treccia, mandavano riflessi che facevano pensare al colore delle castagne appena diricciate. Con sicurezza, ma quel giorno senza diletto, governava il suo baio che talora dava segni d’irrequietezza. Sebbene fosse femmina era abituata a cavalcare, anche a lungo, e sapeva cacciare con il falcone. Adorava stare all’aria aperta, sentirsi in sintonia con Biba, il suo rapace preferito che, lanciato su un albero alla partenza per una battuta di caccia, la seguiva nel fitto del bosco senza bisogno di essere richiamato per poi piombare da un albero, ad un suo minimo richiamo, sulla femmina di un gallo di monte o su un coniglio selvatico che invano avrebbe cercato un rifugio o una via di fuga. Al tramonto, non ancora paga dello spettacolo che la natura sempre regala a chi è attento e sensibile osservatore, cercava sempre una scusa per ritardare il suo rientro al castello.
Dopo la morte della madre, infatti, in quel mondo quasi tutto al maschile, si sentiva sempre più osservata. Gli amici di suo padre la guardavano con occhi diversi, sfacciati, come se volessero gettarsi su di lei, come il suo falco sulla preda. Per questo aveva cominciato a coprirsi il più possibile, mortificando il suo corpo di giovane donna sotto abiti di foggia maschile.
Per l’occasione invece indossava un morbido abito di lana color nocciola, impreziosito da una bordura in velluto marrone scuro allo scollo e da lacci della stessa stoffa alle maniche. A ripararla dal freddo pensava un pesante mantello fermato con una vistosa spilla d’argento.
Avrebbe preferito vestire la solita pratica ed informe tunica e soprattutto non andare a quell’appuntamento, ma si rendeva conto che i suoi desideri non contavano nulla contro la volontà paterna. Se non si fosse maritata per lei non ci sarebbe stata che la monacazione. Su questo il padre era stato molto chiaro ed il Reichenberg, collerico, di modi imperiosi e di eccezionale vigore fisico, non era uomo che ci si potesse azzardare a contraddire.
I tre, attraversata un’estesa foresta di larici ed abeti senza scambiare parola, completamente indifferenti anche al paesaggio che ora s’apriva in un’ampia vallata con prati che si alternavano a campi coltivati, sembrarono riscuotersi all’ingresso di un villaggio dove un gruppo di bambini cenciosi si stava accanendo contro una donna condannata alla berlina. Inutilmente quest’ultima, trattenuta da un collare di ferro assicurato ad una robusta catena, cercava di sottrarsi al lancio di ossa e ortaggi marci.
Il signore di Tarasp fu il primo a passare oltre mentre i ragazzini esultavano per un colpo andato perfettamente a segno.
Arrivati a Zernez il nipote chiese di potersi riposare ma non ottenne nessuna risposta. Il Reichenberg, per la verità, neppure aveva udito la debole richiesta dell’imbelle nipote.
La sua mente era concentrata unicamente sul contratto matrimoniale che si stava recando a stipulare. Poco gli importava dei sentimenti, dei desideri della figlia, molto invece della dote che il futuro marito avrebbe pagato in cambio del trasferimento di potestà.
La caparbietà della fanciulla invero gli forniva qualche motivo di preoccupazione; non poteva e non doveva permettere a quest’ultima di rovinare i suoi piani, in gioco, infatti, c’erano le sue terre e il suo castello, sui quali aveva messo da tempo gli occhi il vescovo di Coira.
Inutilmente per avere appoggi s’era rivolto al nobile Ulrico dei conti di Tures e di Tirolo che pure nei pressi di Tarasp aveva campi, boschi, prati e forni da difendere contro le mire del prelato.
Il conte aveva trovato mille pretesti per rimandare un intervento forte e deciso preferendo un’azione diplomatica grazie all’intervento della di lui sorella, la badessa Ildegarda.
Il Reichenberg temeva pertanto che, presto o tardi, il vescovo l’avrebbe spuntata. Quest’ultimo, infatti, possedeva in buona parte dell’Alta e della Bassa Engadina diritti signorili, tanto è vero che già dal 1140 aveva la prerogativa di amministrare l’alta e la bassa giustizia, anche se non sempre disponeva di possessi fondiari.
Poiché però non aveva la possibilità di esercitare direttamente i suoi diritti in una valle alpestre così lontana dalla sede episcopale, aveva conferito a Pompejus Planta, già da parecchi anni, oltre al diritto di cancelleria anche la carica di ministeriale, ovvero di giudice e intendente, che permetteva a quest’ultimo di amministrare le terre del vescovo ed esercitare la bassa giustizia, di trattare cioè le cause civili di minor importanza.
Il Planta, dal canto suo, sperava che il vescovo si impegnasse a non nominare balivi al di fuori della sua famiglia, in una parola aspirava a conquistare il balivato ereditario.
Imparentarsi con il Planta avrebbe presentato dunque evidenti vantaggi. Quand’anche il vescovo fosse riuscito nel suo intento, l’amministrazione dei suoi beni e delle sue terre sarebbe rimasta in famiglia.
La stanchezza intanto cominciava a farsi sentire. Giunti a S-Chanf il Reichenberg autorizzò una sosta presso l’ospizio di San Nicolao dove i tre, sotto l’occhio vigile e curioso di un frate predicatore, si scrollarono la polvere di dosso e fecero abbeverare i cavalli. Il signore di Tarasp anche appiedato torreggiava in modo impressionante.
Ripreso il cammino, non molto tempo dopo avvistarono la torre di Zuoz.
L’alto edificio in pietra era collegato, con un arco sovrastante la via, all’abitazione del Planta, una casa di imponenti dimensioni che comunicava una sensazione di solidità a causa dei muri spessi e della dimensione ridotta delle finestre.
Lasciati i cavalli ad un inserviente che li avviò verso le stalle, i tre, superato un poderoso portone arcuato, entrarono in un ampio ingresso coperto, una sorta di anticamera dove andò loro incontro un servitore che li accompagnò al primo piano della casa. Su un largo corridoio si affacciava la stüa, una grande stanza completamente foderata in legno, odorosa di resina e riscaldata grazie ad una stufa in muratura. Qui il notaio, che svolgeva per lo più il suo lavoro in quella stanza dell’abitazione, seduto ad un tavolo massiccio ed ingombro di pergamene, era intento a redigere la stesura di un atto presso una finestra che pur non essendo tanto grande riusciva però a catturare tutta la luce possibile grazie alla profonda strombatura.
Al loro ingresso si alzò subito in piedi, anche se con visibile fatica e, abbracciato il Reichenberg, cerimoniosamente diede loro il benvenuto. Poi, indicando un uomo né giovane, né vecchio, di corporatura molto robusta e occhi mobilissimi come quelli di un falco, che prima sedeva accanto a lui ed ora attendeva in piedi, disse: “Vi presento il mio prezioso collaboratore Adelberto che mi aiuta nel compito di mantenere sicura, contra malefactores e ruberie, la strada fino all’Alpe del lago di sopra, dove iniziano le terre del signore di Bregaglia che, come ben sapete, risiede a Vicosoprano”.
“Vedete cara Matildina”, aggiunse poi il notaio rivolgendosi direttamente alla ragazza che se ne stava con gli occhi bassi, compiaciuto per la sua sottomissione, quantomeno apparente, nonché affascinato dalla sua prorompente giovinezza, “anche da noi non mancano saccheggi e furti e c‘è pure chi, adducendo i pretesti più assurdi, ha l’ardire di rifiutarsi di pagare la decima sul grano o quella in agnelli dovuta al nostro vescovo”.
Matilde sentendosi appellata alzò lo sguardo incurante del sorriso e dell’occhiata colma di lascivia che le stava rivolgendo l’aiutante del notaio. Se ne accorse invece il Reichenberg che strinse i pugni già pronto a montare in collera, sennonché il padrone di casa continuò: “Non è forse vero Adelberto che c‘è chi ruba persino le rape?”
“Sì, purtroppo quanto dite è la verità, ma quel tale non potrà più farlo. Ci ha pensato il Castelmur a fargli perdere il vizio. Lo hanno impiccato davanti alla torre rotonda di Vicosprano ed i lupi, scesi nottetempo dai monti, hanno fatto scempio del suo corpo dopo averlo tirato fuori dalla terra fresca della sepoltura ed averlo trascinato per un tratto nella radura di Cudin fin verso il torrente”.
Un brivido di raccapriccio, a quelle parole, percorse il corpo di Matilde mentre gli occhi del debole Joanne si riempirono di lacrime.
L’uomo, intimamente compiaciuto per le reazioni suscitate, avrebbe certamente continuato se non fosse stato per il padrone di casa che, zittendolo con un’occhiata in tralice, interloquì: “Oggi però è una giornata fortunata, abbiamo, infatti, potuto registrare la donazione di un’alpe e di alcuni servi a favore del nostro amato vescovo e al valico dell’Albula abbiamo…”
A quel punto il notaio, accortosi dell’arrivo del proprio figliolo, si interruppe per invitarlo ad entrare. Sulla soglia della stüa, infatti, il giovanissimo Dedalrico, smorto ed allampanato, sembrava esitare come intimidito.
Il Planta, che in cuor suo non vedeva l’ora di dare lettura al contratto, disse allora con un largo sorriso rivolgendosi al Reichenbeg: “Ebbene, ho l’onore di domandare per mio figlio Dedalrico la mano della vostra deliziosa figliola”.
Quest’ultimo, che a sua volta aveva atteso impazientemente quel momento, si accostò a Matilde, di nuovo con la testa bassa e lo sguardo ostinatamente fisso al pavimento, le strinse con forza il braccio a ricordarle la doverosa ubbidienza e rispose: “Sono compiaciuto e spero che le nozze possano avere luogo al più presto!”
In breve, pronunciate le frasi di rito, avuto il consenso dei due giovani e avvenuto lo scambio degli anelli, i due padri si strinsero la mano, dopodiché il notaio si accinse a registrare l’atto abbreviando le formule ripetitive per concludere ancora più in fretta l’ultima fase di un contratto vantaggioso per entrambe le famiglie. Quando tutto fu sistemato, date, dote, titoli e firme dei testimoni, il Reichenberg ed il notaio finalmente si rilassarono e quest’ultimo, visibilmente soddisfatto, andò a stringere le mani dei due giovani.
“Ho una sorpresa in serbo per voi”, disse pensando ad una promessa del vescovo, “sarà il mio regalo per le vostre nozze. Adesso però andiamo a brindare”.
Nella locanda di proprietà dell’importante prelato, piena di fumo e di trofei di caccia, il vino, generosamente offerto anche agli avventori presenti, che volentieri tralasciarono il gioco dei dadi cui erano intenti per brindare ai due giovani, rese euforici tutti all’infuori di Matilde che si sentiva come quel povero orso tenuto al laccio nella piazza vicino alla torre e costretto a ballare al suono di un tamburello.


