
Ultima corsadiMarco Finco |
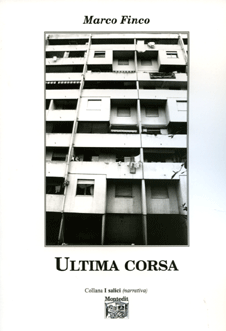
Collana "I Salici" - I libri di Narrativa
14x20,5 - pp. 162 - Euro 11,30
ISBN 978-88-6037-5582
Clicca qui per acquistare questo libro
In copertina: fotografia di Diego Landi
All’interno fotografie di Diego Landi e Marco Finco
Prefazione
Un misterioso numero di codice è il pretesto che utilizza Marco Finco per creare e sviluppare un romanzo intrigante ed avvincente, fino ad una scena finale pervasa da un autentico alone enigmatico, che lascia aperte le più contraddittorie interpretazioni da parte del lettore. La trama segue un ritmo incalzante, non lascia respiro, non ammette distrazioni, sempre ammantando le scene e le riflessioni interiori che ciclicamente si rigenerano nel susseguirsi degli eventi.
Il codice numerico, come un grimaldello, serve per penetrare all’interno d’una storia ai limiti del surreale: inizia come un silenzioso presagio, senza motivazioni plausibili, senza conferme, senza riscontri nella realtà; poi diventa un’evidenza visibile d’una probabile soluzione, quindi un enigma demoniaco da far perdere la ragione e, infine, un incubo dal quale salvarsi.
Marco Finco, con abilità e precisione, utilizza un linguaggio sintetico e ridotto ai minimi termini: le parole sono passate al setaccio, spolpate d’ogni orpello, rese taglienti nella loro fulminea descrizione d’immagini o stati d’animo. In questo romanzo non si ritrovano elucubrazioni esistenziali o filosofiche e nemmeno oceaniche riflessioni ma solamente sferzanti passaggi, brevi e gustosi riferimenti che rendono il racconto assai godibile dalla prima all’ultima pagina.
Il richiamo costante al codice numerico si tramuta in un segreto che non è ancora svelato, in una decriptazione giacente nella mente: tutt’intorno si ritrovano atmosfere rarefatte, situazioni quotidiane del grigiore metropolitano, ambienti fumosi e luoghi insondabili. Quasi in dissolvenza, tra un nuovo evento ed un ulteriore presagio, si snodano, come a concatenarsi in un diabolico intreccio, una serie di decifrazioni mentali, di pseudo investigazioni, d’improbabili indizi e surreali elementi. In alcune pagine si avverte chiaramente la sensazione della perdita prima ancora d’un incontro, la condizione esistenziale di persone che non condividono la vita insieme eppure fanno di tutto per giungere ad una salvazione comune: il misterioso codice numerico diventa un ponte tra un imminente pericolo da evitare e una via di salvezza. L’occasione speculativa della narrazione apre la porta del tempo alle innumerevoli verità: le microstorie conducono ad un’espansione, a molteplici visioni, alle numerose possibilità d’incontro tra persone che non si sono neanche sfiorate eppure sono attratte da un’energia vagante che si percepisce nitidamente nonostante la narrazione si svolga in luoghi pervasi da decadenza, da anonima ambientazione post industriale.
L’intelligenza diventa maestra di vita, permette di trovare la soluzione giusta senza perdere tempo: le memorie storiche d’un archivio diventano le porte della conoscenza che si aprono, una dopo l’altra, come ad entrare in un dedalo di stanze fino ad avvicinarsi alla salvezza. La verità si costruisce lentamente, poco alla volta: è fondamentale cogliere i dettagli, esaminare attentamente la realtà e l’archivio memoriale.
Si può sicuramente affermare che, nel romanzo “Ultima corsa”, Marco Finco alimenta una tensione continua, tra imminenza di chissà quale drammatico evento e sorprendente rivelazione, in uno stato d’incombente drammaticità e di raffinata ossessione narrativa, offrendo una prova della sua capacità nel dirigere un’inquietante orchestrazione.
Massimo Barile
Ultima corsa
Capitolo primo – lui
Da che parte cominciare?
11763016. Aveva sempre in mente quel codice. Non sapeva più cosa fosse. Non riusciva a spiegarsi perché si fosse impresso così deciso nella sua memoria. Tra tutti i ricordi più cari da mai dimenticare, tra tutte le nozioni importanti, una cosa così stupida: un numero. Dopo tanto ragionare e spremersi di meningi ci aveva messo una bella pietra sopra e si era lasciato guidare dall’istinto. Aveva provato al bancomat, facendosi inghiottire la scheda. Aveva tentato un acquisto come carta di credito via internet. Un bel vestito blu scuro in lino per fare un figurone a matrimoni e riunioni importanti. Ma terminata la procedura telematica, seccato, aveva dovuto rimandare l’acquisto. Carta bloccata. Non funziona. «Riprovi un altro giorno, buona sera».
Aveva cercato al telefono con vari prefissi: forse era una data scritta in un modo particolare? Forse un codice cifrato con lettere da associare ai numeri? Non ci dormiva la notte. Come gli era venuto in mente questo numero ora neppure lo ricordava: era capitato. Tempo fa: prima qualche cifra, poi tutto il numero si era snocciolato davanti ai suoi occhi.
Cifra dopo cifra, come un richiamo da lontano, come un segreto a lui noto da tempo ma non ancora interiorizzato. Ora il suo inconscio faceva riaffiorare questo numero senza dargli troppe altre spiegazioni. Il numero di morti in una guerra? Troppi. Il numero di ammalati di AIDS nel mondo? Piuttosto! Ma perché dovevano essere proprio dei morti? Non poteva piuttosto essere collegato a qualcosa di più allegro e solare? Guardandosi attorno però faceva fatica a convincersi. Come un silenzioso presagio, ma senza alcuna conferma, sentiva in questo baco della memoria un collegamento con qualcosa per niente buono.
Tutto filò nel mistero per qualche mese finché una mattina, seduto assonnato sull’autobus che lo portava a lavoro, scorse con estrema meraviglia proprio quel numero: scritto con lo spray a colorare un grande murales su una casa in demolizione, a due passi dalla prossima fermata. Senza pensarci due volte si era precipitato alla porta automatica ed era sceso all’ultimo momento, cadendo quasi addosso alla signora con il sacco della spesa che già si allontanava dal mezzo maledicendo i giovani e la loro fretta. Una fretta da far dare i numeri. Neppure il tempo di chiedere scusa e l’autobus era già ripartito, la donna dileguata.
Capitolo primo – lei
Domenica in tuta
11763016. Samantha le aveva scritto queste cifre sul retro del porta-cerini senza spiegarle tanti perché. Chiama questo numero domenica mattina e ti diranno dove andare. E così lei fece. Le rispose una voce molto sbrigativa: «Via Santa Maria Assunta civico 5, sopra un orto frutta: facile da trovare. Ore nove: vedi di non essere in ritardo». La città di domenica mattina era deserta: solo qualche gruppo di temerari mattinieri che sgranchiva i muscoli correndo lungo l’argine del fiume che abbracciava il centro. Trovò la via senza fatica: l’autista dell’autobus fu molto gentile nel spiegarle a che fermata scendere e che strada prendere per raggiungere prima il posto. «Un orto frutta di domenica signorina? Oggi è chiuso… che ci va a fare? Preparate la vetrina di Natale? Oppure un buon preparato misto già pronto per minestroni?»
Per raggiungere il civico giusto non ci volle tanta fatica: a metà della via scorse un folto assembramento di ragazze vestite su per giù tutte come lei. Tutte con la propria sacca sportiva a tracolla. Molte erano vestite in modo pratico, con la tuta sotto il cappotto. Altre un po’ più eleganti. Raggiunse il gruppo di soppiatto e subito si accorse di non conoscere nessuno. Samantha non c’era: era stata lì troppe volte e questa volta proprio non se l’era sentita. Forse ne aveva ormai abbastanza.
La situazione era imbarazzante. Nessuna sembrava conoscere l’altra, nessuna sembrava intenzionata a voler avvicinare le nuove compagne. Guardavano a terra, intimidite. Oppure all’orizzonte, nella direzione della fermata dell’autobus che la sera le avrebbe riportate a casa. Il cielo grigio e cupo, il silenzio delle prime ore della domenica, il freddo pungente che colorava di rosso i loro visi poco truccati, sottolineava l’imbarazzo e la solitudine. Strano, perché di lì a poco avrebbero dovuto diventare molto intime. Molto amiche. Molto spregiudicate. Molto esperte. Ma nessuna di loro aveva voglia di tirar fuori i propri assi dalla manica prima del tempo. Ognuna voleva gustarsi ancora quel silenzio e quel pudore, che ben presto sarebbe stato oltraggiato.
La maggior parte delle nuove compagne di quella mattina erano ragazze dell’est: bionde, magre, viso slavato. Inquiete fumavano stringendo il braccio sotto l’altra manica, mordendosi le labbra nervosamente guardando verso il cielo. Sembrava avessero fretta. Ma non c’era da aver fretta. Avrebbero passato tutta la giornata in quell’appartamento sopra l’orto frutta.
Lei ancora non lo sospettava. La notte prima Samantha le aveva spiegato tutto con grande fretta ed entusiasmo, in un sorriso nervoso stretto tra le labbra, quasi le avesse illustrato un gioco.
Ancora non aveva capito nulla. Guardava le altre ragazze tutte come possibili concorrenti. Se il posto di lavoro in ballo è uno solo qui siamo già in troppe. Non c‘è da fidarsi di nessuna. Non c‘è da fare troppo la gentile. Ognuna per sé.
Fredda attesa in silenzio, tra mille dubbi e domande. I soliti misteri di Samantha: anche di domenica mi faccio intrappolare dalle sue proposte da discoteca. Colpa della musica alta o dell’aperitivo?
Il silenzio si fa sempre più inquietante: le pare quasi di risentire le parole dell’amica mentre sghignazza facendo l’occhiolino a Jessika.
L’attesa sembra non terminare mai ma così non sarà. Presto ogni dubbio sarà svelato. Presto arriveranno i fotografi, gli attori. Il calore dei neon riscalderà per ore i loro corpi, e forse anche i loro animi.
Il cielo grigio e basso sarebbe rimasto per lunghe ore all’esterno a cullare la città avvolta e annoiata nella sua fredda domenica d’inverno fuori dai caldi salotti. Come una coperta grigia avrebbe protetto il loro calore e sottolineato l’assenza di stupore e gioia dei loro giochi.
Sì... ma quanti giochi? Capendo finalmente la situazione, chiusa la porta del caldo appartamento alle sue spalle, accompagnata insieme alle altre nello spogliatoio, non potendo più tirarsi indietro, maledicendo le promesse della discoteca, un numero spregiudicato le verrà così in mente e le farà strozzare un amaro sorriso: 11763016.
Capitolo secondo – lui
Palazzi e nubi
11763016. Sembrava quasi un effetto ottico. Per riconoscere veramente quel numero bisognava concentrarsi per davvero. Il murales rappresentava la vista di un insieme sterminato di grattacieli, osservati dall’alto. Pochi colori: grigio, nero ed un giallo fluorescente. Il punto di vista della rappresentazione era curioso: sicuramente si trattava di un panorama rubato durante un improbabile volo aereo o dalla sommità di una torre ancora più alta delle altre, molto facilmente una molto simile a quella in cui lavorava lui ormai da troppi anni. L’effetto d’insieme, infatti, non era molto diverso da quello che si gustava dal suo ufficio nelle pause caffè, quando voleva riposare lo sguardo da interminabili ore di computer. Sopra quei palazzi adesso correvano nubi basse: sembrava di sentirle davvero sopra la testa. Nubi di settembre: bianche, piccole e veloci. Trascinate dai primi venti freddi che giungono all’improvviso a raggelare la schiena, quasi a ricordare l’ormai prossima fine dell’estate. Nubi bizzarre e rade.
Allora si ricordò di tutte le volte che aveva sentito soffiare il vento in quel modo. Di come, in quei momenti, volgendo lo sguardo, poteva seguire le ombre muoversi a terra: vederle lentamente accarezzare e inghiottire auto, tram, parchi, stazioni, alberi, panchine, fontane, parcheggi, supermercati. Ora, in quel murales, quelle nubi correvano proprio su quei grattacieli, mettendo in ombra solo i più alti. I palazzi erano disposti in modo caotico: in questo modo le macchie scure proiettate dalle ombre creavano sul cemento forme diverse, a seconda delle altezze delle sommità dei tetti. Non ci mise molto a riconoscere, tra queste cifre, un sette, un sei. E via via tutti gli altri numeri. Forse era perché li aveva già in testa da tempo. O forse li stava osservando adesso per la prima volta. La mente gli faceva brutti scherzi. Difficile alle volte gli era diventato riconoscere con certezza l’esatta concatenazione degli eventi. Rimase fermo davanti al grigio variopinto di quel muro. Respirò profondamente a pieni polmoni per rilassare e distendere i pensieri: per un attimo gli parve per davvero di sentire il brivido del vento di settembre, che intanto spazzava le nubi dal suo murales. Cazzo! Ora era anche in ritardo per il lavoro. E chi aveva più voglia di andarci? Allora, che fare? Prendere un autobus o farsela a piedi? Chiarirsi le idee e sgranchire le gambe gli avrebbe fatto sicuramente bene, anche se era lunga. Sì, ma quanto lunga? Quanti passi ci sarebbero voluti? Si voltò prima a sinistra in direzione di casa, poi a destra nella direzione in cui l’autobus aveva proseguito. La risposta già la sapeva e sorrise turbato: 11763016.
Capitolo secondo – lei
Fumo
11763016. Oltre al numero, sul biglietto, non c’era altro. Nessun nome, nessun riferimento. Mettendo il portafoglio in ordine saltò fuori così. E come tutte le volte che le succedeva di trovare qualcosa che non capiva, ci rollò dentro un po’ di tabacco e si accese la sigaretta. Il fumo allora l’avvolgeva nei suoi pensieri liberandola ancora meglio da quegli stinti ricordi. Come poteva dimenticare tutto così facilmente? Come poteva sempre rimanerle solo il nulla di uno sbiadito passato?
Come gli anelli di fumo che ora le uscivano dalla bocca, tutta la sua vita sembrava dissolversi nell’aria della sua stanza, ormai piena di fumo. Denso e preciso, lasciava le sue labbra, prendendo forme solide che si libravano sicure nello spazio. Allora rimaneva ferma incantata, osservando le nuvole allontanarsi. Quando capitava che le sembrassero troppo vere per essere fatte solo di fumo, provava allora a stringerle con la mano, quasi per fermarle. Ma tutte le volte, con il solo colpo d’aria provocato dal movimento della mano, giochi ed animali scomparivano al suo avvicinarsi, cancellando in un attimo gli ultimi sogni fatti di vapore e nicotina. Ricadeva allora sul letto, ammutolita e sconfitta. Allora stringeva a sé la mano per controllare cosa ci fosse rimasto dentro. Nella sorpresa e nella delusione di sempre, le era triste constatare solo l’olezzo di fumo vecchio.
Era dura da accettare ma ora era proprio così: tutto sembrava sfuggirle di mano e dal corpo. Una rinuncia non decisa, una sconfitta ad una lotta mai affrontata.
Spesso ricordava le fiabe che suo padre le raccontava da bambina. Seduta sulle grandi ginocchia sul letto della sua camera, in attesa della cena. Fuori il buio, l’oscurità. Dentro le parole rassicuranti ed i primi profumi che arrivavano dalle pentole dell’altra stanza. Al lume dell’abat-jour, i colori delle pagine prendevano vita. Conigli, principesse, fatine, incantesimi saltavano fuori dalla carta profumata e le giravano attorno. Quel silenzio fatto solo di parole e gioia, quell’attesa per la cena, il canto spensierato di mamma ai fornelli, quei preziosi attimi le avevano lasciato un segno indelebile. E così aveva pensato che tutta la vita avrebbe potuto essere sempre così: un incantesimo.
Un mondo stupendo da scoprire l’avrebbe aspettata, avvolto dalla magia, dal fascino, dalla possibilità di un incessante divenire, colmo di gioia.
Per quanto tempo ha inseguito orsetti e funghi parlanti? Scesa dalle braccia del padre, uscita di casa sbattendo la porta, non aveva poi più saputo distinguere le figure giuste, le strade buone, i profumi delle cene in vera allegria, la curiosità di un inizio e la gioia per un finale di una bella storia.
Troppo presto. Era accaduto tutto troppo presto. Troppo per capire che non era ancora sicura e pronta. Ma il tempo insegna, quando è già passato. Anche la superbia, con il tempo si trasforma come tutto il resto in fumo e cenere. Nulla più.
Ora gnomi e cavalli alati continuano a venirla a trovare come da piccola, ma solo nell’intimità delle sue fumate solitarie.
Fuori dalle sue corse per strada, fuori dai pianti, dai ceffoni, dai conati di vomito, dai graffi, dallo sballo. Fuori da un mondo ben diverso che ora, troppo spesso, la attende fuori dalla porta. Non per scelta, ma per non aver saputo distinguere le ginocchia giuste su cui sedersi. Non per vizio, ma per non aver saputo attendere la cena giusta, alle volte. Non è servito uno sbaglio continuo. Ne è bastato qualcuno. Pochi, in verità: ma importanti.
Tornare indietro è possibile? Dipende. Dipende dall’orgoglio e dal rimorso. Lei lo sa. Lo ha capito! Come nasconderlo a se stessa? Ma cosa sarà a pesare di più? È un pensiero costante, una logorante attesa. L’uno cerca di cancellare il peso dell’altro, anche se lei sa benissimo che la strada giusta sta nel mezzo, ma come fare per imboccarla? L’incantesimo allora potrebbe tornare come se ne è andato: da un momento all’altro. Basterebbe solo saper dare il giusto peso ad entrambi.
Anche il fumo ha un peso. Le sembra strano a guardarlo così come ora è, libero ed indistinto nella stanza. Ma ripensando a cosa l’ha generato, al tabacco sminuzzato, al biglietto sapientemente arrotolato, alla saliva per legare i lembi, non le ci vuole poi un grande calcolo per determinarne il peso. Forse vale lo stesso anche per i suoi sbagli e il suo orgoglio. Per pesarli bisognerebbe saper ricostruire cosa li ha generati. Solo tornando all’origine, forse, è possibile riuscire a trovare il giusto punto di vista.
Distesa sul suo letto, quando nella stanza il fumo diventa solo una cappa grigia indistinta, dissolti i sogni di fate e maghi con i loro incantesimi, ancora una volta cerca nella memoria il giorno preciso del suo passato che ha determinato la svolta.
Un’adolescenza intera passata con la sigaretta in bocca. Unica compagna davvero inseparabile. Ognuna così scontata eppure ognuna così importante ed opportuna. Quante ne erano passate, dalla prima? Quale quella sbagliata? Un conto davvero complicato. I giorni, le notti, i viaggi, i patti, le sconfitte, le bugie della sua vita le sono davanti agli occhi uno dopo l’altro e il calcolo diventa di colpo rapido ed inevitabile: 11763016.
Capitolo terzo – lui
La grande città
Ripensava al numero dell’autobus che aveva lasciato allontanarsi. Poteva ancora scorgerlo in lontananza in fondo al viale, fermo al semaforo dello svincolo autostradale.
Quanto grande avrebbe dovuto essere la città per avere un numero di linee così elevato? Tutti quegli autobus insieme, quanti chilometri avrebbero potuto coprire ogni giorno? Considerando un percorso medio per ogni linea di una ventina di chilometri, le distanze da coprire gli sembrarono incredibili. Come poteva essere successo tutto questo? Potevano le linee pubbliche di tutte le città del mondo, messe una dopo l’altra, raggiungere un numero così elevato? No: forse non bastavano ancora.
La città quella mattina gli pareva più congestionata del solito. Colonne immense di auto tossicchiavano fumanti ferme ai semafori di lunghi viali, sotto un susseguirsi a perdita d’occhio di alti palazzi moderni. Forse per il ritardo accumulato, forse per la brusca discesa alla fermata sbagliata, si ritrovò in un angolo di città che faceva fatica a riconoscere. Eppure ci passava davanti ogni giorno da anni, seduto al suo solito posto in autobus. Così distratto o così attento al suo giornale da non aver mai notato la profonda trasformazione in atto.
Gli parve allora di intuire. Le linee si erano moltiplicate come ragnatele, intrecciandosi le une sulle altre. Appiccicate alle città d’origine, si erano spinte fuori dai grattacieli e dal caos a cercare nuovi territori dove altri uomini avevano cercato posto per vivere. Spazi di luce, sole e quiete. Spazi di silenzi, verde e dolcezza. Ma non era bastato. Le fughe non sono mai state abbastanza rapide. Le città, lentamente ma inesorabilmente, si erano espanse dietro di loro, inghiottendo sobborghi, periferie, campagne. Tutto alla fine si era trasformato in metropoli. Poi in megalopoli. E poi non era ancora bastato. Come tante macchie d’olio le immense periferie si erano allargate all’infinito, sino ad incontrarsi tra loro, fino a diventare la zona esterna di un’unica grande città. Un’unica metropoli che ora copriva il mondo intero.
«Quando si parla di globalizzazione…» Ora a lui questa parola faceva sorridere. Gli autobus ora correvano su tutta la terra, senza uscire mai dall’unico grande centro abitato. Con un unico biglietto urbano, saltando da un autobus all’altro, finalmente ora era possibile girare il mondo intero.
Ripensava ai suoi amici perduti e nascosti in città. Come fare a ritrovarsi? Troppa fretta, troppo lavoro, troppe corse. «Non sono più padrone nemmeno del mio tempo. Devo darci un taglio. Devo riprendermi i miei spazi. Riappropriarmi delle mie idee. Riprendermi i miei sogni. Altrimenti finisce che non capisco più neppure quello che cercano di farmi vedere».
Il terrore di essersi perso anche lui, quella mattina lo prese alla gola: i grandi palazzi grigi del centro direzionale lungo la sua via erano diventati di colpo tutti uguali. L’unico modo infallibile per non perdersi, era ricordarne il civico: poco altro ora permetteva di distinguere una costruzione dall’altra, purtroppo. E come dimenticare un numero del genere? Tirò un respiro di sollievo, alzando gli occhi verso il tabellone luminoso, appena riconosciuto. Rallentò il passo per lasciare alla porta automatica il tempo di aprirsi di fronte a lui. Anche gli ingressi erano ormai tutti uguali. Ma il civico del palazzo era quello giusto: 11763016.
Capitolo terzo – lei
Pasti caldi
11763016. Non uno di più, non uno di meno. Era esattamente questo il suo totale di pasti serviti. Ora che rovesciava le sedie sopra i tavoli per passare il pavimento per l’ultima volta non le sembrava ancora vero. C’era voluta quasi una vita intera. Ma era volata tutta così: in un attimo. Minestre, pastasciutte, bistecche, insalatone. Volti arrossati, tute puzzolenti, scie di sudore intriso dell’olio delle macchine, complimenti per il pasto. Apprezzamenti al suo corpo mai troppo pertinenti.
Si fermò un instante a fianco del tavolo dei condimenti, accese una sigaretta ed aspirò la prima tirata a pieni polmoni, per riprendere fiato. Altro che aria pura: era sempre quel fumo denso a farla sentir meglio! Molto meglio. Era quella l’anima della grande fabbrica. Era quello il suo fascino. Un potente magnete che aveva attirato paesi interi dalle campagne attorno per risucchiare loro la vita. Ma non la felicità. Non l’illusione di potersene andare, forse un giorno.
La fabbrica silenziosa ora era lì: ormai a ridosso della città. Su di lei vegliava, anche nel cuore della notte, con le sue alte torce luminose. Sempre pronta ad accarezzarla con sogni di sviluppo e benessere ma allo stesso momento, in un attimo di rabbia, a vomitarci sopra i propri veleni. Ormai legate indissolubilmente l’una all’altra, fino a diventare un tutt’uno, fino a confonderne le strade e gli odori.
Eccola là fuori la fabbrica: madre ed origine della stessa città, delle sue scuole, delle sue vie, delle sue piazze, dei suoi mercati. La fabbrica che adesso faceva paura e doveva andarsene via. La fabbrica che aveva già dato e, anche se stanca, continuava a dare da mangiare a migliaia di persone, a paesi interi.
Ora, in questo preciso momento, tra fabbrica e città, il grande gesto del dar un pasto a paesi interi, passava proprio per mezzo delle sue mani. Un lavoro nobile: pesante, duro, ma altamente umano. Sfamare gli affamati. Assicurare il pane quotidiano a tutti: nessuno escluso.
Lei la fabbrica non l’aveva mai vista dal di dentro. Ammirata e spiata dalla grande mensa della portineria numero tre, l’aveva immaginata nelle tante attese del primo turno di operai delle undici e mezza. I lavoratori e le macchine erano dentro le mura. Il suo lavoro, i suoi piatti, fuori. Uno scambio nello stesso luogo non era mai stato possibile.
Nonostante quel muro invalicabile, aveva comunque imparato a conoscerla ed amarla dai discorsi dei commensali, nel breve tragitto del vassoio lungo lo scivolo del bancone del self-service.
Le imprecazioni degli operai, le preoccupazioni dipinte sui volti di dirigenti e quadri. Tra un piatto di lasagne ed una minestra con i broccoli, lei spiava i loro volti e immaginava colloqui che le sciogliessero i cancelli di quel mondo. “Allora, oggi come è andata? Ci sono problemi sugli impianti? Il mercato richiede ancora i nostri prodotti? Vanno ancora forte, vero? Le autorità cosa dicono degli ultimi incidenti? E la popolazione? Tutto bene allora per il futuro? Possiamo contarci, vero?”
Bestemmie sempre più cattive. Solchi sui volti sempre più profondi. No: non doveva andare tanto bene. Ma quanto sarebbe durata la crisi? Perché si trattava solo di una crisi temporanea… vero? Allora mangiate e ritempratevi dai vostri sforzi: domani la fabbrica saprà far di meglio. Guardatemi le cosce sotto il grembiule, spiatemi il petto mentre vi allungo il primo sul vassoio, desideratemi più di un piatto di maccheroni al ragù, ma poi fate i bravi e tornate dentro quelle mura a produrre: io ho bisogno di voi, del vostro lavoro, come voi avete bisogno di me. Io vi desidero come voi fate con me. È uno scambio, un tutt’uno ancora come è sempre stato da decenni: fabbrica e città.
Ma poi, un giorno, la fabbrica, molto stanca e troppo tradita, si voltò da un’altra parte e la grande mensa tre rimase vuota. Le sue lunghe tavolate animate per anni da rumorose squadre di montatori sempre affamati e festosi come ad una sagra, i tavolini delle impiegate amministrative sempre più magre e costantemente a dieta, la lunga coda, impaziente ma ordinata, in attesa della distribuzione del pasto quotidiano: tutto questo sacro rituale, che per lei era lentamente diventato il suo universo, di colpo svanì. Un mondo che aveva preso il volo in un solo momento. Cambio di accampamento: le sembrava di vedere le grandi tribù di indiani d’America smontare le tende e mettersi in viaggio in cerca di praterie più promettenti, ricche di grosse mandrie di bisonti per carni e pelli. Rimanevano qui l’immensa sala a piastrelle rosse, i tavoli di formica ed uno strano profumo di broccoli assorbito irrimediabilmente nei muri. In tutti quegli anni insieme alle colleghe non erano ancora riuscite a trovare un prodotto per eliminarlo.
Mentre passava lo straccio insieme alle compagne di lavoro per l’ultima volta pensava a quante volte avevano giocato con gli spazzettoni aspettando la clientela, improvvisando corse di lavaggio del pavimento correndo tra i tavoli. Scherzi e gioie d’altri tempi. L’accampamento ora andava lasciato. Risciacquare i grandi pentoloni per l’ultima volta. Staccare il gas, chiudere l’acqua, spegnere i frigoriferi. L’immensa cucina era ancora buona e funzionante, pronta per una nuova vita, per un efficiente servizio. Ma a chi sarebbe potuto tornare utile tutto questo?
Chiuso il portone con il doppio catenaccio lanciò un ultimo sguardo alla portineria tre. Era sempre lì di fronte: deserta, ma ancora coperta di bandiere rosse dei sindacati. Un rapido ricordo le strinse il cuore: erano le stesse bandiere che aveva visto il primo giorno che era capitata lì in cerca di lavoro, dieci anni prima. Quasi per caso si era fermata lì davanti, sulla curva della portineria tre, per ritirare il modulo per fare domanda. Le avevano fatto compilare dei questionari e le avevano detto di ripassare.
“E quelle bandiere? Ci sono problemi? È sicuro lavorare qui?” aveva chiesto impaurita.
“Nulla è più sicuro qui, bambola, ma ci farai presto l’abitudine: è il bello di lavorare in petrolchimico. E poi quelle bandiere sono sempre fuori come monito ai padroni: per ricordar loro la minaccia del potere operaio”.
Ma il potere operaio aveva ora voltato la faccia alla portineria tre, ai suoi pasti caldi, storico successo anch’esso di infinite lotte sindacali degli anni Settanta. Bandiere rosse e simboli dei diritti acquisiti lasciati abbandonati, sulla curva della portineria tre. Come è stata possibile una fuga così rapida e silenziosa? Come è stato possibile lasciarsi dietro sul terreno i propri simboli e i propri vessilli? Distrazione o calcolo? Forse nessuno dei due: sulla curva della portineria oggi incombeva il progetto di una nuova arteria per la città: era quella oggi a rappresentare veramente la speranza e il miraggio della gente.
Ecco un’altra stupenda mattinata di settembre: di quelle in cui l’aria è così nitida che ti sembra di toccare con una mano le montagne azzurre all’orizzonte. Si indirizzò verso il suo motorino, parcheggiato dall’altra parte del sottopasso del curvone della tre, a fianco del binario morto dello scalo ferroviario. Quante volte aveva attraversato quel tunnel? Ricordava tutti i cartelloni sindacali di volta in volta affissi, le epigrafi dei pensionati mancati proprio soli pochi giorni dopo la fine del lavoro: “sindrome da mancanza di lavoro” la chiamavano per scherzo. Per scherzo poi si diceva anche che questo lavoro facesse male. Ricordava le corse nel sottopasso degli operai che euforici correvano in mensa per appropriarsi delle porzioni migliori. Come era potuta sparire tutta quella gioia?
Speranze, delusioni, fatiche, incidenti e anche morte: era quella la vita che aveva imparato a conoscere. Come avrebbe fatto ora senza tutto questo? Sbucò fuori dall’altra parte del sottopasso, proprio sotto le bandiere rosse. Issate sopra l’ingresso, sventolavano ancora al vento con i loro colori ormai sbiaditi. La portineria era sprangata. Alte erbe crescevano di fronte coprendo le spoglie stanzine delle guardie e i tornelli di timbratura dei cartellini. Come aveva fatto a farsi imbrogliare così? Come aveva fatto a credere che tutto sarebbe stato infinito? Perché non aveva ascoltato il messaggio di quelle bandiere del suo primo giorno di lavoro?
Sganciò il casco e liberò il blocca sterzo. Che importanza aveva adesso porsi tutte queste domande? Alla fine cosa avrebbe potuto darle più gioia al mondo? Meglio esserci stata, anche se non per sempre. Chiuse gli occhi e le parve ancora di ricordare tutti i volti di quei pasti. Gli stessi volti, ma sempre diversi giorno dopo giorno, pensiero dopo pensiero. Nel rivedere tutti quei visi ora non si sentiva più sola. A ripensarci non erano proprio pochi: ma un popolo intero.


