
Il riscattodiVittoria Mura |
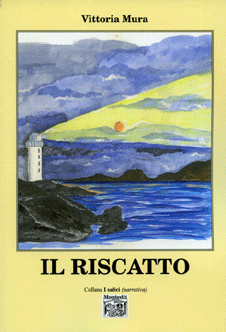
Collana "I Salici" - I libri di Narrativa
14x20,5 - pp. 154 - Euro 11,80
ISBN 978-88-6587-2741
Clicca qui per acquistare questo libro
In copertina illustrazione di Fernanda Stagnari
Fatti, personaggi e luoghi che appaiono in questo libro sono di pura fantasia. Ogni riferimento a persone esistenti o esistite e a fatti reali è da ritenersi puramente casuale.
PREFAZIONE
Questo libro è lo sviluppo di Verso la libertà di Vittoria Mura apparso nel 2005. Allora l’Autrice aveva presentato alcuni personaggi e situazioni fermandosi ai soli cenni. Ora ce li ripresenta con dovizie di particolari e si preoccupa di ampliare lo scenario, aggiungendo alcuni capitoli nei quali sviluppa il percorso investigativo della protagonista alla ricerca continua dei genitori negati e alla fine trovati, ma non accettati perché altro è il desiderio dell’acquisizione nominale dei genitori altro è invece il vissuto educativo parentale che ogni individuo si porta dentro ed implicitamente ne riconosce l’autorità e l’identità filiale.
Sonia, personaggio principale e parallelo, di cui l’Autrice racconta la vita e nella quale riversa il proprio vissuto, si muove all’interno di un istituto che dovrebbe essere dedicato all’infanzia abbandonata, ma che in realtà è un cronicario dove individui non autosufficienti vengono messi a contatto con i bambini e dove tutti, grandi e piccoli, vengono privati delle cure più idonee al loro stato.
Con dovizie di particolari, la Mura segue la protagonista nei vari stadi della sua esistenza: bambina, adolescente e quando ventunenne conoscerà il giovane soldato che la sposerà e la porterà fuori dall’ambiente in cui ha vissuto. La segue nel percorso spazio-temporale che dovrà attraversare fuori dall’istituto e che per lei sarà ben diverso da quello sognato, chiamandola a superare nuove difficoltà. Saranno difficoltà di adattamento, ma principalmente saranno difficoltà di discernimento perché la mancanza di termini di confronto porta la giovane Sonia a valutazioni oggettive errate e si troverà sul punto di dover rimpiangere proprio quell’istituto prima ripudiato e ora desiderato come luogo in cui veniva garantita la protezione che sente di mancarle.
Il percorso investigativo di Sonia, alla ricerca dei suoi genitori naturali, la porta a scoprire il degrado ambientale, ma principalmente morale, nei suoi molteplici aspetti che colpisce sia i bassifondi della città sia le strutture protette entro le quali ai bambini non viene dato esempio di serenità, di lealtà e di giustizia. Ambienti questi nei quali l’età evolutiva viene ignorata e il risultato sarà inevitabilmente quello di preparare dei giovani incapaci di autodeterminarsi e di cedere davanti alle prime difficoltà. Giovani donne che appena messe di fronte alla vita di relazione, fuori dalla struttura nella quale sono state allevate, si troveranno allo sbaraglio, vittime dello scarto educazionale esistente con quello di una qualsiasi famiglia normale. Questo sarà il prodotto di quelle strutture dedicate all’infanzia, che nel secolo scorso ha generato disadattati con problemi psichici molto seri. Alla fine ne viene fuori il racconto di una donna segnata inesorabilmente dagli eventi, ma che nonostante tutto ha saputo trovare oltre alle sue radici genealogiche, anche la motivazione per dedicarsi agli altri sia nell’ambito della famiglia sia nell’ambito lavorativo.
Sappiamo che in Italia non esistono più strutture per l’infanzia come quella descritta dalla Mura, ma questo libro vuole essere portatore di insegnamenti, e in modo particolare di ammonimenti, affinché la nascita di un bambino sia prima di tutto, per le madri e per chi vi sta vicino, un evento gioioso e non un gravoso problema da risolvere. Vuole sollecitare la presa di coscienza che tutti i soprusi di cui un bambino sarà fatto oggetto, saranno elementi che gli impediranno un futuro vivere sereno e principalmente lo porteranno ad un’esecrabile solitudine interiore e ripulsa nei confronti dei suoi simili. Per converso, tutte le cure e l’amore che ogni individuo riceverà nell’infanzia sarà la chiave del suo successo da adulto e gli permetterà di accettare ed amare il mondo che lo circonda.
Benedetto Di Pietro
Il riscatto
Occhi tristi
Ho visto troppi occhi tristi
senza luce.
Ho sentito troppe grida di terrore
che nell’aria facevan tremare
anche le foglie.
Era lo stesso dolore
mio e dei miei fratelli di sventura
abbandonati negli istituti.
Questo è il mio e il loro dolore,
voglio trasformarlo nei colori più belli
con i canti degli usignoli
perché questi ricordi sempre
io mi porto dentro.
Vittoria
1.
COME SI NASCE CRONICI
Ancora prima della sua nascita il destino tramava contro di lei e le preparava una strada pietrosa: un’erta difficoltosa ed aspra che avrebbe affrontata da sola. Sonia era stata messa in Istituto che aveva pochi mesi e ne sarebbe uscita a ventidue anni. L’Istituto si chiamava Casa Divina Provvidenza Cronici Derelitti, ma per la gente di Sassari era semplicemente “i Cronici”. Quando i bambini andavano alle processioni o ai funerali, diligentemente allineati dietro il gagliardetto di Sant’Agnese e tutti con la divisa, le persone per strada li fermavano per chiedere loro di che istituto erano. Erano uomini e donne con sguardi rapaci e modi bruschi. Alle loro secche domande i bambini rispondevano «Casa Divina Provvidenza!», ma quelli non capivano e insistevano chiedendo: «E dove si trova?» Allora i bambini rispondevano: «i Cronici». Solo così capivano e per tutti erano solo i Cronici. Ai bambini la parola “cronici” non piaceva, aveva qualcosa dentro di dolente, di tragico. Non ne conoscevano bene il senso, ma li turbava e cercavano di evitarla, invano.
Sonia, ora adulta, capisce che nella parola, riferita a loro bambini, c’era una contraddizione: come si poteva essere cronici a pochi mesi o pochi anni? Come si poteva avere formulata su di loro una tale definitiva diagnosi? Forse gli abitanti della città trovavano più rapido e più semplice definirli così. Del lungo ed altisonante nome dell’Istituto era rimasto quel breve termine che lo caratterizzava e distingueva da altre istituzioni con le quali condivideva altri termini come “casa” o “provvidenza”.
Il fondatore dell’Istituto era stato un prete, un certo padre Manzella. Ma Sonia non ne è sicura che lo sia stato, perché ai bambini era negata anche la conoscenza della storia e non veniva narrata la circostanza di come l’Istituto fosse nato. Bisognava solo ringraziare padre Manzella. Nell’atrio della chiesa era posto in bella vista un suo ritratto, in cui appariva arcigno e freddo, e non si può escludere che la posa e l’atteggiamento seguissero uno schema tipico delle iconografie dell’epoca. Certo è che a Sonia non piaceva. Ancor più le pesava dovere sempre genuflettersi quando passava davanti a quel cupo ritratto. Era un atto dovuto a perpetuo ringraziamento per aver fondato la Casa Divina Provvidenza. Non capiva che cosa avesse fatto di buono nel costituire quello ed altri istituti simili che si trovavano nella città.
Padre Manzella era di origine lombarda, ma aveva operato in Sardegna. La sua fondazione ripercorreva le linee guida di Giuseppe Cotolengo e, come queste volevano, si trattava di creare strutture chiuse, che tendevano a nascondere per proteggere, ma anche per isolare ed impedire il contatto con il territorio. Padre Manzella aveva fondato anche l’ordine delle suore manzelliane per operare con i più derelitti della società umana.
La Casa Divina Provvidenza era affidata alle suore di San Vincenzo de’ Paoli, le suore dal gigantesco cappello bianco, del quale andavano fiere e dal quale dovettero separarsi a fatica, nonostante fosse scomodo ed anacronistico: timore di cambiamento, vanità o perdita di un’identità visiva ben marcata e chiara? Sonia ricorda che le udì più volte singhiozzare a calde lacrime dopo la notizia del cambio del loro abito. Nel 1964 l’ordine decise, infatti, di eliminare gli incredibili cappelli e di accorciare e semplificare l’abito. Il papa Paolo VI aveva espressamente invitato la Superiora generale delle Figlie della Carità a semplificare l’abito tradizionale che era una tunica blu scuro con una pettorina bianca che spuntava dallo scapolare e contrastava con il saio. La caratteristica più visibile era il grande cappello candido appoggiato sopra la cuffia bianca.
Il famoso copricapo richiedeva un lungo rituale di pulizia e preparazione. Era un rettangolo di tela lungo circa un metro e largo una quarantina di centimetri. Quando si doveva fare l’ultimo risciacquo, bisognava dare una leggera colorazione di azzurro. Si prendeva una pallina di una sostanza blu e veniva immersa più volte nell’acqua fino a far colorare leggermente i teli che dopo questo trattamento venivano immersi in acqua con amido. Così inamidati si facevano asciugare al sole appoggiati su plance di metallo. Alla fine risultavano dei teli duri che poi le suore modellavano dando la forma dei cappelli tipici.
Quel copricapo a larghe tese, veniva detto anche cornetta e all’inizio fu adottato per conformarsi alle contadine attorno a Parigi, della Piccardia e del Poitou. Poi divenne sempre più ampio ed inamidato. Il nome della Compagnia deriva, infatti, dalle Dame della Carità istituite da San Vincenzo de’ Paoli. Le “fraternità” si diffusero nelle aree rurali della Francia e nel 1630 le Dame vennero affidate alla direzione di Luisa di Marillac. All’inizio vestivano l’abito secolare, poi passarono allo stile delle contadine, con cappello e saio grigio. Successivi cambiamenti nel tempo confermarono l’ampio cappello usato come elemento identitario, ma anche per tenere lontani i contatti con gli altri. Dopo il 1964 si passò ad un abito blu scuro, più corto, e fu abolita la cornetta.
La cosa che ora sorprende Sonia, nella storia dell’ordine, è l’origine semplice e povera: San Vincenzo non voleva che avessero abito, cappelle e beni. Ancora più sorprendente è che le sue reverende suore forse non sapevano che la stessa Luisa di Marillac nacque in circostanze misteriose. Venne riconosciuta dal padre come “figlia naturale” per evitare uno scandalo, correndo voce che la vera paternità fosse attribuita ad uno dei suoi fratelli. Così Sonia, ora adulta, vorrebbe dire a quelle suore che per anni le sono state vicine: «Carissime, anche la vostra Luisa era una ‘bastarda’ come me!»
Per Sonia, le suore restarono a lungo degli esseri misteriosi, privilegiati, potenti ed insieme crudeli. Anche molti anni dopo la sua uscita dall’Istituto e dalla loro tutela, le ha temute e guardate come divinità prive di ogni espressione lieta, da rispettarsi con timore e tremore. Aveva anche desiderato di diventare una di loro, naturalmente le fu sempre negato. Non era legittimata, era figlia del peccato; solo se avesse trovato un padre avrebbe potuto aspirare a tale privilegio. Quando le chiedevano perché volesse farsi suora rispondeva, con tono risentito, che le suore mangiavano bene e lei non aveva mai cibo abbastanza. La miseria e lo squallore rendono gli animi bassi e tristi. La povertà e la scarsità di beni elementari possono essere più tollerate in famiglie con genitori che lottano quotidianamente per sfamare i loro figli con i quali sono pronti a condividere tutto; al contrario diventano intollerabili quando vengono imposte da chi è ben pasciuto e ben nutrito e commina ad altri digiuni indesiderati e senza un apparente motivo. Una delle motivazioni più segrete e profonde che faceva desiderare a Sonia di diventare una di loro era la speranza di poter assumere un’identità forte, che le mancava, e inoltre l’idea di poter vivere ed interpretare il ruolo di potere in modo più umano.
Sonia lavorava spesso in cucina e vedeva arrivare grandi quantità di derrate alimentari: frutta, verdura, carne e uova. Le suore dicevano: «È arrivata la Provvidenza!». L’espressione è bella e piacevole, ma non era condivisa tale provvidenza. La ragazza non vedeva nulla di tutto quel bendiddio arrivare sulla tavola sua e delle sue compagne; le buone cose approdate in Istituto finivano sulla tavola delle suore. Vedeva giungere grandi ceste di fichi d’India, che doveva ripulire dalle spine, ferendosi le mani. Se osava lamentarsi, la risposta era che doveva pensare alle sofferenze di Cristo in croce, a confronto delle quali i suoi dolori erano poca cosa. Lo stesso rituale avveniva col taglio di enormi quantità di cipolle che le provocavano il pianto. Le veniva detto, con tono duro ed aspro, che piangeva sui suoi peccati e poteva ritenersi fortunata di farlo, doveva espiare le sue e le altrui colpe. L’allusione alle colpe di sua madre non era velata. Era poco più di una bambina e non poteva mai assaggiare quelle leccornie, che finivano sistematicamente sulla tavola delle suore, degli ospiti privilegiati, dei pensionati paganti e dei parenti delle suore.
L’Istituto dove visse Sonia era in realtà un insieme di bambini, di vecchi e malati. Non era solo un orfanotrofio, era anche una scuola, un ospizio ed un pensionato. Era tanto vasto che ai suoi occhi appariva come un paese, completo di tutto. Per molto tempo aveva creduto che fosse l’universo completo insieme con la città di Sassari. Non pensava esistesse altro. La struttura di tutto si presentava come un insieme di palazzotti, uno accostato all’altro, senza una precisa armonia d’insieme. A ogni palazzo corrispondeva un portone, tutti si affacciavano in via Sant’Agostino o in via delle Conce, che terminava in piazza Sant’Agostino. Dall’altro lato c’era un ospedale militare. Le finestre del ricovero anziani davano proprio verso quelle dei militari e dovevano restare sempre chiuse per evitare che quelli, affacciandosi, vedessero le ragazze, le quali quando lavoravano nei cameroni degli anziani, non potevano cedere alle richieste dei vecchi ospiti di avere un po’ d’aria fresca nella calura estiva. Il problema principale era quello di non essere viste e guardate dai militari di fronte.
I palazzi che davano sulle vie erano suddivisi in scuole, pensionato e ospizio. Sul retro c’erano gli orti, in cui veniva coltivato di tutto, nello spirito di autosufficienza che governava la casa. L’area dell’orto comprendeva anche la porcilaia, un luogo per Sonia denso di paure e di fantasie angoscianti. Spesso veniva inviata in quella zona a cercare qualche ortaggio, necessario per le cucine, e incontrava l’ortolano “zio Paolo”, un uomo minuto asciutto e quasi senza tempo. Sonia si aggirava tra le zolle e le piantine basse alla ricerca di qualcosa, mentre l’uomo le preparava i mazzetti di verdure ed erbe aromatiche di cui aveva bisogno. Può sembrare ridicolo e assurdo, in primo luogo alla stessa Sonia, ma stava cercando i bambini piccoli. Li immaginava nascosti tra i cavoli, come si raccontava in un passato recente, che pare già così lontano. Qualche volta lo esplicitava all’ortolano, che restava senza parole a sentirle dire che non trovava i bambini, lì nell’orto. L’uomo non osava ridere dell’ingenuità della ragazza, né aveva il coraggio di spiegarglielo. Nella sua mente, già di giovane donna, alloggiavano convinzioni arcaiche e mondi diversi da quelli pensati dagli altri e da quelli ritenuti oggi “scientifici”. Se le fosse stato possibile disegnare il “tutto” con una sua cosmogonia, avrebbe messo l’Istituto al centro, con orti e cortili, attorno avrebbe raffigurato quel poco di mondo che conosceva solo come vago contorno. In una circonferenza più ampia avrebbe posto il mare, contenitore indefinito. In questo universo piatto e limitato, l’orto sarebbe stato il ventre da cui venivano i piccoli bimbi che crescevano nell’istituto.
A Sonia non fu negato di frequentare la scuola; avrebbe dovuto conoscere ed ampliare le sue idee sul mondo, ma ciò non avvenne. La sua frequentazione scolastica fu sempre da ultima e da emarginata. Ora Sonia si domanda come abbia potuto imparare a leggere e a scrivere in una tale situazione: non aveva un suo quaderno, non veniva mai interpellata, sentiva echeggiare termini strani come “equivalenze”, “Nord”, “Sud”, che per lei restavano misteri. I bambini frequentavano la scuola che c’era all’interno dell’Istituto. A quei tempi l’obbligo scolastico arrivava fino alla quinta elementare, così toccò anche a Sonia. Qualcuno di quei bambini continuava a studiare, ma si trattava di privilegiati e il privilegio consisteva nell’avere la mamma che s’interessava a lui o di essere stato riconosciuto alla nascita, cioè legittimato. Rientravano nella categoria privilegiata anche i parenti delle suore.
All’interno del gruppo dei bambini c’erano caste e classi sociali, che godevano di privilegi o favori secondo il grado di appartenenza. La stratificazione era complessa e spesso Sonia se ne rendeva conto nell’avere più o meno diritto di accedere ad un cibo migliore. In primo luogo c’era la classe più elevata, composta da coloro che avevano i genitori ancora in vita e si trovavano lì perché parenti di una religiosa o perché meritevoli di qualche favore. Si trattava di una cerchia ristretta e per loro l’Istituto era una specie di collegio di buon livello, in cui raccoglievano la conferma della loro identità attraverso i continui rinforzi che le suore davano loro. Venivano poi gli orfani legittimati, parola per Sonia allora sconosciuta nel suo significato reale, ma molto importante per il senso che aveva lì in termini di distribuzione di cibo, attenzioni e vantaggi. L’ultimo gradino della scala sociale era occupato dai non legittimati, in pratica i figli di padre sconosciuto. C’erano anche i “trovatelli”, ma la loro condizione era superiore alla precedente, per loro non era chiaro il peccato materno e su di loro si stendeva una pietà che li rendeva fragili e meritevoli di compassione. Sonia apparteneva alla classe dei non legittimati e così, fra l’altro, non aveva diritto a continuare gli studi. Forse le suore pensavano che con lei fosse tempo sprecato.
A Sonia piaceva tanto studiare, specie le poesie, ne aveva una vera passione. La musicalità del linguaggio poetico, la sua semplicità e la scelta di bellezza e di attenzione di cui si sentiva investita, gliele rendeva gradite. Ricorda ancora una poesia che studiò nelle prime classi elementari, ha dimenticato l’autore, ma il testo le è rimasto impresso. Si intitolava “Il primo giorno di scuola” e recitava così:
«Un dì mi ci portarono e mi lasciarono là,
come un meschino passero che ancor volar non sa.
Vociavano e ridevano i bimbi attorno a me,
io cominciai a piangere senza sapere il perché.
Una bambina piccola, lesta si avvicinò,
avea una mela ruggine e disse: – Ne vuoi un po’?
E me la diede a mordere finché non ce ne fu più.
Poi mi asciugò le lacrime ed io non piansi più.»
Per Sonia, l’ingenua poesiola era ed è simbolica. Per tanto tempo si è sentita anch’essa come un meschino passero. Anch’essa avrebbe voluto trovare qualcuno che le desse attenzioni e le offrisse una condivisione. Non ha mai sentito quest’aiuto, non ha mai percepito la presenza di una calda amicizia o di una vicinanza capace di aiutarla. L’abbandono e il vuoto affettivo della sua prima infanzia sono stati una voragine che nessuna “mela ruggine” poteva riempire ed ha sempre percepito che nessuno si è mai impegnato ad asciugare il suo pianto solitario. In classe era posta sempre lateralmente, in fondo. Se cercava di intervenire e di proporsi per recitare una poesia o ripetere una lezione veniva subito azzittita: «Taci tu, che sei balbuziente!».
Una delle sue prime manifestazioni di disagio riguardava la parola. La rabbia repressa, la frustrazione continua e l’assenza di attenzioni avevano colpito la sua capacità di parlare. Insisteva moltissimo per poter intervenire in classe o per poter ripetere le poesie, che apprendeva con facilità, le bastava leggerle un paio di volte per poi saperle a memoria. Una sola volta la maestra le concesse, dopo le sue continue insistenze, di recitare una poesia. Ma tanta fu l’ansia che non riuscì a dire che poche sillabe: la voce le usciva spezzata e a singulti. L’insegnante l’interruppe subito, ripetendo la solita filastrocca: «Vedi, non riesci, sei balbuziente! T’interrogherò dopo che ti sarai messa dei sassolini in bocca, come Demostene». Sonia non era in grado di cogliere il dotto riferimento e neanche l’ironia nascosti dietro le parole della maestra. Nella sua incredibile ingenuità la bambina cercò realmente i sassolini, ma le mancava allora l’energia psicologica per lavorare su di sé in qualsiasi modo e per credere in un suo miglioramento. L’essere figlia illegittima, riconosciuta solo dalla madre, ha condannato la bambina al biasimo e ad ogni sorta di violenza, psichica e fisica, lasciandole nell’animo l’ombra cupa del pessimismo esistenziale.
2.
I GENITORI NEGATI
Sonia era nata nell’aprile del 1945 e lasciata in istituto a pochi mesi. Era il giorno di Pasqua, ma non per lei. Sua madre Maria fu costretta ad abbandonarla; all’epoca avere un figlio illegittimo era un vero scandalo e comportava un’immediata ed esemplare punizione, una sorta di ostracismo. Sua madre fu cacciata via da casa incinta, per “salvare l’onore”. Così la partorì a Sassari. Qui la suora del reparto la invitò già da subito ad affidarla ai “Cronici” e le procurò una madrina per la piccola, un’inserviente che lavorava lì, ma viveva ad Ossi, suo paese d’origine. La mamma non poteva tenere la bambina con sé e per il suo compagno era stata solo un’avventura, così la donna si ritrovò sola.
Sonia da bambina non sapeva nulla di tutto questo, non sapeva né di lei, né di suo padre. In seguito, faticosamente, ha ripercorso quei primi eventi della sua esistenza; ha effettuato, quasi da sola, una ricostruzione di tutto quanto si riferiva alla sua vita e alle persone coinvolte in essa. Sua madre apparteneva ad una famiglia povera e segnata da numerosi lutti; insieme alle sue sorelle andava a lavorare da un proprietario di un terreno come raccoglitrice di frutta o con altre mansioni straordinarie di cui nel podere avevano bisogno. Suo padre Giovanni era il figlio del padrone e non fu per lui difficile circuirla e possederla. Sonia non sa come le cose siano andate tra loro agli inizi, ma vorrebbe sperare che almeno ci sia stata una certa dose di tenerezza e di passione. Non ne ha raccolta memoria alcuna da parte di suo padre. Sua madre successivamente le raccontò che aveva amato quell’uomo, anzi era stato il suo vero primo amore. I due giovani non erano degli adolescenti quando concepirono Sonia, per il loro ambiente e per l’epoca si trattava di giovani già in grado di badare a se stessi. Sua madre aveva ventiquattro anni e il padre ventidue.
Le informazioni di Sonia risalgono già a quando la madre non sapeva come gestire l’esistenza della bambina e tentava di evitarle i “Cronici”. È pietoso il suo disperato tentativo di non inviarla in un brefotrofio; la sua incapacità di reggere la situazione da sola la mostra fragile e vittima di una realtà rigida e arcaica, che la circondava e la portava inevitabilmente al compiersi del suo destino. Maria portò la bambina dalla nonna paterna, tenendola in braccio e, come in un romanzo di Carolina Invernizio, supplicandola di prendersi cura di lei perché era figlia di suo figlio Giovanni. Proprio come in un racconto ottocentesco s’inginocchiò pregandola di prenderla. Ma la madre di Sonia venne scacciata con una buona dose d’insulti: «Bagascia! Puttana! Vattene via con la tua bastarda e non dire in giro che è figlia di mio figlio Giovanni! Non mi hai chiesto il permesso prima di coricarti con mio figlio!»
Lo sapeva, la mamma di Giovanni? Voleva lavarsene le mani? Riteneva che un figlio illegittimo non avesse alcun diritto? Preferiva non vedere e non capire? Rappresentava l’espressione del suo mondo e della sua realtà, forse non poteva agire diversamente.
Nel percorso del ritorno, la donna attraversò un torrente e le venne la tentazione di gettarvi dentro la piccola Sonia, ma la bambina si mise a piangere e il suo pianto la commosse. Così la riportò a casa, affidandola a sua madre, e se ne andò a Sassari per cercare lavoro come domestica.
In casa della nonna la situazione era pesante e difficile: c’erano già parecchi bambini di cui la donna doveva occuparsi. Erano i nipotini rimasti orfani chi di madre e chi di padre. Vittoria, una zia della piccola Sonia, era morta a ventisei anni lasciando due piccoli, uno di due anni e l’altro di sei mesi. La donna aveva tentato di far sposare una delle altre sue figlie al vedovo, ma questa si rifiutò. C’era poi un’altra bambina, orfana di padre, che le era affidata perché la madre doveva lavorare.
Gavina era la madrina di battesimo di Sonia e viveva ad Ossi. Un giorno andò a trovare la piccola e la vide in uno stato di totale abbandono: sporca, ricoperta di mosche, lasciata tra pochi stracci. Gavina aveva tenuto Sonia a battesimo che aveva avuto luogo nello stesso giorno della sua nascita. Chi nasceva nel peccato necessitava di un immediato battesimo allo scopo di purificare quello stato. La donna lavorava come lavandaia in ospedale e fu scelta dalla suora addetta alla cappella del nosocomio che sapeva di essere dello stesso paese della madre di Sonia. Gavina ogni tanto andava a vedere come stava la bambina, anche su suggerimento della suora dell’ospedale, così un giorno qualcuno prese la decisione di portare Sonia in un istituto di Sassari. Cercarono di evitare di consegnarla ai “Cronici”, ma pareva non ci fosse altra soluzione. Era come se tutto spingesse perché Sonia precipitasse lì, in quella realtà che avrebbe costruito la sua gabbia e il suo limite.
Sonia ha un ricordo molto vago di quei primi anni di istituto e di sua madre. Il ricordo della madre si amplifica con quello che di lei le è rimasto impresso dopo, quando la ricercò per capire e per ricostruire faticosamente la sua storia e con essa la sua identità. La vedeva molto di rado, non provava per lei alcun affetto e la madre non faceva nulla per meritarlo. Da parte sua, Sonia da sola non sarebbe riuscita ad operare una simile impresa emozionale. I primi ricordi che ha della madre risalgono a quando, seppur raramente, questa la veniva a trovare nell’istituto, accompagnata ogni volta da un uomo diverso. Suor Francesca prima di mandarla in parlatorio le imponeva con tono severo ed allarmato: «Non baciare quell’uomo! Non è tuo padre.» Per Sonia la parola padre era strana e priva di senso; cos’era un padre? In un mondo dominato dalle suore e dove la presenza maschile era quasi assente, non aveva senso un padre. Non capiva neppure la connessione tra essere figli legittimati ed avere un padre. D’altra parte l’esigenza di un padre è comparsa molti anni dopo, quando da altri le venne fatta la richiesta di averne uno e di conoscerlo. All’epoca della sua infanzia per lei contava di più la figura della madre, che si presentava nella saletta del parlatorio con aria insieme aggressiva e dolente. Quella donna le portava in dono un dolce e la costringeva a mangiarlo: Sonia avrebbe preferito condividerlo con le sue amiche per poi lasciare un po’ di briciole per le formiche, altre sue compagne mute della solitudine affollata della sua vita infantile e giovanile. Era sola, seppure circondata sempre da altri individui per lei estranei e lontani.
Il dolcetto era tondo, rigonfio, formato da due metà ricoperte da una glassa rosata disseminata di zuccherini. Il primo gesto che Sonia compiva, dopo che la madre glielo porgeva, era di infilarselo in tasca. La madre protestava e la obbligava a mangiarlo davanti al suo sguardo di rapace ferito, forse temeva che glielo avrebbero portato via; vedeva la bambina denutrita e dar cibo è uno dei più naturali ed arcaici gesti materni. Allora Sonia non conosceva il nome di quel dolcetto che avrebbe dovuto intuire poiché somiglia al frutto di cui porta il nome: la pesca. L’avrebbe scoperto molti anni dopo. Nella sua infanzia era il dolce che le portava la mamma, denso di sapore, caramelloso e zuccherino. Il suo forte potere energetico doveva compensare la sua fame di mamma che si portava dentro. Mangiarlo sotto occhi indagatori e acuti della madre era più un obbligo che un piacere. Era un imporsi di un’assenza troppo sofferta, tramutata in rabbia.
Durante le sue visite, la madre domandava a Sonia perché non parlasse; le chiedeva: «Ti trovi bene?» La bambina non rispondeva, teneva la testa bassa, mangiava il dolcetto a bocconi piccoli e lenti, senza potersi esprimere, né aprirsi alla madre, per lei ancora più nemica di chi la circondava di consueto. La sua difficoltà di parola diveniva con la presenza della madre mutismo, oppositivo e difensivo. Una delle ultime volte che Maria andò a trovare Sonia, l’incontro fu differente dagli altri; infatti, giunse con un’altra donna che indossava il costume tradizionale sardo, che alla bambina sembrò la Madonna. Sua madre vestiva sempre abiti comuni, quindi Sonia non aveva mai potuto osservare i tradizionali vestiti regionali, lunghi, ornati ed ingioiellati. I costumi regionali sardi sono caratterizzati dalla gran quantità di gioielli che li adornano, tanto che i gioielli sono strutturalmente legati al costume. Il significato di tali gioielli è antichissimo: si racconta che le fate ne avessero fatto dono alle donne per renderle più forti e capaci di reggere le avversità. Bottoni, gemelli, pendenti, orecchini, amuleti, catene, collane, spille ed anelli adornano i coloratissimi costumi. La donna che Sonia aveva di fronte indossava un abito in cui predominava il colore rosso, aveva un velo sul capo tenuto fermo da un lungo spillo con una capocchia a forma di sferetta di corallo. Un’altra spilla, a forma di girasole, le chiudeva sul petto il corpetto. Le numerose collane erano distribuite in modo da essere in bella mostra e di rivelare i loro pendagli: piastrine a forma di farfalla, a fiocco, minuscole perle. La parte davanti del costume era poi ornata da due bottoni “mammillari” in oro posti nei due lati del busto. Gli orecchini erano di corallo lavorato a goccia fasciato da un cerchietto in oro nel quale era fissato lo spillo da inserire nel lobo. Le sue mani, scurite dal sole, ma ancora belle, erano adornate da tre anelli, quelli consentiti alle donne maritate, uno di questi riproduceva sulla fascetta due manine strette in atto di fede, il classico anello che il fidanzato dona alla futura sposa, ricevendone in cambio un prezioso coltello, anch’esso ornato e lavorato.
La signora, così straordinariamente vestita e ornata, rivolse la parola alla bambina, chiamandola per nome e le chiese:
«Sonia, perché non parli?… Come ti trovi?… Ti trattano male?… Ti picchiano?…»
La piccola non rispondeva. Dentro di sé la parola si bloccava come strozzata da un legaccio profondo ed oscuro. Se avesse potuto parlare avrebbe urlato, la sua voce si sarebbe trasformata in una furia di uragano, ne avrebbe avuto paura lei stessa per prima, ma avrebbe potuto urlare quello che dentro le premeva come una pietra: «Portatemi via da qui!». La settimana prima di quell’incontro le suore le avevano bruciato una natica con il ferro da stiro rovente, uno dei loro sistemi educativi. Sonia non rivide più la signora ingioiellata, seppure il suo aspetto le rimase fermo nella mente, e non comprese neppure il senso della sua visita. Non era strano, non le veniva spiegato nulla e non comprendeva il significato di quanto le succedeva intorno, potevano essere gesti, eventi piacevoli o spiacevoli e dolorosi, tutto perdeva il motivo che l’aveva causato. Gli eventi si presentavano con un assurdo susseguirsi di casualità irrazionale e cieca.
Sonia vide per l’ultima volta sua madre verso i dieci anni, quando doveva fare la Cresima. In tale occasione si rendeva necessaria una madrina, alle sue compagne ne era stata data una, scelta dalle suore tra le stesse ospiti dell’istituto, a lei no perché sua madre si era opposta e voleva essere lei a proporla. Così la madre si presentò con una signora che aveva scelto come madrina: si trattava della persona presso la quale era a servizio. La madrina svolse poi un ruolo forte nella vita di Sonia, fu una sorta di surrogato materno, incapace però di rispondere al suo urlo di dolore, ma fu presenza e testimone seppure inefficace.
[continua]


