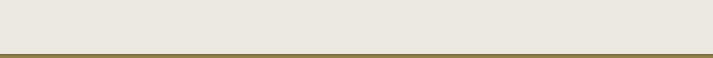|
Homepage personale diSaul Bellow |
Articolo di Massimo Barile – Rivista Il Club degli autori – 153-154-155-156 Ottobre 2005
Saul Bellow: Un uomo in bilico tra sarcasmo e spietata intelligenza
«Vivo per scrivere, scrivo per vivere»: e i conti tornano sempre.
Il fulminante sarcasmo e la sorniona saggezza di Bellow sono in una sua dichiarazione di una decina d’anni fa: «Oggi, quando un giovane decide di fare lo scrittore, per prima cosa sceglie la pettinatura, poi l’abbigliamento e infine quale marca di whisky pubblicizzare».
Saul Bellow è uno scrittore che ha fatto scoppiare il fegato a molte persone con quella tagliente capacità di cogliere i difetti umani e metterli in mostra sul tavolo operatorio di un assatanato chirurgo. Nei suoi romanzi ha sezionato i rapporti umani fino a chiedersi perché persone intelligenti finiscono «immancabilmente per trovarsi nella spazzatura»; ha smembrato i sentimenti senza farsi una ragione del fatto che uomini capaci di «interpretare i misteri della natura» sono costretti a fare la figura dei mentecatti; ha analizzato la tragicomica avventura umana tra amori, matrimoni, separazioni, ossessioni, abbandoni e insulti, senza riuscire a spiegare come mai quando le cose vanno male «come prima cosa si cerca un rimedio di tipo sessuale».
Ne emerge una sola certezza. La vita è servita a Saul Bellow «per scrivere e scrivere gli è servito per vivere». La stesura dei suoi libri ha sempre coinciso con lo stato d’animo o l’incazzamento in alcuni momenti cruciali della sua vita e quel velenoso e sarcastico accanimento è stato forse un mezzo di difesa nei confronti di coloro che considerava ormai dei “nemici” o dei potenziali detrattori.
È stato uno scrittore capace di tutto e soprattutto di scrivere e dire qualunque cosa, anche la più umiliante, come quando gli fu chiesto di recensire un testo del suo ex direttore William Phillips e lui se ne uscì con le testuali parole: «È come fare il sub nelle acque di Coney Island, in mezzo all’urina e ai rifiuti galleggianti».
Nei confronti delle donne si può leggere anche di peggio (nonostante la figlia avuta con la quinta moglie alla soglia di ottant’anni) e la sua coerenza non è mai venuta meno perché ha conservato lo stesso tono sprezzante fino alla fine, d’altronde come tutti sanno e Bellow conferma, le donne «mangiano insalata e bevono sangue umano».
Nei tempi d’oro ad una femminista era riuscito a dire senza finire all’ospedale: «L’unica cosa che potrai mostrare tra dieci anni sarà il tuo seno cadente». Ci vuole del coraggio, bisogna ammetterlo.
D’altronde Bellow non ha mai amato neanche i giornalisti definiti «attori di varietà di terz’ordine», nè i recensori e i critici che spesso hanno stroncato le sue prime opere: alcuni sono stati definiti idioti, altri killer, ad altri ha tolto il saluto per lungo tempo, in un caso ha annullato il contratto con l’editore perché sotto contratto aveva anche un “killer” che s’era espresso con “riserve” su Herzog, un suo capolavoro.
Bellow è nato per fare lo scrittore. Ha sempre avuto il vizio di continuare a riscrivere i testi, fino all’ultima ora, prima di consegnare la stesura definitiva quasi a nascondere con quel comportamento una sorta di difficoltà nel separarsi dalle sue opere come se rappresentassero delle sue creature, quasi fossero assimilabili a dei figli: allevati, curati, accuditi, coccolati, amati. In alcuni casi arrivò a dire «sono distrutto… mi sono ridotto a pezzi, ma sono un tipo che si riprende in fretta». Ad una segretaria, assunta per l’occasione, dettò le pagine di un romanzo componendo a memoria per dieci ore al giorno per sei settimane: «ero arrivato vicino al suicidio» ammetterà.
È stato più volte accusato di una estenuante prolissità, di esser capace di monologhi fluviali, di riflessioni a dir poco oceaniche e, non a caso, i suoi personaggi sono spesso meravigliosi conversatori o grandi denigratori. Si può trovare un’intera pagina sulla felicità e sulla depressione, o magari sulle richieste economiche di una ex moglie, così come su Freud o una sequenza di ordinarie stupidaggini quotidiane. È questo il lato affascinante di Bellow, uno scrittore capace di scrivere che «uno si può divertire un mondo, ma la vita può anche schiacciarci come una lattina vuota» e poi, poco tempo dopo, «ci sono cose che solo un poeta sa dire, sulla poesia» o «dietro alla bellezza delle apparenze è l’inconoscibile» parafrasando Conrad.
Le crisi familiari e i matrimoni in uno stato disastroso, le mogli che distruggevano le automobili, i continui salassi per i divorzi, le liti e gli avvocati, la mancanza di denaro, i difficili rapporti con un ambiente culturale che cercava di isolarlo, avevano un effetto stimolante sulla sua fantasia: «Più disastrosa diventava la mia vita personale, più ne acquistavano in comicità i miei libri». A proposito d’un caro amico che se la faceva di nascosto con sua moglie, dirà alcuni anni dopo: «Sapere e non sapere: una delle strategie umane più frequenti».
Eppure è lo stesso Bellow che sentenziava «tra moglie e marito vigono le regole della guerra …regole nobili, cavalleresche, ma sempre di guerra si tratta».
E poi la colpa era sempre della “donna”, moglie o amica che fosse. Insomma amava farsi passare per il povero scrittore alla mercé degli “umori imprevedibili” e incontrollabili delle donne.
Bellow era un assiduo frequentatore delle aule di tribunale e i messaggi del suo legale facevano paura: «Pare che Susan (la terza moglie di Bellow) voglia far scoppiare la bomba» ... «È piombato un altro meteorite dal cielo» perché l’ex moglie pretendeva di aver contribuito alla carriera letteraria del marito, aiutandolo a riscrivere Herzog e quindi reputava di aver diritto ad una parte dei proventi. Bellow non riteneva di doverle altro denaro oltre all’appartamento con tutti i mobili e agli alimenti concordati nella sentenza di divorzio e nel corso di una furibonda lite le aveva giurato: «Te la farò pagare. Ti spellerò viva. Il tuo nome sarà fango» e mantenne la promessa. Susan è la più nemica, la più bastarda tra le mogli, la Denise «bellicosa e stridula», «non del tutto umana» ne Il dono di Humboldt.
Comunque la causa di divorzio fornì a Bellow la materia per interi capitoli del libro e per alcune tra le sue battute più celebri «La sua foglia di fico si è rivelata un cartellino del prezzo».
Il bisogno di trovare un senso nei fatti casuali e discontinui dell’esistenza era il suo imperativo ed era magistrale nel registrare la sua esistenza con occhio acuto: agli inizi degli anni Settanta «sembrava sapere più cose di qualsiasi altro scrittore americano vivente». Accattivante, arguto, divertente, spregiudicato, oratore esaltante, sempre disposto a misurarsi con i fatti della vita per quanto tristi e incresciosi e non è un caso che se si leggono i suoi libri in ordine cronologico è come leggere una biografia.
Anche dall’analista Bellow si esibiva in “magistrali prove di oratoria”, insomma un paziente affascinante e sfuggente che farà ammettere allo psicoanalista Paul Meehl: «Non ho mai capito fino in fondo che tipo fosse».
D’altronde Bellow aveva una fede incrollabile nel potere della creatività ed era infastidito se qualcuno interferiva nella sorgente della sua ispirazione, convinto che fosse «se non divina, quanto meno inaccessibile alla curiosità degli analisti».
«Lo scopo della vita consiste nel portare il suo fardello, provare vergogna, gustare il sapore di queste lacrime»: e la sofferenza e il tormento avevano una «funzione di redenzione, un antidoto all’illusione, uno sforzo per raggiungere il vero stato di veglia».
Quel contemplare le tribolazioni con distacco, come una sorta di spettatore del suo dramma, quel mettersi alla finestra ed osservare “dal di fuori” le proprie vicissitudini e i fatti del mondo circostante con uno sguardo freddamente distaccato, al di sopra delle passioni quotidiane, del travaglio, dei torti subiti da un uomo assediato da mille problemi, erano le caratteristiche della sua scrittura e qualche volta era riuscito con astuzia persino a imbastire delle situazioni personali per poi studiarle. Costruttore per qualche anno e poi distruttore per rinnovare l’ambiente.
I protagonisti introspettivi dei suoi romanzi, il linguaggio crudo ed efficace, la necessità funambolica con le innumerevoli divagazioni, la complessità del suo stile omnicomprensivo che alternava veri e propri saggi dall’arte, alla politica, alla filosofia, all’antropologia e quel famigerato vizio di spingere gli episodi ai limiti della farsa, dimostravano forse che Bellow «scrivesse a se stesso» come aveva sempre fatto nelle numerosissime lettere indirizzate alle sue conquiste femminili.
IL DONO DI HUMBOLDT
Ne Il dono di Humboldt lo stesso Von Humboldt Fleisher, scrittore d’avanguardia degli anni Trenta, colto, apprezzato poeta, bello, biondo, serio e al contempo spiritoso (insomma un intellettuale capace di grandi conversazioni da salotto che aveva subito un declino pauroso fino a trasformarsi in un uomo “ributtante”, morto in uno squallido albergo dopo aver sofferto di pazzia e aver tentato di alimentare il suo genio, farlo sopravvivere o salvarlo con la droga e con l’alcool): «Aveva creduto di essere un artista divino, un uomo in stato di grazia visionaria, un incantato, un invasato platonico… Desiderava essere magicamente espressivo, d’una eloquenza cosmica, capace di dire qualsiasi cosa; voleva al tempo stesso essere saggio, filosofico, trovare un terreno d’intesa fra scienza e poesia, dimostrare che la fantasia è altrettanto potente della meccanica, liberare e benedire l’umanità» ... «Era corso dietro alla rovina e alla morte con più accanimento che non dietro alle donne. Aveva sciupato il suo talento, la salute, e aveva raggiunto il traguardo della tomba rotolando per una china polverosa. Si era scavato da sé la fossa».
Il concetto era questo: «Con la loro incapacità di vivere in mezzo a noi i poeti giustificano la nostra miserabile esistenza».
Il dono di Humboldt è per Bellow una fatica colossale. Una serie infinita di “inizi”, tre anni per la parte centrale e sei settimane per la parte finale. Ma era soprattutto l’inizio del romanzo che rappresentava il vero problema, pezzi sconnessi, stralci, ripensamenti e nuove versioni si aggiungevano ai manoscritti eliminati o scartati. Per tutto il tempo che scrisse il romanzo si alzò alle sei del mattino, caffè a volontà e poi si metteva a lavorare. La mattina dopo dettava alla dattilografa la ventina di pagine con addosso ancora la vestaglia. Bellow amava avere un gran caos intorno e la confusione era d’obbligo: e poi rispondeva alle telefonate di redattori, agenti e amici. Verso mezzogiorno faceva la pausa, pasto leggero e un bicchiere di vino. Quando si avvicinò alla fine della fatica letteraria era distrutto.
Nonostante tutto si può dire che il romanzo contenga due storie differenti: la prima vede come protagonista Von Humboldt Fleisher che è il poeta geniale, il “campione di sventura”, con la sua parabola discendente; la seconda storia racconta di Charlie Citrine, ricco e scaltro notabile di Chicago, autore di una commedia di successo e personaggio simile al suo creatore.
Ma Il dono di Humboldt è un romanzo di vittime.
Le somiglianze tra i personaggi del libro e gli amici, nemici, mogli, amanti della vita reale di Bellow erano evidenti ma la sovranità assoluta dell’artista non era in discussione. Per Saul Bellow il destino del protagonista Humboldt era emblematico, incarnava l’agonia dell’artista americano. La sua scrittura è espressione del vitalismo e dell’entusiasmo di Bellow in quel momento della sua vita: «sentivo le parole e verso la fine l’ho dettato tutto ad una dattilografa che l’ha trascritto». Il romanzo registra un cambio di stile, la scelta della voce narrante in prima persona, il monologo di Charlie Citrine è tenuto in vita per quasi cinquecento pagine e poi le lunghe elencazioni senza punteggiatura e la costante autoironia sono l’inizio d’una maturità di stile “esuberante e disinvolta”. Bellow fu accusato addirittura di usare il tono spigliato dei notabili di Chicago: colti, presuntuosi e logorroici. Ma il romanzo è una miscela spaventosa di personaggi e avvenimenti impensabili, un mondo di imbroglioni e “professori di realtà” che perseguitano Citrine/Bellow con i loro consigli. In verità l’autentico asse portante del romanzo era la complessità della vita ebraica di Chicago e tutto prendeva vita e pulsava in quella evocazione magistrale con le sale da biliardo e i ristoranti ungheresi, gli psichiatri nelle loro ville, gli speculatori che sudano nella sauna chiacchierando di Acapulco e di conti cifrati alle isole Cayman, senza dimenticare le memorabili scene nelle aule di tribunale per le cause intentate dalla ex moglie.
«È un libro comico sulla morte» così lo aveva definito lo stesso Bellow in un’intervista a Newsweek e il protagonista Charlie Citrine, in definitiva l’alter ego di Bellow, dal suo mondo di certezze e di sicurezza economica, si ritrovava gettato nel marasma di dubbi, rimorsi e preoccupazioni d’ordine quotidiano. La sua vita diventa una miscellanea di eventi assurdi e impensabili, tribolazioni, guai d’ogni genere che nascono come funghi in un sottobosco fertile: l’ex moglie vuole “spolparlo”, l’amante s’industria per intrappolarlo in un nuovo vincolo matrimoniale, il fisco lo insegue per salassarlo, un amico imbroglione gli chiede soldi per imprese assurde, un gangster da quattro soldi, un certo Cantabile, pazzo ed affascinante al contempo, gli fracassa l’auto per un mancato pagamento d’un debito di gioco e, da un lato lo minaccia in continuazione, dall’altro gli propone fantastici affari. E poi c‘è il ricordo inquietante del suo amico Humboldt, il poeta famoso, travolto dal potere e caduto nel vortice della follia fino a morire di miseria, solo e dimenticato da tutti. Citrine per cercare la pace dell’anima decide di mettersi in contatto coi defunti e sogna di continuare l’opera di Humboldt e «scoprire un modo più corretto di pensare alla morte».
Dall’oltretomba Humboldt beffardamente interverrà a mutare ancora una volta il corso degli eventi e la vita dell’amico. Insomma in quelle cinquecento pagine c‘è tutto il mondo e la cultura di Bellow.
Le idee scorrono a getto continuo mentre «l’America s’aspettava da un momento all’altro di vedere sbucare l’Anticristo dai bassifondi», Humboldt finì direttamente all’obitorio e «qui non v’erano cultori di poesia moderna». Le parole di Humboldt diventano profezie «Bramiamo più che mai la radiosa vivace realtà dell’amore infinito, e sempre più gli aridi idoli ce lo vietano», e poi ancora «Se la vita non è ubriacante, non vale niente. O bruci, o marcisci, non si scappa».
Colpi di scena ed esilaranti dialoghi compongono la sostanza delle “occasioni mentali” di Bellow e sono luce che illumina lo scenario, lampi di fulminante sarcasmo, saette di sorniona saggezza, stilettate al cuore di ex mogli, ironia a piene mani e umorismo: tutto è condito con profonde riflessioni, sul valore dell’intellettuale, sul denaro e soprattutto sulla morte. La sua parola è vetriolo, veleno servito con un morbido dolce, eppure «domande ancor più angosciose si rincorrono dietro i suoi occhi». Mettere la società davanti allo specchio, per mostrare le sue incertezze, il senso di crisi, la disperazione.
La fede nella scrittura come missione da parte di Bellow lo conduceva alla convinzione che «gli scrittori dovevano risvegliare la società dal torpore spirituale, rimettendola in contatto con i valori più elevati».
Non era compito facile e le parole scorrevano a fiumi.
A chi accusava Bellow di prolissità rispose Richard Rhodes dalla Chicago Tribune: «The talk is all, and marvelous talk it is» (Il discorso, la chiacchiera, è tutto e, qui, la chiacchiera è meravigliosa).
Al conferimento del Nobel, Saul Bellow rispose ad un giornalista che «si sentiva più che altro confuso» ... «Comincio adesso a padroneggiare il mestiere» ... «Il bambino che è in me è felice; l’adulto scettico». Il Premio non cambiò nulla della sua vita. E continuò ad essere insofferente nei confronti dei critici paragonati ad «accordatori di pianoforte affetti da sordità». E poi, che mestiere era quello di critico letterario? «Io preferirei piuttosto fare il gasista a Chicago».
Non si stancò mai di contemplare quel miracoloso percorso che era la sua vita «dalle camere d’affitto da tre dollari nella fredda metropoli dei ghetti, ai grattacieli con vista sul lago»: ne aveva fatta di strada.
Corrosivo come acido, non smise mai di lanciare bordate e le sue battute taglienti, le sue freddure leggendarie, esagerate, irrispettose, strafottenti, amava considerarle una «forma di possessione demoniaca, un rapimento estatico, divina follia…».
Il suo stile di vita era sempre lo stesso ma gli anni passavano anche per lui. «Eccomi qui, sempre in fuga, in latitanza, per così dire, e un giorno o l’altro ho intenzione di ritirarmi e spero di riuscire a reggere la tranquillità senza cadere a pezzi. Questo è il vero rischio per un uomo».
Le persone d’un certo tipo, presuntuose e critiche per pregiudizio, gli facevano ancora girare le palle ma in un’intervista, pubblicata nel 1990, fece alcune riflessioni sulla vecchiaia: «Prima ero bellicoso. Con l’età, il narcisismo si modifica. Tra dieci o quindici anni sarò morto. Non sarò più qui a piantar grane. Non sarò più qui a difendere la mia cittadella con la spada. Con l’età si diventa più impersonali».
Nel suo rifugio nel Vermont coltivava il giardino, scriveva, faceva passeggiate, ed era ancora abbastanza in gamba da cavare i sassi dal suo terreno. A Bellow piaceva la campagna ed abbelliva la tenuta con tulipani e peonie; non mancava l’amaca sulla quale leggeva Blake e anche cucinare stimolava la sua creatività, i suoi pomodori “erano grossi come palle di dinosauro”. Era orgoglioso e fiero di essere un uomo che sapeva fare un po’ di tutto: curare il giardino, lavare i vetri delle alte finestre in bilico sulla scala, estirpare le erbacce e quant’altro.
Quando, negli anni Novanta, si trasferì a Boston così scrisse John Blades sul Chicago Tribune: «Non c’erano divani in cui sprofondare, nè quadri alle pareti,, soltanto due pezzi di carta incorniciati alla meglio: il National Book Award per Herzog e l’Harold Washington Literary Award. C’erano tre schedari neri, una parete di libri e quattro scatoloni sul tappeto viola consunto. Sembrava l’ufficio di un piccolo investigatore privato». La visione non era certo esaltante. Eppure sull’uomo Bellow scrive: «Mentre beve il tè nella penombra crepuscolare della sua casa, Bellow potrebbe essere un principe in esilio che ripensa alle rovine dell’impero perduto. Ma le sue parole, anche se spesso di rammarico, non sono nè lacrimose nè amare. Se vi è un residuo di tristezza, Bellow lo nasconde dietro il sorriso distaccato, che si trasforma spesso in una schietta risata».
«Sono risorto e ce l’ho con tutti» dirà Bellow.
Queste poche parole nascondono la tremenda verità. Sono convinto che la vita è una reinvenzione continua: amare e odiare, gioire e soffrire, partire e ritornare, fuggire o combattere, provare a spiegare il sangue impazzito, rendersi conto che non ci si può fidare di nessuno perché quasi sempre chi ti accarezza l’anima nasconde un soffio di Satana. Disperati umani alla ricerca di chissà chi e chissà cosa: fino all’ultimo respiro, fino all’inevitabile epilogo. L’Uomo in bilico, l’Uomo in fuga, l’Uomo davanti alla fatidica “resa dei conti” è sempre solo con se stesso proprio come Saul Bellow. Non servono a niente le menzogne, le falsità, le ipocrisie dei parassiti senza dignità che infestano questo nostro mondo perché la “merda” della società viene sempre a galla. Solo dopo aver fatto i conti con te stesso, con la tua anima, potrai guardare i nemici sprofondare, gustare in bocca il sapore acre della polvere intrisa del sudiciume d’un marciapiede, Chicago o Milano non fa differenza, dimostrare che la maggioranza delle belle parole che ti vengono offerte non sono che un artificio di chi si vuole prendere gioco di te. Imparare ad amare il proprio dolore: ecco la soluzione rapida ed altamente efficace per chi non ha tempo da perdere. Un dolce veleno iniettato nelle vene per continuare a vivere nonostante tutto.
La scontrosa diffidenza, il suo modo di essere “triste e spavaldo” e anche quando perde quasi tutto riesce a spadroneggiare la scena «mi sento pieno di dolore ma dritto in piedi… So essere diligente nel soffrire. Non solo tocco il fondo, ma ci cammino avanti e indietro». E poi ancora «voglio stancarmi fino all’esaurimento per poter sopportare l’infelicità del divorzio (e la malignità delle donne)».
«Che stanchezza questa lotta che va avanti da cinquant’anni. Me la sento nelle braccia, nei pugni perfino». Bellow non tenne mai un diario e si limitava ad annotazioni, appunti, qualche riga dettata da un momento di forte tensione emotiva e “sentiva di avere ancora dei conti in sospeso” fino a dire «Quando mi alzo dalla mia scrivania, a volte mi sento spaesato: inoltre, detesto tornare a casa in un appartamento vuoto. Ma ho anche imparato ad apprezzare i piaceri della solitudine. E quando penso ai momenti d’inferno che ho passato, le mie serate solitarie mi sembrano il paradiso».
Sul palcoscenico d’un personale teatro dove a calcare la scena vi sono le sue creature ha sempre cercato di raccontare «una di quelle vite che non aveva ancora vissuto», tra matrimoni finiti male, caos esistenziale, sensazione di non essere mai amato abbastanza, insofferenza nel diventare un uomo capace solo di dire sì, risorto miracolosamente da una malattia con diagnosi che lo dava già spacciato, un autentico uomo in bilico del nostro tempo: un cercatore d’oro nel grande teatro della memoria, tra tragedia ed ironia. Un grande teatrante capace di indossare la maschera letteraria dello sproloquio, dei fitti monologhi (alcuni assolutamente da non perdere perché geniali), delle mirabili dissertazioni, e quel suo sorriso amaro che ha conservato sulla piega della bocca fino alla fine, è stato forse il tratto saliente della sua vita: le lacrime trattenute sono state la sua condanna, più volte ha affermato «I miei libri sono comici» quasi a scherzare del suo piacere cerebrale a raccontare le vicende d’un pover’uomo nelle grinfie delle seduttrici (leggi cinque mogli e numerose amiche).
Una bellissima donna che lo aveva accompagnato in una serie di conferenze, così sensuale ed attraente da avere un palmarès da paura, non solo aveva subito l’affronto di non essere stata corteggiata da Saul, ma neanche presa in considerazione. Quando fu chiesto a Bellow se non si fosse sentito in imbarazzo o magari un alieno e come mai non “ci avesse provato” rispose con tre velenose parole: «Devoradora des hombres».
Uomo stupefacente. A quarantacinque anni Saul Bellow viveva come quando ne aveva la metà: errabondo, senza legami, senza fissa dimora, senza un vero lavoro. La sua esistenza da “nomade intellettuale” era forse l’immagine d’un uomo che metteva in conto la sua incapacità o riluttanza ad assumersi impegni o responsabilità nei confronti delle persone che comunque, quasi sempre, lo avevano tradito o lasciato con il culo per terra. L’imperativo inderogabile era uno solo: “Trovarsi un posto nel mondo”.
Il franamento di ogni certezza, la mancanza d’una “vera famiglia” con la quale condividere la quotidianità o dell’amore d’una donna che non lo facesse soffrire, accorgersi che il tempo lasciava i segni sulla pelle, «lo smarrimento della mezza età, non implicavano un crollo esistenziale, rappresentavano, anzi, un inizio, non una crisi» come sottolinea James Atlas nella meravigliosa biografia Vita di Saul Bellow pubblicato negli Stati Uniti nel 2000 e in Italia da Mondadori nel 2003.
Certamente il rendiconto doveva essere onesto e qualche anno dopo affermerà senza troppi rimorsi: «Ho il cervello istupidito per l’età. O per le troppe donne».
Saul Bellow è l’Uomo senza messaggi, diffidente per natura, il figlio di immigrati ebrei russi con il desiderio incessante di dimostrare che era uno scrittore di talento, l’uomo ambizioso diventato uno scrittore di fama internazionale, il protagonista indiscusso di una tempestosa vita sentimentale, un “idrante innamorato” che si è sempre “sentito vittima” di donne fatali che lo hanno annichilito con costosi divorzi. I ritratti memorabili dei personaggi che costellano i suoi romanzi sono, quasi sempre, le persone, uomini e donne, amici e nemici, che ha conosciuto o solo incontrato di sfuggita nella sua vita: e sempre ha colto l’essenza di ognuno, con acume psicologico e umorismo, rendendo giustizia al suo stile libero, alla storia raccontata a modo suo.
«La lingua è un luogo dello spirito: alberga la nostra anima».
Le definizioni e le catalogazioni del suo stile narrativo lo infastidivano e l’etichetta di scrittore ebreo era una stronzata perché negava l’universalità della letteratura, della cultura e lo stesso Bellow dirà: «Allo stesso modo uno potrebbe essere definito astronomo samoano o violoncellista eschimese». Bellow, con onore, sosteneva di “non saper dire di che cosa trattassero i suoi libri” eppure parlavano della sua vita, affermava di non leggere le recensioni ai suoi libri eppure era attentissimo alle critiche e i recensori erano buffoni o addirittura vermi quando non capivano o fraintendevano le sue intenzioni. Gli scrittori che potevano mettere in discussione la sua egemonia venivano trattati con freddezza, quelli un gradino sotto erano “compagni di fatica”. Quando si rese conto che il vento era cambiato e il successo e la fama stavano entrando dalla porta principale di certo visse un momento di euforia ma comunque rimase abbastanza compassato perché “ne aveva viste tante nella sua vita” e come al solito con quel suo tono un po’ fatalista affermò «I venti del Paradiso mi soffiano sotto il sedere».
Saul Bellow è stato uno dei più grandi scrittori americani del Novecento, Premio Nobel nel 1976, uomo “controverso ed affascinante”, scrittore che spesso dirà «odio il sussiego», con semplicità disarmante amava ripetere che «la bellezza del romanzo non può sfuggire, basta essere un lettore».
Ma «non tutti quelli che scrivono libri sono scrittori, i bravi scrittori sono sempre più rari a ogni decennio che passa».
Bellow difese sempre a spada tratta una sua convinzione ricorrente: «la libertà di accostarci al meraviglioso, che nessuno ci può togliere, il diritto, e la grazia, di trarre il massimo da ciò che abbiamo».
Ad un amico rispose: «Non ho cambiato il corso del romanzo, ma della Iingua americana».
«La morte è una sfida. Per guardarla in faccia, devo tirar fuori tutta la mia grinta. Non mi getta nel panico. Mi incuriosisce».
Il 23 dicembre 1999 sua moglie Janis, a quarant’anni mette al mondo Naomi Rose. Il nuovo romanzo Ravelstein sarà pubblicato l’anno dopo. In una lunga intervista alla BBC a proposito del suo romanzo con una voce ormai tremante Bellow disse: «Quello che ho da dire, la sola cosa che ho da dire, è che conto di vedere i morti, i miei morti. Quando morirò, li troverò ad aspettarmi. Non faccio previsioni, nè mi immagino una scena precisa. Non saprei dire che cosa dirà mio padre, o mia madre, i miei fratelli, i miei amici. Con ogni probabilità, mi diranno cose che ho un gran bisogno di sentirmi dire».
In una delle pagine memorabili de Il dono di Humboldt, Charlie Citrine afferma: «Per quanta paura e rabbia provassi, la mia anima amante di sensazioni era anche gratificata. Ce ne voleva troppo, lo sapevo, per fare contento me. La soglia della gratificazione era ormai troppo elevata, nel mio animo. Bisognava abbassarla. Così non andava. Lo sapevo: bisognava cambiare ogni cosa» e, nella vita reale, Bellow lo fece sempre. Fino alla fine.
«Sit tibi terra levis», Mr. Bellow.
Massimo Barile