
Perle nerediSalvatore Conaci |
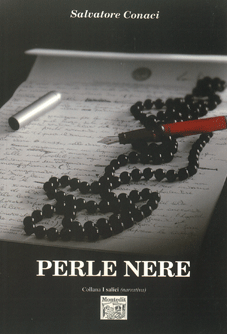
Collana "I Salici" - I libri di Narrativa
14x20,5 - pp. 72 - Euro 8,00
ISBN 978-88-6587-5513
Clicca qui per acquistare questo libro
In copertina: fotografia di Antonio Vatrano
PREFAZIONE
Edgar Allan Poe, espressamente richiamato a mo’ di chiusa di questi brevi racconti, è senz’altro il nume tutelare della fantasia dell’autore. Il ridurre il nostro giovane autore ad emulo dello scrittore americano nasconderebbe, però, i più ampi richiami semantici, letterari ed esoterici densamente presenti in questi sette scritti.
Come non riconoscere l’influenza di Lovecraft, di Gustav Meyrink o degli antichi scrittori di saghe nordiche nel gotico incedere della prosa di Salvatore Hermes Conaci.
Non solo ineluttabilità e mistero, volutamente ed ampiamente ostentati, ma anche, e viepiù, drammaticità dell’esistere e incondizionamento dell’agire, fortemente espressi sin dall’incipit del primo racconto, ci richiamano la morselliana affermazione “dell’inutilità del pregare chicchessia”.
Tragicità del vivere ma mai nichilismo, in quanto c’è un tempo fatto di istanti e di ore che rimandano a un domani in cui qualcosa di già iniziato si dovrà per forza compiere; un qualcosa reale o irreale, possibile e al tempo stesso impossibile, non forzatamente ma necessariamente teso, non da noi, verso l’eternità.
Due mondi, allora, fatti entrambi di percorsi veri e simbolici, di luoghi reali e onirici, di incontri attesi e inaspettati, di cambiamenti audaci e temuti, di rivelazioni cercate e subite.
Due mondi non separati, ma articolati su molteplici piani di tempo e di spazi, purché, coerentemente, si riesca a guardarli con “l’incredulità nell’onnipotenza del visibile”.
Ecco il mondo alluso delle fiabe, della poesia, dell’Upanishad, dei Vangeli; il mondo, o i mondi di Salvatore Hermes Conaci, in cui tutto si fa segno e simbolo, in cui tutto orienta ad unico centro che è l’esistere di ognuno.
Parafrasando Cristina Campo “Due mondi – e io vengo da entrambi”, dice il nostro giovane e già valente Autore.
Girifalco, 30 dicembre 2014
Vincenzo Fulvio Attisani
Perle nere
Rinato
15 Novembre 2013
Chiunque dica che nella vita c’è sempre una via di fuga, si sbaglia.
L’ho capito, anzi sperimentato direttamente sulla mia pelle, sui miei nervi, sull’indole solitamente stoica del mio animo, qualche giorno addietro (a trentacinque anni!) per la prima volta. Ho finalmente dimostrato, a quanti hanno udito dalle mie labbra la terribile storia che ora mi accingo a raccontare anche ai coraggiosi, insani lettori di queste righe, che non bisogna far certezza della mutevolezza del mondo che ci circonda. Alle volte, l’eterogeneità delle cose non porta all’uscita da una situazione nemmeno col massimo dell’impegno. Per lo meno, non finché non sia compiuto ciò che il Cielo, il Fato o il Demonio han fatto iniziare. Come già detto, sono sempre stata una persona ferma ed impassibile. Raramente, in passato, ho visto turbata la mia serenità. Ho sempre vantato nervi saldi, calma e lucidità finanche nelle vicende più drammatiche della mia vita. Caratteristica, questa, che mi ha sempre dato una marcia in più rispetto a chiunque mi gravitasse attorno. Che proprio agli occhi dei miei prossimi ha contribuito a farmi divenire punto di riferimento, ancora di salvezza. Forse per questo motivo, colleghi, amici e familiari ancora stentano a credere a questa tremenda storia. Prego Iddio, quindi, che almeno voi, pazienti e coraggiosi lettori (che nessun tipo di preconcetto nutrite nei miei riguardi), abbiate modo e forza di credermi.
Era un giovedì 12. Non sono mai stato superstizioso. Mai. Col senno di poi, però, mi rendo conto di quanto sia poco trascurabile questo dettaglio. Mi recavo, come spesso facevo, quando ne sentivo la necessità, a far visita ai defunti, al cimitero. Non è mai stata, questa, un’azione meccanica. Prima della mia orribile esperienza, mi limitavo a fare quest’omaggio solamente quando sentivo dentro di volerlo. Quella sera, l’istinto mi spinse dai miei cari estinti piuttosto tardi, ma si sa: taluni, inspiegabili istinti sono impossibili da domare. Nonostante iniziasse a corrucciarsi, mi addentrai nel camposanto, convinto che sarebbe bastato un lesto giro dei più cari congiunti a farmi uscire da lì. Per lo meno lo speravo. L’unico motivo di turbamento nella mia vita, infatti, fino a quel giorno, era stato il pensiero (o l’inspiegabile paura, se vogliamo) di ritrovarmi chiuso in un cimitero.
Sapevo bene di questo mio limite per un motivo ben preciso: qualche anno prima, sempre in visita ai defunti, ma alle tre del pomeriggio, vidi da lontano (percorrendo il corridoio d’uscita) un operatore ecologico mettere mano al cancello e spostarne un’anta per spazzare via alcuni rami incastrati sotto. Nonostante fosse pieno giorno, il terrore che quell’uomo potesse chiudere il cancello e lasciarmi intrappolato là, tra quei marmorei edifici di morte, mi fece scattare violentemente e inopinatamente, come il felino che abbia visto una preda inaspettata. Presi a correre, urlando e pregando lo sbigottito signore in arancione di non chiudere “il maledetto cancello”. Inutile descrivere l’imbarazzo del momento in cui mi trovai fuori, senza panico che potesse accecarmi e instupidirmi, e con l’espressione basita dell’uomo davanti a me.
Ero, dunque, intenzionato a far presto. Guardai l’orologio: le diciassette e quarantacinque. Sì, avrei dovuto sbrigarmi. Raggiunsi inizialmente la tomba di un vecchio zio di mio padre. Pregando per lui alla mia pragmatica maniera, mi rassicuravo osservano la gente intorno a me: era poca, ma i modi lenti e rilassati di ognuna di quelle persone mi tranquillizzava. Se esse non andavano di fretta, io non avevo motivo di affannarmi. Nonostante si formassero le prime ombre, quindi, mi rilassai, godendomi l’abluzione catartica della preghiera. Andai, poi, verso la tappa successiva: una cugina, prematuramente scomparsa, di mia moglie. Alla tomba accanto, vegliava una signora poco più che sessantenne, evidentemente vedova (visto il nero che indossava, e il bell’uomo della foto, che guardava commossa). La signora in nero mi rivolse un saluto appena accennato, che io ricambiai con uguale misura. Stava immobile. Lo notavo con la coda dell’occhio. Quell’immobile figura nera, al mio fianco, era rassicurante. Guardai la foto della graziosa cugina di mia moglie. Iniziai a pregare isolandomi dal mondo, certo della compagnia della garbata vedova. Le preghiere divennero intense, dense come il dormiveglia, complici i ricordi dello spensierato sorriso di quella ragazza che ora mi fissava dalla foto. La vita è ingiusta. Il pensiero di quella giovane e briosa esistenza, sciupata dal cancro, mi rese quasi sensibile. Il ricordo di Anna era quasi più struggente del giorno stesso in cui se ne andò. Pensai che, sotto quella lastra d’ebano, riposava la persona che tante volte avevo abbracciato, sfiorato. La persona che tante volte aveva riso, pianto, scherzato, litigato con mia moglie. La persona che si portava dietro tutti i piccoli contributi che ciascuno aveva apportato nel suo pur breve tragitto. Realizzai con un brivido quanto, in fondo, ci fosse un pezzo di me, sotto quella gelida lastra. Tutti, tutti dovremmo chiederci quante volte sia possibile morire, durante questa vita. Strano, per un tipo come me: pensieri profondi. Così profondi che, quando riemersi per controllare se la signora fosse ancora al mio fianco, ciò che vidi mi paralizzò per il terrore. Era quasi buio, e la donna non c’era più. Quanto maledetto tempo avevo passato a rimuginare? Guardai l’orologio: le 18:35. Come avevo potuto non udire nemmeno l’avviso acustico della chiusura? Diedi un’ansiosa occhiata tutt’intorno a me: nessuno, nemmeno la Solitudine mi affiancava.
Raggiunsi di corsa, e col cuore in gola, il corridoio dal quale ero arrivato. L’unico segno di vita: un macabro mare arancione di lumini. Impossibile descrivere l’orrore che provai. Corsi nella direzione in cui mi aspettavo l’uscita più vicina, cercando di guardare solo ed esclusivamente il pavimento. Tutto, al crepuscolo, prende la forma dei nostri peggiori incubi, soprattutto quando ci si trova in un camposanto. La strada mi parve insolitamente lunga. Era quella di sempre, n’ero certo, ma qualcosa non tornava. Continuavo a correre; continuava a calare la luce. Dov’era il maledetto cancello? Giunto al punto in cui avrei dovuto trovare l’uscita, lo giuro su quanto possiedo di più caro, vidi davanti a me una cappella. Mai mi sentii, in vita mia, smarrito come in quel momento. Era improvvisamente cambiata la struttura di quel luogo? Stavo impazzendo? Mi guardai nuovamente attorno, atterrito. Credevo di essere in una zona periferica del cimitero ma, osservando da fermo, l’impressione era di trovarmi nel cuore di quel posto. Mi resi conto che il buio era diventato, ormai, totale. La mia paura più violenta e nascosta, forse la mia unica e tremenda paura, si stava materializzando tutt’intorno a me. Sapeva di buio, di chiuso, di terrore radicato nell’anima fin dall’infanzia, e cresciuto col tempo, nutrito dal lato di me che meno conoscevo. Sapeva di latrato di spirito, di pianto dannato. Sapeva di tutto e di nulla al contempo. E mi scuoteva, mi carezzava, mi stressava e confondeva. Ero incredulo e asfissiato. M’impegnavo a non guardare le mie silenziose e tremolanti guide: i maledetti lumini arancioni. Era però impossibile distogliere lo sguardo da quello spettacolo, per quanto potesse essere agghiacciante! Il tremolio delle fiammelle rendeva mobile ogni ombra, sicché pareva di trovarsi in un muto, tetro mondo indipendente, con tutta la sua sorda dinamicità. Mi cadde, poi, l’occhio sulla foto di una tomba che avevo accanto: un uomo intorno ai settant’anni, dall’espressione spenta. Lo immaginai, senza volerlo, nella sua bara, esattamente con quell’espressione. Per poco non ebbi un infarto quando, per effetto delle stupide fiammelle tremolanti, la sua mascella parve contrarsi. Il mio corpo era tutto un brivido. Ripresi a camminare, voltandomi continuamente indietro, per scongiurare ogni presenza sgradita alle mie spalle. Gli unici suoni che si sentissero, in quella città di morte, erano l’eco dei miei passi (eco inspiegabile, vista l’apertura del luogo) e il ronzio del debole vento tra i rami densi dei numerosi cipressi. In che razza di situazione mi trovavo! Guardai l’orologio: constatai con indicibile ribrezzo ch’era tornato alle 17:45! Sentii il bisogno, continuando a camminare, di tenermi la testa tra le mani per verificare che fosse tutto vero e ‘regolare’. Finalmente raggiunsi una zona familiare, un punto di riferimento: una fontana nei pressi della tomba dello zio che avevo visitato precedentemente. Non ebbi il tempo di esultare per il risultato (seppur minimo) che qualcosa mi scosse dalla cima dei peli fin nelle viscere, e da esse di nuovo ai peli. La pelle mi si accapponò così violentemente da far male. Un suono familiare. Dei passi. Dei passi svelti. Dei passi che, da una viuzza particolarmente buia, sembravano avvicinarsi sempre di più. Appena captate queste informazioni, vidi emergere, dall’oscurità di quella stradina, la nera figura di un uomo. Fu sufficiente. Urlai come non avrei mai sospettato di poter fare: un urlo che, più che dal profondo del corpo, venne dai meandri più improbabili dell’anima mia. Corsi via. Corsi, senza mai voltarmi indietro, a una velocità che forse mai più raggiungerò, perché mai più sarò posseduto da un terrore simile. Mai più nella vita, ne sono certo! Mi resi subito conto, però, che al mio urlo di terrore rispose un altro, ugualmente angustiato. Mi fermai. Violentai la mia mente e la costrinsi a tornare razionale: non si udivano più passi, ma ciò non poteva fare, di quella figura, uno spirito (mi dicevo). Doveva certamente essere un uomo in carne ed ossa, spaventato tanto quanto me. Un compagno di sventura, insomma. Dovetti sforzarmi per credere che fosse quella la verità, ma alla fine me ne convinsi. Urlai, quindi: «Chi c’è?». Nessuna risposta. «Vi prego, rispondete! Sono rimasto chiuso qua e non riesco a trovare nessuna uscita!». Mi rispose un rumore di passi lenti, nuovamente nella mia direzione. Questa volta attesi, pugni e denti stretti, narici dilatate. Dall’ombra uscì un uomo che sembrava aver superato da poco i cinquanta, ben vestito: un impeccabile completo nero, molto British. L’espressione, sul suo volto allungato da un demoniaco pizzetto a punta, era inspiegabilmente calma. Sorrideva quasi! Tirò fuori dalla tasca del panciotto un delizioso orologio a cipolla. «Dovremmo prestare più attenzione al tempo, – disse – ce lo meritiamo». La sua ironia mi calmò. Era stranamente disteso e sicuro, quasi rassegnato. Una malcelata rassegnazione che pochissimo si confaceva con l’urlo che aveva lanciato poco prima. La sua innaturale naturalezza, però, mi rasserenava. Mossi un passo verso di lui. E lui a me, anticipandomi: «Non sono del luogo. Non ho la minima idea di come si possa uscire. Sono venuto a porgere il mio saluto ad un amico fraterno, ed eccomi qui: incastrato e sperduto da chissà quando». Era buffo nei modi e nei gesti, pareva un uomo d’altri tempi. Nonostante tutto, mi piaceva. Doveva piacermi. L’immediatezza degli avvenimenti me lo fece piacere subito. Gli porsi la mano: «Mi chiamo Emanuele. Mi vergogno ad ammetterlo ma io sono del posto, e trovo io stesso difficoltà ad uscire!». Sorrise distrattamente. Forse non ricambiò la stretta; forse lo fece in modo particolare. Non ricordo. Per un attimo sentii il peso dell’assurdità della situazione mettere alla prova i miei quadricipiti, le mie ginocchia. Quante possibilità c’erano che si materializzasse la mia fobia? Soprattutto, quante ce n’erano che la cosa capitasse a due persone, nello stesso cimitero, contemporaneamente? La perplessità non durò che un attimo. Quell’uomo stava davanti a me, e lo sentivo parlare, respirare, muoversi. La mia disavventura era maledettamente reale, e reale era il mio compagno di disavventura. Decidemmo insieme la strategia per uscire da quel posto. Ricordavo bene i tratti delle piante di quel dannato cimitero. La mia indole, inconsciamente timorosa delle situazioni come quella che vivevo, mi aveva suggerito più volte di osservarle alle varie entrate del luogo. La forma era un perfetto, esteso rettangolo con una maledettissima uscita su ogni lato. Avremmo percorso il cimitero formando una croce (sfruttando le due strade perpendicolari principali), così da coprire i quattro lati, a partire da un punto preciso, che avremmo usato come riferimento. «La fontana?», mi chiese, dandomi la vaga idea che potesse leggere il mio pensiero. Volli sapere perché avesse proposto proprio quel posto. «Semplice», rispose, «alla fontana convergono le due strade dalle quali siamo giunti noi, incontrandoci. Tu venivi da nord, io da ovest. La strada per la quale sei scappato tu, quando mi hai visto, è il braccio est della nostra croce; e poi rimane l’ultima strada, quella a sud della fontana, che io non ho ancora percorso, e nemmeno tu, ne sono certo!». Mi sorprese la sua capacità di orientarsi in un luogo per lui sconosciuto. Era acuto. La sua spiegazione era coerente e semplice, mentre io avevo già iniziato a pensare che avesse chissà quali stranissimi poteri. Mi ero fatto prendere dalle emozioni, dal terrore, e la cosa mi tediava particolarmente. In quel momento, quell’uomo era, per me, l’ancora di salvezza che solitamente io rappresentavo per gli altri. «Bene», miagolai miseramente, «tanto vale ripartire da nord. Insieme saremo più tranquilli e attenti ai particolari. L’uscita non ci sfuggirà».
Ci avviammo per la strada che avevo percorso qualche minuto prima. Quasi non sentivo i passi del mio nuovo ‘amico’, che pure mi camminava accanto. I nostri passi sincronizzati si bloccarono, all’inizio del nostro cammino, quando ci parve di sentire un lamento. La cosa non durò che un unico, gelido istante, poi svanì. Sembrò nascondersi in quell’inferno di marmi e luci fioche, come un diavolo che si divertisse a tentar due anime all’orrore, e poi sparire sghignazzando. Mi voltai a guardare il mio compagno di sventura. Era rigido. Il suo sguardo, paragonabile a quello impassibile e spento di una statua, fissava il vuoto. «Agghiacciante!», sibilò appena. Poi riprese, quasi in trance: «Così terrificante da poterne morire!». Pronunciò quell’ultimo verbo voltandosi verso di me, fissando i suoi occhi sgranati nei miei. Sarebbe da matti pretendere di descrivere il brivido mordace che provai per colpa di quello sguardo che, mi stupì pensarlo, tante affinità aveva con lo sguardo di chi ha appena restituito l’anima a Dio. Volli sforzarmi di guardare altrove. Di guardare avanti. Di proseguire il cammino senza dire nulla. Lui mi seguì. Le lapidi ci scorrevano accanto. Somigliavano tanto alle disgrazie della vita, che incrociano il cammino dell’Uomo, e lo tormentano, lo spaventano, ma scivolano alle sue spalle divenendo amari ricordi. Un’upupa volò davanti a noi, passando dall’albero alla nostra sinistra a quello alla nostra destra. Si fermò ad osservarci, pietosa e dolente. Colsi del dolore, nel suo sguardo. Il sentiero di morte proseguiva, e l’uscita non appariva nemmeno da lontano. Dopo un numero certamente minimo di passi (non saprei quanto tempo fosse passato), ci fermammo improvvisamente. Impossibile descrivere quanto fossi atterrito, e quanto certamente dovesse esserlo il mio compagno di sventura. Davanti a noi si ergeva quello che doveva essere il limite nord del cimitero, e stavolta differiva anche da quello che aveva fermato me poco prima. Non c’era nessuna cappella, nessun cancello, solo un esteso muro costellato di ceri e fotografie. Terribile. Lui, una leggera sfumatura di rassegnazione sul viso pallido, mi disse inspiegabilmente: «Non te l’ho ancora detto, Emanuele: io sono Pàlin, Pàlin Gènius. Il nome è importante». Pareva fosse sotto shock. Non seppi cosa rispondere. Cercai ancora, con lo sguardo, il maledetto cancello. Niente. Decidemmo di tornare alla fontana. Da là, avremmo tentato il braccio ovest della nostra croce. Al ritorno, l’upupa ci attendeva ancora sull’albero che ora stava alla nostra sinistra. Quel dannato uccello, ora, pareva ridere. Trovai macabro e sadico il suo verso. Non potei non pensare a La Risata del Diavolo di Paganini. Rabbrividii, ancora. Quando iniziavo già a credere che non avremmo più trovato nemmeno la fontana, ce la ritrovammo di fronte. La strada ovest era molto meno illuminata. Trovai curioso come alla strada prima fossimo più assistiti dalla luce ma meno avveduti, mentre ora, meno sprovveduti, non avevamo che il favore delle tenebre. Iniziai a sentire freddo nonostante camminassi velocemente da un po’. Pàlin (che gran soddisfazione, conoscerne il nome!) non batteva ciglio, non pronunciava parola, non mostrava brivido. Camminava. Semplicemente mi seguiva (o mi guidava?!) come un automa. Mi impensierì particolarmente un fatto: più passava il tempo, meno sentivo i suoi passi. Pareva avere la leggerezza di una ballerina, il passo felpato di un felino. Perdevo colpi, o ne acquistavo? Era un tipo strano, ma non poteva non andarmi bene. Soprattutto non poteva non piacermi il fatto di aver compagnia in quella mia disavventura. Mentre arrovellavo la mia testa, già scombussolata, accadde un fatto tremendo. Si alzò, inopinatamente, un vento fuori dal normale. Alcuni cassonetti vicini iniziarono a sbattere i loro coperchi, come se mille anime dannate, inferocite, stessero sfogando la loro ira ed i loro tormenti su di essi. Altri oggetti, più piccoli e leggeri, come palette e scope dei netturbini, volarono via andando ad infrangersi contro una cappella. Quella cappella, poi! Mi impressionò da subito il simbolo inciso poco sopra la vetrata d’entrata: un serpente si mordeva la coda, formando un cerchio perfetto. Avevo visto tante volte quel simbolo, essendo sempre stato attratto dall’esoterismo. Si trattava dell’Uroboro. Simboleggiava eterno ciclo, eterna rinascita, eterna trasformazione. Sapevo che, alle volte, al centro del cerchio formato dal serpente campeggiava una farfalla. Dapprima illuminata all’interno, come se dentro continuassero in eterno indicibili e arcani riti funerei di chissà quale terrificante tregenda, la singolare cappella piombò immediatamente nel buio più denso. Subito dopo, avvenne lo stesso, poco a poco, passo dopo passo, per ogni altra cappella nei dintorni, per ogni lumino delle tombe che ci circondavano. Fummo inghiottiti dal più terrificante tipo di buio: quello pregno di morte. Il vento continuava. Faceva urlare i cipressi in maniera tale che, se oggi mi chiedessero di associare un suono all’Inferno, non esiterei a pensare a quello.
«Maledizione, Pàlin! Tu ci vedi?!», chiesi al mio furtivo compagno, giusto per sentirmi meno solo. «Purtroppo ci vedo anche troppo bene. È normale che non ci capisca nulla. Domani sarà tutto più chiaro». Stava diventando anche mistico. Qualcosa, nella sua voce e nel suo tono, mi sconvolse, ma non volli sembrare eccessivamente preoccupato e diffidente. Non replicai. In pochi minuti arrivammo al limite ovest. Il vento cessò all’improvviso, e tutti i ceri e i lampioncini, prima spenti, si riaccesero. Ebbi paura. Quando guardai Pàlin in faccia, mi parve più pallido dei momenti precedenti. Non glielo feci notare, e mi voltai a cercare l’uscita. La conformazione dell’intero cimitero pareva essersi modificata per far torto a noi. Mi parve d’impazzire. Afferrai d’istinto la giacca del mio compagno e, strattonandolo con un gesto disperato, gli urlai contro: «Come diavolo usciremo da qui?! Perché non ti pesa quanto pesa a me?!». Di tutta risposta, egli mi guardò negli occhi, con uno sguardo indecifrabile che s’insinuò nelle mie pupille come solo un ago avrebbe potuto fare. Poi, un filo di voce (la sua voce?), sussurrò: «Mi pesa tremendamente. Ma esistono cose per le quali affannarsi è vano». Vi sfido solamente a pensare che voi, lettori cari, avreste avuto il coraggio di ribattere. Tornammo alla fontana senza proferire parola. Mi chiese improvvisamente: «Non hai congiunti in direzione sud, vero?». Io, sempre più perplesso: «No, perché?». «Perché nemmeno io ne ho, là. Andiamo ad est, per ora».
Lo seguii senza alcuna voglia di capire, né di discutere. Volevo abbandonare quel luogo, e non avevo perso la speranza di trovare l’uscita prima dell’alba. Giunti al punto in cui il mio compagno ed io avevamo parlato per la prima volta, egli tirò fuori il suo orologio, proprio nella stessa posizione in cui l’aveva fatto precedentemente. Mi parve di vivere un fastidioso dejà vu. Il bell’orologio ancora in mano, Pàlin sorrise, poi mi chiese: «Sei stanco?». Appena ebbe finito di parlare, qualcosa nel suo viso mi colpì: la sua espressione era ferina, mostrava quasi i canini in un sorriso quantomeno bizzarro. «Sì, Pàlin, sono stanco! È la cosa peggiore che potesse capitarmi!», risposi, con un tono a metà tra la disperazione e la rabbia. Ripresi a camminare, senza curarmi dei suoi movimenti. Mentre tiravo dritto, sentii una voce urlarmi alle spalle, divenendo sempre più alterata, furiosa, irreale: «NON LAMENTARTI, EMANUELE! A TE È ANDATA BENE! IO QUI SONO MORTO!».
Quelle parole agghiaccianti, urlate in modo tutt’altro che umano, mi paralizzarono. Il vento tornò, fortissimo! La croce di una tomba che guardai casualmente si capovolse. Successe la stessa cosa per ogni croce che cercai, disperato, con gli occhi. Non mi fermai a riflettere se stesse realmente accadendo ciò che vedevo. Mi voltai, istintivamente, indietro: Pàlin non c’era più. Contemporaneamente, un lamento straziante si diffuse in tutto il cimitero, ad un volume tanto elevato che parve assordarmi. Quel lamento non terrorizzò me, no! Terrorizzò la mia stessa anima, tanto fortemente che non sentii più il mio corpo! Non ebbi la forza di urlare. Corsi! Corsi ancora in direzione est, verso il punto dal quale ero entrato in quel maledetto posto. Il lamento proseguiva. Mi dava l’impressione di avere il Male alle calcagna. Corsi ancora più veloce, probabilmente sollevandomi da terra, di tanto in tanto, per via del ritmo pazzesco che avevano raggiunto le mie gambe.
Improvvisamente, davanti a me, una visione incantevole: l’uscita del braccio est! Il cancello era chiuso, ma mi ci vollero circa cinque secondi per saltarvi sopra e scavalcarlo.
Una volta a casa, mani tra i capelli, cercai di analizzare la vicenda fino alle prime luci dell’alba. Quando il sole iniziava a ricordare al mio emisfero che la vita non si era interrotta nemmeno quella notte, io uscii di corsa, diretto al cimitero. Sì, sarei tornato là. Dovevo schiarirmi le idee. Avevo bisogno di certezze che dissolvessero i miei dubbi sulla mia stessa sanità mentale. Parcheggiai l’auto praticamente in mezzo alla strada: al diavolo il traffico di quella dispersa stradina di periferia! Un addetto stava aprendo il cancello che qualche ora prima avevo scavalcato come uno psicopatico. Entrai, guardingo a dir poco. È inutile dire che guardai continuamente, con sospetto, l’ignaro netturbino finché non sparì dalla mia vista. Le croci che avevo visto capovolgersi erano tornate nelle loro posizioni esatte. Sentii il bisogno di scrollare la testa. Raggiunsi la fontana. Sapevo dove sarei dovuto andare. Mi diressi a nord. Nel punto esatto in cui Pàlin aveva pronunciato il verbo “morire”, un uccello stramazzò al suolo, ai miei piedi. Era certamente l’upupa della notte appena trascorsa. Ogni caratteristica era identica a quella dell’animale visto di notte. Perché non ero per niente stupito?
Scavalcai la carcassa del povero volatile, giunsi all’estremità nord: il cancello, non ancora aperto da alcuno, era ben visibile ora. O meglio, c’era, ora! La notte precedente, al suo posto, vi era solo un’immensa diga di morte, costellata di ceri. Laddove il mio compagno di disavventura mi aveva confidato il suo particolare nome (proprio in quel preciso punto!) qualcosa attirò il mio sguardo sul pavimento di cemento: proprio sotto i miei occhi, una farfalla nasceva dalla sua crisalide. Quell’essere leggiadro mi sfiorò il volto, e svolazzò alle mie spalle, imboccando la direzione che, stranamente, mi aspettavo. La seguii. Mi portò fino alla fontana, poi andò verso il braccio ovest della croce che avevo percorso poche ore prima. Il cerchio si stava chiudendo. Non ero matto! Avrei potuto finalmente liberarmi dell’insopportabile fardello raccontando l’incredibile fatto, senza dover fare i conti con la mia coscienza. Il freddo di quella mattina mi graffiò il volto, mi irritò gli occhi. Sentii il bisogno di stropicciarli, ma non volevo perdere la mia graziosa guida alata. La guardai quanto più intensamente fosse possibile, con gli occhi certamente arrossati e colmi di lacrime. Poi, senza smettere di correre in quell’esatta direzione, mi portai le mani sul viso e diedi loro sollievo. Quando li riaprii, la farfalla era sparita, ma mi trovai proprio di fronte a ciò che cercavo: la cappella col singolare simbolo inciso sopra. Un fatto mi sconvolse: questa volta, al centro del cerchio formato dal serpente, vi era scolpita la farfalla!
Mi avvicinai alla vetrata della cappella, bloccata da un catenaccio. Ora la luce mi assisteva. Ora era tutto chiaro. Vidi la foto della tomba all’interno. Tremai! Lessi le incisioni sulla lastra marmorea:
Renè Palingenius Noegun
– 1886
– 1951.
Sotto i pochi dati del defunto, credetemi, lettori cari, campeggiava una frase, incisa sotto una stella a cinque punte: “Esistono cose per le quali affannarsi è vano”.
Vale!
Et tu!
[continua]


