
Zacintha in mezzo al mare - Da Como al Mediterraneo in cerca della vitadiMaria Orsola Castelnuovo |
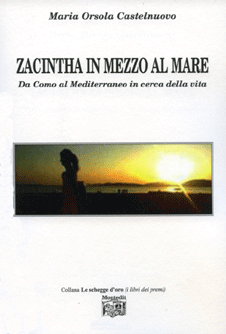
Collana "Le Schegge d'Oro" - I libri dei Premi - Narrativa
14x20,5 - pp. 142 - Euro 12,50
ISBN 978-88-6587-3885
Clicca qui per acquistare questo libro
In copertina: fotografia di Flavio Sturdà
Pubblicazione realizzata con il contributo de IL CLUB degli autori in quanto l’opera è segnalata dalla Giuria nel concorso letterario Jacques Prévert 2013
«Maria Orsola Castelnuovo propone un romanzo che è affascinante, dimostrando notevole acutezza nel penetrare l’animo umano e qualità letteraria nel far rivivere atmosfere, stupende immagini e suggestioni dell’umano vivere. Il nucleo portante, dopo gli incontri casuali di una donna con un giocoliere, prima nella città di Siena e, poi, a Copenaghen, sono le narrazioni delle tre vite di quest’uomo: la prima vissuta nelle valli dove era nato; la seconda, vissuta in Europa, tra i giocolieri di strada, dopo la perdita del lavoro e la separazione dalla moglie; e, infine, la terza vita con l’approdo all’isola del Mediterraneo che lo accoglie come un clandestino in patria, senza identità e senza documenti, un Mattia Pascal del nostro tempo. Fascinazione e propensione all’incantamento davanti alla meraviglia della vita».
Massimo Barile presidente della giuria del premio internazionale Jacques Prévert 2013
Zacintha in mezzo al mare - Da Como al Mediterraneo in cerca della vita
A Lally
L’ANTEFATTO
Alcuni anni fa mi trovavo a Siena il giorno dopo Capodanno. Ero ai bordi del Campo, nella parte alta, al tavolino d’un Caffè: era una bella giornata e si stava bene all’aperto.
Guardavo, nella parte inferiore della piazza, la Torre del Mangia ai cui ranghi supremi s’intravedevano turisti in cerca di nuove inquadrature per la fotografia d’autore. Consideravo che lo spazio sembrava ridotto, rispetto a quando lo si vede gremito di pubblico per il Palio. Il cameriere intanto teneva a raccontarmi quanto gli spazzini avessero faticato il giorno prima a rimuovere il carico di corbellerie da notte di San Silvestro.
Udii un certo clamore con risate e applausi provenire dalla mia sinistra e volsi il capo in quella direzione, così per prassi, senza provare grande curiosità o interesse: un drappello di turisti e visitatori avanzava osservando le spiritosaggini d’un giocoliere di strada, che non si esibiva in numeri acrobatici o d’effetto, ma semplicemente si faceva burla di volta in volta di qualche passante ignaro. Prima si affiancava ad un signore distinto, imitando i suoi gesti e il suo portamento, finché quello se ne accorgeva, notando un certo scompiglio tra il pubblico, che compatto volgeva lo sguardo verso di lui.
Poi agganciava il berretto di un altro, con un minuscolo amo legato ad un’ancor più minuscola lenza; indi sottraeva la bottiglia ad un bambino che beveva pacifico trasportato a spalle dal padre, e gli rifaceva il verso. Proseguiva con altre trovate dello stesso tipo, coinvolgendo i presenti che si divertivano per l’insolito passatempo capitato lì sulla piazza; perciò quando decideva, con regolare cadenza, di passare per la questua col suo cappellino rosso scuro a forma di semicono rovesciato (un fez senza nappa), ritirava il corbello pieno di monete.
Ad agosto ero a Copenaghen e lo rincontrai, con il medesimo spettacolo, lo stesso berretto, la medesima disinvoltura:
“È quello di Siena, è quello di Siena.”
E lui rideva, scrollando la testa per diniego.
Qualche anno dopo, in un’isola del Mediterraneo circolavo tra i campi lontani dall’abitato e uno di essi attirò la mia attenzione: era un’estensione di piante di patate in fiore. Mi avvicinai allo steccato che le recingeva, per chiedere quando le avessero messe sotterra: eravamo a metà marzo. Mi venne incontro un vecchietto piccolo e arzillo, che immaginai proprietario dell’appezzamento.
Le piantavano presto, a gennaio; dovevano esser pronte per la raccolta prima dell’inizio dell’estate, altrimenti avrebbero sofferto all’eccessivo calore.
Indicai lì accanto un’aiuola di iris blu, splendidi. Mi disse: “Oh, lì è mia moglie, sono solo fiori.”
Poco distante, tra le piante di patate, un uomo più giovane chinato a zappare dava l’impressione d’ascoltare divertito. Le maniche rimboccate lasciavano vedere avambracci di pelle chiara, lunghi e poco muscolosi, qualcosa di familiare, che mi ricordava gli uomini di casa nella mia infanzia, dediti anche loro all’attività contadina. Mi sembrò estraneo a quel clima e a quell’ambito, più affine alle terre da cui io stessa ero scesa in vacanza.
Il vecchio riprese il suo lavoro e io mi soffermai ancora un attimo: mi piaceva quel terreno così ben tenuto, così rigoglioso quando avevo lasciato la nostra campagna ancora spoglia, fresca d’aratura.
Lo zappatore si accorse del mio interesse, della mia esitazione; abbandonò l’attrezzo e poco dopo mi si avvicinò con la mano sinistra tesa in avanti, ricoperta dalla destra, con circospezione, come se vi racchiudesse una magia. Era alto, come avevo immaginato, ed imponente nella sua magrezza. Sollevò lentamente la mano che copriva l’altra, per lasciarmi vedere il suo tesoro; lo tratteneva appena con due dita, per non lasciarlo sgusciare via di scatto: un breve rettile, col capo sollevato all’erta.
“Questo è un ramarro”, mi disse, rivelando un accento a cui bene ero accostumata.
“Lo vedo.”
“Lo vedi?”
“Certo. Conosco bene i ramarri.”
Così risposi, ma qualcosa non mi convinceva: mi aspettavo di vedere la luminosità del blu cangiante; invece appariva verde smeraldo compatto, non riusciva, in quella luce e in quella posizione, a mostrare il meglio di sé.
“Ma il blu, non si vede?”, chiesi infatti.
“Non è un ramarro come i nostri. Qui, anche le lucertole hanno un altro colore. Non hai notato infatti che le patate a marzo sono già così alte, fiorite? Ti sembra che i limoni abbiano la forma e le dimensioni di quelli che abbiamo noi? Niente è uguale. Neppure noi, quando siamo qui. E tu eri convinta d’averlo riconosciuto, il ramarro…”
Mi vergognai un po’ per la mia presunzione e tacqui, provando un certo smarrimento. Non sapevo come rimediare. Poi alzai lo sguardo fissando il volto dell’uomo, che prima avevo notato appena. Era magro anch’esso. Aveva grinze, ma era così calorosamente simpatico, con un’espressione che avevo già vista e non riuscivo a collegare a nessun posto, a nessun momento particolare.
Gli chiesi “Posso prenderlo io? Il ramarro”, mi sentii di precisare, perché lui mi sembrava ora svanito nel filo di pensieri suoi che nulla avevano a che fare con la circostanza presente.
Mostrava esitazione, ma disse no e poi prese a ridere, scrollando la testa per diniego.
Allora seppi dove l’avevo visto, e quando: Siena, Copenaghen, erano solo due delle tappe. Lo riguardai con stupore e curiosità anche. Gli accennai al suo passato di giocoliere. Vi si dedicava ancora? Mi studiò per qualche attimo senza rispondere.
“Prendi il ramarro”, disse infine, “vieni a sederti. Se lo saprai ascoltare, ha una bella storia per te.” Sedette accanto a me sul muricciolo che recingeva la proprietà e prese a parlare: mi disse che, nel suo scarso mezzo secolo, era alla terza vita: la prima, poco più di quarant’anni, dignitosa e regolare nelle valli del granoturco dove era nato; la seconda, brevissima, attraverso l’Europa, tra i giocolieri di strada dopo la perdita del lavoro e la separazione dalla famiglia. La terza, la viveva ora nell’isola che l’aveva accolto senza documenti, clandestino in patria, Mattia Pascal del nostro tempo.
Una giovane, ch’egli chiamava Zacintha come il fiore tipico dell’isola, aveva assunto il ruolo ch’egli avrebbe voluto dalla sua propria figlia.
Fino a tarda notte rimanemmo lì nel campo: lui raccontava, fingendosi il ramarro o forse entrato in simbiosi con esso.
Non faceva pausa alcuna. Né io mi stancavo d’ascoltare.
I.
Le valli, conosci? nelle Prealpi, là dove il sole d’inverno arriva poco prima del mezzogiorno e se ne va poco dopo le due, proprio nell’istante in cui la domenica ci alziamo da tavola, perché ci siamo dilungati al pranzo della famiglia intera.
Là in una di quelle valli io sono nato: dal paese, attraverso camminamenti tra le rocce, puoi salire in alto, alla sella che supera i duemila metri e sotto si vede il lago immenso, senza limiti, che nelle giornate di vento, a cielo sgombro, diviene blu cobalto e non vorresti mai che scendesse la sera.
Eppure essa è foriera di bellezze indescrivibili: quando la luna non è piena e sale dopo che si è fatto buio, prima che arrivi ad illuminare tutto puoi vedere spuntare ad una ad una le stelle e Saturno che si affaccia prepotente, più nitido e voluminoso di tutti gli astri, proprio sopra di noi. La luna arriva tardi, sorge da dietro i crinali e quando ne vedi emergere un fiocchetto sai che poco dopo sarà lì tutta intera; la parte che è visibile quella notte, intendo.
Quando l’uomo era ancora nomade e viveva di caccia, credeva che la luna perdesse effettivamente le parti e poi crescesse di nuovo. Anche noi parliamo di luna crescente e calante: questa piccola poesia ci è rimasta, pur sapendo che ciò che di essa non si vede esiste tuttavia, e soltanto non è illuminato dal sole. A quel tempo mai avrebbero pensato che l’astro del giorno, scomparso dietro i monti opposti a quelli da cui era sorto, potesse continuare di notte a mandarci luce, grazie al riflesso della luna: era lei stessa che ci illuminava, brillando di luce propria e collaborando allo sviluppo della natura, che per alcun tratto di tempo viveva anche durante la notte; per altro tratto invece rispettava il riposo del settimo giorno.
La sella lassù in cima ti permette di scendere sul versante opposto e valicare la frontiera pochi metri più sotto. A volte si incontrano i doganieri che, non fosse per l’uniforme, sembrerebbero tranquilli cacciatori con il fucile in spalla; ti chiedono dove vai e raramente vogliono che tu esibisca i documenti. Invece spesso, lungo i sentieri e le mulattiere di discesa, si trovano cancelli o corde elettrizzate di sbarramento, con l’avviso cortese di richiudere dopo il passaggio: è a motivo delle capre, che sono lasciate fuori al pascolo. Le allevano così alla selvaggia e spesso sono ragazzi giovani che si danno a questa attività, incoraggiati dal fatto che il loro Paese li sovvenziona. Li senti parlare con provata competenza di un acquisto di seicento, settecento ovini, mentre da noi a malapena i pochi allevatori rimasti ne hanno una cinquantina.
Nella nostra valle, i pendii erano un tempo tenuti per l’erba, dal limitare delle stalle costruite appena a monte del nucleo delle case, fino a poco sotto le cime delle montagne, dove iniziano i picchi rocciosi: in alto erano i pascoli e sotto, a lambire le case e le stalle, i prati falciati.
Ora non lo diresti, perché negli ultimi vent’anni tutto s’è lasciato perdere e il bosco, che prima era solo sui fianchi rivolti a ponente, sta invadendo ogni spazio libero dal cemento.
Invece la piana sottostante i paesi era interamente coltivata e per lo più a granoturco. Le piante arrivavano a tre metri d’altezza, favorite dal concime delle stalle e dall’acqua abbondante che lasciava il terreno sempre umido. Ciascuna faceva a volte anche quattro pannocchie e la rendita era alta: si vendeva alle industrie che ricavavano bramata, fioretto per i biscotti, olio per la cucina raffinata.
Qualcuno ha mantenuto questa attività, ma non molti: morti i vecchi, gli eredi hanno preferito vendere i terreni alle immobiliari che vi hanno costruito schiere di case come celle d’api, che chiamano ville.
Sulla tavola dei nostri avi, in particolare di quelli che praticavano l’agricoltura, c’era sempre polenta: era compito degli uomini prepararla, nel paiolo appeso alla catena del focolare. In più d’una occasione m’è venuto spontaneo chiedermi che cosa mai si mangiasse in quei luoghi prima della scoperta dell’America, se non avevano il mais che qui è stato per secoli il solo alimento, provocando malattie di conseguenza; e non c’erano neppure le patate a sostituirlo eventualmente.
Il paese dove sono nato è diviso in due nuclei distanti tra loro circa mezzo chilometro, ciascuno dei quali aveva un tempo una funzione precisa: quello più soleggiato, aperto a sudest, era abitato da commercianti e artigiani del ferro, potremmo dire dalla borghesia; quello ad ovest, dove il sole arriva dopo aver superato il culmine del mezzogiorno e poche ore più tardi si trova già oltre l’ostacolo dei boschi, era abitato dai contadini che lavoravano la campagna giù nella piana.
I due agglomerati sono tuttora separati da un profondo vallone, scavato nei secoli dal torrente d’acqua verde, che noi chiamiamo Rio del Pinìn, che significa anche Piccolo, ma qui è il nomignolo per Giuseppe, Giuseppìn.
Un tempo, mi hanno raccontato, si chiamava semplicemente Rio, o Rivo, dando al nome comune valore di proprio, in quanto era il solo in paese e pertanto era il solo nel mondo intero.
Sui pendii che gli fanno da sponda, c’è una sorgente che zampilla tutto l’anno. Un percorso sotterraneo vi trasporta dall’interno della montagna l’acqua di displuvio, che non ha trovato subito sbocco nel torrente, ma si è infiltrata sotto il profilo del terreno, fino a raggiungere l’aria libera sopra il corso del Rio, nel quale si getta. Lo sbocco è incanalato con pietre, apposte a formare un alveo poco più largo di un tubo idraulico aperto verso il cielo.
Gli uomini che si apprestavano a suo tempo a cuocere la polenta rientravano dai campi verso le undici, a prendere il paiolo e recarsi con quello stesso alla sorgente, dove lo riempivano d’acqua che era più fresca e meno calcarea di quella delle fontane di paese, avendo viaggiato meno sotterra e assorbito pertanto i minerali in quantità inferiore.
Era una piccola processione, con i recipienti che cigolavano là dove i manici si congiungevano alle orecchie e il rame lustro dell’interno brillava contro la fuliggine che li ricopriva al di fuori. Al cigolio si accompagnavano gli scarsi brevi motti dei contadini, che dal mattino presto avevano compiuto preziose opere nella solitudine delle stalle prima, dei campi poi, e si scambiavano le impressioni sul tempo, sulle bestie, sulla semina o sul raccolto secondo la stagione.
Erano borbottii appena accennati, che riuscivano a capire solo loro, usi a dire poco per esprimere molto.
Se due si trovavano a camminare affiancati, l’uno esordiva guardando dritto davanti a sé: “La bestia. Forse va prima. La Rossa ha fatto. A posto.”
L’altro deduceva un discorso articolato che poteva suonare: “La mia mucca non sta bene. Le manca ancora qualche tempo prima di partorire, ma dubito che riesca ad arrivare al termine. Invece la Rossa (intendendo la mucca di un loro conoscente) ha avuto il vitello senza problemi.”
Quindi rispondeva: “Ieri. Lei a casa… Ha chiamato”, intendendo: “La mucca della mia stalla ha partorito ieri. Per fortuna a casa c’era mia moglie e ha provveduto a chiamare il veterinario.”
Il più vecchio degli uomini che si recavano alla sorgente era Pinìn; nessuno ne precisa l’età quando cita questa storia, perché nessuno forse la ricorda o perché non era poi così avanzata. Se dicessero che aveva settant’anni, come io credo fosse, non farebbe certo impressione al giorno d’oggi. Si moveva prima degli altri, perché non andava più nei campi, non reggeva il lavoro per ore di seguito e s’accontentava dell’orto fuori casa. Di solito, quelli che s’incamminavano per l’acqua lo incontravano che era già di ritorno.
Un giorno, tornando il drappello più o meno sparpagliato verso casa, i primi del corteo s’imbatterono nella moglie che veniva loro incontro agitata, con le mani allacciate dietro la testa scoperta, nonostante il freddo; senza scialle neppure. Si rivolse loro senza guardarli, ma scrutando più lontano, tra gli altri che sopraggiungevano e ancora più in fondo: “Il mio Pinìn, non l’avete visto?” Senza attendere spiegazioni, tutti insieme gli uomini piantarono a terra i paioli pieni d’acqua fresca e fecero dietrofront per mettersi alla ricerca. In un momento si sparpagliarono per le sponde ripide del torrente e per i sentieri limitrofi, li ispezionarono in lungo e in largo senza risultato. Più che salire verso monte, dove era poco probabile che si fosse avventurato, scendevano verso la piana: il pensiero di tutti, senza che si confrontassero, era che forse per un malore poteva essere caduto e l’acqua averlo trascinato. Ma anche in questo caso, le probabilità si riducevano, se si teneva conto che il torrente non era profondo tanto che l’acqua ricoprisse un uomo e neppure così impetuoso da trascinarlo, e poi si sarebbe incagliato tra le pietre presto o tardi.
Scambiandosi sguardi che venivano riportati come un passaparola a quelli più distanti, ritornarono indietro. E la decisione fu opportuna, perché ancora una volta qualcuno venne incontro a loro, un ragazzino che era stato mandato lesto lesto dalle altre donne per avvertire che la ricerca era inutile: Pinìn era morto.
La moglie stava pulendo la verdura al piano di sotto; l’aveva visto uscire col paiolo, ma non rientrare e, insospettita dal ritardo, gli era andata incontro. Partiti gli altri alla ricerca, le vicine l’avevano fermata un attimo per consolarla che non si disperasse, che l’avrebbero ritrovato e l’avevano trattenuta a bere un sorso di caffè per rincuorarla. Poi qualcuna l’aveva accompagnata a casa e in quel momento ella aveva notato nel cortile il paiolo pieno d’acqua appoggiato al muro, in un posto dove non doveva essere. Un sospetto l’aveva assalita ed era corsa di sopra, nella camera che si raggiungeva con una scala esterna o con la scala a pioli dalla botola. Là infatti l’aveva trovato, sdraiato per traverso sul letto con ancora le scarpe ai piedi, in una posizione innaturale. Aveva chiamato; le vicine erano accorse e avevano mandato per il medico che tardava ad arrivare.
Ma la diagnosi era già stata fatta per esperienza: probabilmente era stato un infarto. Si era sentito male e rientrando era salito a sdraiarsi. La moglie non l’aveva né visto, né potuto soccorrere.
L’uomo era benvoluto in paese, sempre disponibile, sempre pronto ad aiutare chi avesse bisogno. Tutti lo rimpiangevano e il torrente fu indicato a lungo con il ricordo della vicenda: “Al Rio dove il povero Pinìn s’è sentito male…”, un ritornello che si era sintetizzato col passar del tempo.
[continua]


