
Boulevard Circus & altre storie americanediGiovanni Crespi |
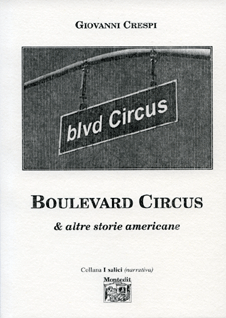
Collana "I Salici" - I libri di Narrativa
12x17 - pp. 60 - Euro 6,00
ISBN 978-88-6037-7555
 Libro esaurito
Libro esaurito
In copertina fotografia di Giovanni Crespi
A mio figlio
Di me non rimarrà nulla.
Solo un’ultima eco della mia voce che ti cerca
tra vecchie stanze. Vuote.
PREFAZIONE
Personaggi a tutto tondo sono quelli che colorano i racconti di viaggio “crespiani”. Personaggi che ricercano continuamente qualche cosa che va aldilà della loro comprensione. Personaggi in bilico, sullo sfondo di un’America libertina, tutta spazi sconfinati e rettilinei dove è impossibile dare tregua all’acceleratore. In un ambiente così desolante e al contempo così perfetto per quanti non hanno meta, lo scrittore disegna i suoi personaggi che ubriachi, intontiti, ebbri del loro dolore quanto dai boccali di birra tracannati o dall’immancabile vino “Made in Italy”, paiono svanire. Salvo poi ritrovarli in un paesaggio che improvvisamente riempie i loro occhi ancora velati dall’alcool, e così anche l’animo si scrolla di dosso per un attimo il dolore, si ristora di un calore immenso, di quell’appiglio per cui, in fondo, vale sempre la pena vivere, vale la pena esserci, vale la pena godere anche della più piccola delle cose. Perché «Non c’era nessuna guerra da combattere, nessun nemico da affrontare». Il “male di vivere” trova la sua formula più estrema proprio nei personaggi di carta che inzuppano i racconti di Giovanni Crespi. L’autore ne fa quasi una parodia di se stesso, ne immerge ogni tratto nel più buio degli anfratti, che «tanto a nessuno può fregargliene di meno». Giunti a tale ipotetica meta, allora, tanto vale riempire un vecchio di botte fino a farlo stramazzare, baciare una donna per poi bruscamente allontanarla, continuare a tracannare birra anche quando ormai i tuoi immaginari compagni di viaggio hanno ceduto la spugna. Nei racconti, quanto mai nitida e oggettiva, appare allora la società italiana quale essa è. Quella società che sotto la formula magica dell’imperativo americano, scalfisce, rode, intacca, penetra e si intrufola senza fare rumore nella famiglia perbenista e perfetta che non esiste più, che forse non è mai esistita ma della quale si è sempre costruita intorno una ragione di vita. Si sgretolano uno per volta i valori di un Novecento che ha dato fondo a tutte le sue risorse per farli capitolare nella toilette, per maschi o per donne o ancora unisex. Impossibile allora non essere trascinati, riga dopo riga, dentro quella fogna quale appare l’esistenza per alcuni, ma forse molti si sapranno riconoscere nei tanti Johnny o John, che “on the road” danno fuoco alla loro esistenza per poi ritrovarla, intatta, negli occhi del figlio dato alla luce anni prima. Convinti altresì che l’amore per la propria donna fosse l’amore per sempre. «Pet era per lui il bimbo più bello che avesse mai visto in giro in quei giorni passati lontano da casa, lo aveva confrontato con mille altri camminando lungo le strade di quella città che gli era diventata ostile, che gli aveva rubato gli affetti, lasciandolo solo con niente altro che aveva». Distolti, i tanti John, in un frangente ibrido, dall’amore, magari una fredda mattina d’inverno, mentre immobili fissavano una valigia sfilare davanti al proprio letto nuziale, colma di quegli indumenti femminili che tante volte avevano visti indossati. Incapaci in quell’istante di formulare qualsivoglia pensiero, anche il più banale. È indispensabile allora fuggire, di tanto in tanto, scegliendo la meta, in base a folli connessioni che vedono ad esempio nascere uno scrittore, letto e riletto, in un paesino sperduto in mezzo al nulla. È altrettanto indispensabile varcare i confini europei ed evitare, per quanto possibile d’imbattersi in un connazionale, che guarda caso il più delle volte è intento a leccarsi la medesima ferita. La ricerca è allora soltanto ricerca dell’oblio, mentre segnali fraudolenti di un passato alquanto irto, marcato da cicatrici indelebili e profonde, riemerge d’improvviso per affondare il coltello lì dove la ferita si era nascosta. Le donne sono parentesi vuote per lasciarsi andare e con altrettanta baldanza lasciarle rimanere ove non c’è nulla. Non si lascia loro nulla di sé, se non il ricordo del fetore di una bocca perennemente impastata dall’alcool, l’odore acre del sudore maschile in stanze fetide ai margini del mondo. Vivere in un mondo così non ha, però, alcun senso e il ritorno in se stessi è sempre accompagnato da colori e sfondi talmente belli, talmente intensi da togliere il fiato. Il viaggio dello scrittore è quello dentro la coscienza umana, un viaggio che ha dell’impossibile e comporta rischi d’ogni sorta seppure, talvolta, indispensabile per poter nuovamente assaporare il gusto, l’odore, la luminosità, il tocco dell’esistenza. «Aveva capelli biondi e occhi chiari… gli stessi colori di sua madre, e sapeva di buono».
Lo stile, fluido e scorrevole della scrittura, lascia spesso intravedere elementi del parlato che sforano nello slang, per conferire all’eccesso maggiore incisività ed espressività. Prevale comunque la naturalezza di certa terminologia che non stride all’orecchio del lettore, abilmente accompagnato dalla penna dell’autore a scendere nei sottoscala suburbani, dove ogni cosa è concessa al di fuori dell’eleganza e del pudore, che invece striderebbero alquanto di facciata perbenista. Colpiscono, nei racconti di Crespi, a dire il vero i pochi racconti scampati al gesto sconsiderato dello scrittore, di distruggerne buona parte, quel soffermarsi su particolari talmente sottili e quasi indiscreti, capaci però di donare al lettore uno zoom intrigante sul personaggio descritto. Sembra così di catturare il susseguirsi delle vicende o dei dialoghi attraverso l’obiettivo di una macchina da presa.
L’ambientazione è quella di un’America impersonale e restia a cedere il suo aspetto selvaggio al passaggio dei colonizzatori come a quello dei viandanti malconci, tutti irrimediabilmente toccati dagli spazi immensi. Nelle metropoli del nord si concentra, invece, l’essenza dell’operosità umana, per certi aspetti anch’essa straordinariamente affascinante.
Persino la contemporaneità dei racconti è caratterizzata dal vuoto incolmabile dei personaggi dei racconti, che in sé e attraverso il loro pensiero, ne delineano distintamente ogni squarcio. Gli innumerevoli cedimenti del viandante italiano, in collera con sé e con l’umanità, si esibiscono poi in tutta la loro alterigia in gesti di violenza inaudita, i quali non trovano spiegazione alcuna, nemmeno quando etichettati dalla cronaca dei quotidiani col felice termine raptus. Parola che indica da un lato un atto improvviso e violento di un malato ma dall’altro sta anche a significare il rapimento nel culmine dell’ispirazione poetica. L’episodio, anche quello di sangue, se inquadrato allora in una prospettiva a 360°, sembra più il frutto di un’ascesi mistica che non un atto di violenza fine a se stesso.
Angela Dussin
De “La tribuna di Treviso”
Boulevard Circus & altre storie americane
BOULEVARD CIRCUS
La strinsi tra le braccia e la baciai. Ero reduce da una scorpacciata di noccioline americane a Boulevard Circus, dove avevo appena lasciato i miei amici perditempo, giù per la discesa ripida che porta al mare, dove la puzza di piscio è insopportabile. Adesso cominciavano a darmi veramente fastidio, sia lei che quell’odore. La presi per le spalle e me la staccai di torno con un gesto inconsulto. Vidi i suoi occhi celesti guardarmi e dire “ma cosa fai?” Le lasciai un po’ di soldi e me ne andai. Volevo starmene da solo. Avevo più di quarant’anni, la pancia, e vestivo camicie da quattro soldi. Le donne mi evitavano e anche quelli che pensavo amici mi frequentavano di rado. Ero un caratteraccio. Si facevano vedere solo quando pensavano che avessi chissà cosa da offrire loro, e io quasi mai potevo dare qualcosa. Ero sfigato. Qualche volta li pensavo a luci spente.
Spesso camminavo per le strade del porto, come piace a me, testa bassa e mani dietro la schiena.
Guardavo gli uomini nei bar. Molti di loro erano scaricatori, mani grosse e tute sporche, restavano aggrappati a boccali di birra. Altri, più distinti nei loro abiti, parevano non toccare nemmeno per terra quando camminavano, tanta era la boria che avevano intorno. Mi sembravano dei leccaculo arrivisti. È così che si faceva! Non come me che non cavavo un ragno dal buco. Le loro donne belle, giovani, armeggiavano sigarette e si aggiustavano il vestito. Entrai in uno di questi posti con la scusa di bere qualcosa. Volevo vederne qualcuna da vicino. Seduto su uno sgabello davanti al bancone, presi un giornale e ordinai una birra. Tre ragazze stavano entrando, abbassai gli occhi sul giornale, facendo finta di leggere. Si avvicinarono per ordinare da bere. Quando alzai lo sguardo mi avevano già visto e dimostrarono tutto il loro interesse per me voltandomi le spalle. Parlavano fitte fitte rubandosi il tempo l’una con l’altra. Facevano bene a non considerarmi, non avrei mai potuto competere con loro, la mia voglia di fortuna non sarebbe bastata. Le ragazze non vanno mica in cerca di operai: loro hanno bisogno di avvocati, dottori e uomini d’affari. Noi ce le prendiamo quando sono brutte, stagionate e ammattite.
Bevvi in fretta e uscii. Continuando per la mia strada vidi un uomo che mi fissava, uno strano sguardo. Teneva un occhio chiuso e sforzava l’altro per cercare di mettermi a fuoco. Mi era molto familiare, ma chissà dove l’avevo già visto, in questa città così grande sarebbe stato praticamente impossibile rivedere due volte la stessa faccia. Io poi mi spostavo continuamente, conoscevo poca gente. Ero forestiero. Venivo dall’Europa e ancora mi chiedevo che cavolo ci facessi da quelle parti.
Frugando in una tasca trovai una sigaretta e mi avvicinai a lui per farmela accendere. Mi aveva incuriosito e la scusa era buona per vederlo da vicino. “Ehi amico, avresti mica da accendere?” Non se l’aspettava. Nervosamente e senza dire una parola agitò le mani dentro alle tasche. Capii che non fumava e anche che gli seccava non potermi accontentare. “Fa niente”, dissi, “troverò qualcun altro”. Ripresi la strada ma subito mi disse “non sei neanche tu di queste parti, parli strano, me ne sono accorto subito, da dove vieni?” “E tu?” Dissi. “Sono italiano, vengo dal nord-est dell’Italia.” “Bene, allora possiamo parlare anche il dialetto, perché anch’io sono di lì. Venezia.” Quando trovavo un mio conterraneo fuori casa dicevo sempre Venezia, anche se il mio paese distava una sessantina di chilometri da quella città che tutti conoscevano, ma era un ottimo riferimento. Poi, se era il caso, aggiustavo la mira e dicevo esattamente da dove venivo. Questa volta era proprio il caso, io conoscevo il suo paese e lui il mio, e anche qualcuno in comune. Non amavo per niente trovare compaesani in giro per il mondo, mi deprimeva. Cercavo sempre di frequentare persone di posti e ambienti diversi. Me n’ero andato anche per questo dall’Italia. Poi gli italiani sono appiccicaticci fuori dai loro confini. Non ti mollano, vanno avanti regolari a mangiare spaghetti e a lodare il Bel Paese. Saranno anche cose giuste ma io non le reggo.
Ci infilammo nel primo bar.
Ordinai una birra per me e una per il mio amico. Dovevamo bere qualcosa per parlare, eravamo tutti e due di poche parole e bere sarebbe servito. Tracannammo la prima birra d’un fiato, guardandoci intorno. La cameriera sorridendo portò altre due birre e per dovere disse: “Ci sono anche la bistecca e le patatine fritte.” Nessuna risposta. Mise in moto le sue grosse chiappe e andò a ripulire un tavolo. Iniziammo a parlare con molta tranquillità, nella nostra lingua, quasi scoprendo noi stessi per la prima volta perché eravamo lì, così lontani dai posti che ci avevano cresciuti. Ma senza piagnucolare o roba del genere. La cameriera capì ben presto con chi aveva a che fare, passava e portava altre birre, le andavamo a genio. Era divertita forse dal nostro modo di parlare e gesticolare tutto mediterraneo. Cominciavamo ad essere un po’ alticci e ridevamo senza motivo, poi ogni tanto fermavo l’espressione sul viso di quell’uomo, cercando di capire chi mi ricordasse, senza riuscirci. Pensai: a volte succede che una fisionomia o le movenze di qualcuno ci riporti a persone conosciute. Poi risi piano quando mi venne in mente che da piccolo io e i miei amici passavamo delle ore seduti su di un muretto a paragonare la gente che passava per la strada a degli animali: per la forma del loro viso, l’espressione o il modo di camminare. Lasciai perdere.
Feci un cenno a Mary, la cameriera, così la chiamava da dietro il bancone un tipo grosso e baffuto che aveva tutta l’aria di essere il capo. Lei arrivò, spostai una sedia per farla sedere. Disse che non poteva starsene lì a chiacchierare, ma che tra qualche minuto avrebbe staccato e si sarebbe fermata a bere qualcosa con noi. Il giorno dopo sarebbe stato il suo day-off. Sedette lo stesso in fretta, accavallò le gambe fuori dal tavolo come per scattare di corsa. Guardava i tavoli intorno, a un tratto prese il mio boccale di birra e diede una gran tirata. Si alzò e tornò in mezzo alla gente. Dan, così si chiamava il mio interlocutore, aveva due baffoni rossi, i capelli appoggiati alle spalle erano castani, e solo sulle punte avevano lo stesso colore dei baffi. Aprì il soprabito e da un taccuino tirò fuori una foto. Me la diede dicendomi che quelle erano le sue donne in Italia. La presi guardandolo negli occhi: c’erano una giovane donna mora, lui, e una bimba di tre o quattro anni, scura e riccioluta, bellissima, sorridevano senza guardare. Mi disse che la bambina era figlia di lei, lui era arrivato solo più tardi. Gli voleva un gran bene ma alla fine se ne andò. Un brivido mi attraversò il corpo, restituii la foto e cercai di parlare d’altro. Lui capì subito. Eravamo entrambi scappati da qualcosa. Preferivo ubriacarmi che parlarne. Mary finì il suo turno, si infilò una giacca e venne da noi. Ci presentammo: Dan, Mary e Johnny. Gli americani mi chiamavano Johnny, era il diminutivo del mio nome tradotto nella loro lingua. Ma mi sa che anche Dan e Mary erano nomi di fantasia, lui italiano come me e lei polacca. Non credo proprio esistessero quei nomi dentro ai loro confini. Bellissimo, eravamo come invisibili, immaginai che avessimo perduto le nostre identità, a chiunque ci avesse fermato e chiesto di noi avremmo potuto rispondere: “No signore, guardi che si sta sbagliando, non siamo quelli che lei crede. Vada a rompere le palle da qualche altra parte!” Mary voleva andarsene subito da quel posto, la capivo, allora dissi “l’ultima in piedi e poi via”. Non mi ascoltarono, ci avviammo al bancone, pagai e ordinai comunque un’altra birra, Dan non voleva più niente e Mary non vedeva l’ora di filarsela. La mia bevanda paglierina era servita, stupenda: schiuma giusta, bollicine perfette e goccioline tutt’intorno al bicchiere. Ma io dovevo andare in cesso. Mary me lo indicò. Trovai una porta a soffietto e ci misi un poco a capire come funzionava. Avevo perso un po’ della mia proverbiale lucidità. Usai il bagno e uscii, avvicinandomi al bancone non volevo credere ai miei occhi: c’erano rimasti solo un paio di centimetri di birra nel boccale. Guardai prima l’uno poi l’altra. Si guardarono, complici. Non seppi mai se era stato Dan l’ubriacone o Mary la spugna. Uscimmo. La strada umida e lucida sotto le luci della sera ci trovò alquanto brilli. La ragazza doveva aver bevuto di nascosto durante il lavoro, poiché anche lei non mi sembrava propriamente sobria, oppure più semplicemente era il suo modo di essere: pareva un po’ svampita e ingenua, ma certo era simpatica e carina. A Dan piaceva sicuramente. Si prendeva spesso la briga di tornare sui discorsi per spiegarle qualcosa che non aveva capito. Neanche stessimo filosofando.
Aveva un viso minuto, un nasino a punta e due begli occhi chiari. Il trucco esagerato e i capelli biondi e corti che lasciavano vedere due grossi orecchini. Il seno piccolo e sostenuto era quello di una giovane donna, le spalle strette non erano proporzionate al sedere e alle cosce, decisamente grosse, ma era alta e nel complesso niente male. Dan aveva una macchina alla fine di Boulevard Circus, all’incrocio con Pasadena Avenue. La raggiungemmo. Era una Continental grigia del ’79. Mary salì dietro e Dan si mise alla guida, io stavo al suo fianco. Avviò il motore e andò incontro alla città. Los Angeles era un posto infinito, ombre di vecchi indios dai volti scuri vagavano sui marciapiedi. Era la California dei messicani. Si accalcavano alle fermate degli autobus, le donne tenevano per mano i loro bambini e gli uomini si guardavano intorno come forestieri nella loro terra. Avevano attraversato pericolosamente la frontiera a Tijuana o nel deserto di Sonora. Adesso vendevano tortillas e tacos per la strada o lavavano piatti nei ristoranti.
Dan non aveva idea di dove andare, Mary voleva andarsene e basta. Io dissi “Big Sur”.
“Big Sur?” Ripeté Dan, “che cavolo di posto è?”. “Gira la macchina, si va verso nord, prendi la 101. Direzione Frisco.” Dissi senza interessarmi se a loro andava bene.
Prendemmo la “One o One”, sognavo da sempre di andare in quel posto. Per me era diventato importante da quando ci aveva vissuto il “guru” Henry Miller. Jack Kerouac ci aveva scritto un libro.
Attraversammo paesi e paesi, uomini alti e magri lavoravano nei campi, salivano e scendevano da enormi macchine, avvolti in una debole luce. Poi di nuovo il buio terribile. L’aria tersa ci mostrava stelle e astri brillare sopra le nostre teste. L’orizzonte era sgombro, libero come l’America dei nostri sogni. Avremmo seguito anche il diavolo, ovunque ci avesse portato. Dan guidava senza preoccuparsi di niente, pareva di un altro mondo e pensai davvero che lo fosse. Mi girai a guardarlo cercando di capire perché, fin dal primo momento che lo vidi, fui attratto da lui, perché mi avvicinai con la curiosità di parlargli. Adesso non mi bastava più l’idea che mi ricordasse qualcuno. Ebbi la netta sensazione che quell’uomo mi stesse cercando. Si voltò a guardarmi, sentiva i miei occhi su di lui. Dissi “facciamoci una birra, ci sono delle lattine qua dietro”, “bene, prendine un paio”, rispose. Mary si era addormentata, accovacciata sul sedile con le mani sotto la guancia e le ginocchia sul petto. “La ragazza dorme”, dissi. Dan annuì distrattamente, senza aver capito. Sfilai due birre da sotto i piedi di lei. Ad un tratto, come venuti da chissà dove, una paletta e due stivali in mezzo alla strada ci fecero sobbalzare. Il poliziotto aveva un braccio dritto a indicare il bordo della strada, nella mano destra impugnava la paletta e ci faceva segno di accostare e fermarci. Dan accostò proprio davanti alla macchina della polizia, fino a quel momento invisibile.
Presi d’istinto la lattina di birra dalla mano di Dan, e insieme alla mia le nascosi tra il sedile e i miei piedi, sperando che quelle dietro si volatilizzassero per opera di qualche buon samaritano che tanto aveva pregato per noi, o meglio ancora che l’ombra della notte ci aiutasse. In un attimo mi scrollai di torno quella mezza sbronza che avevo, sperando che per il mio autista fosse lo stesso. Nel Paese libero non era ammesso guidare da ubriachi.
Solo ora si accesero i fari della loro macchina, insieme alle luci colorate e lampeggianti. Riuscii a vedere dallo specchietto retrovisore l’uomo che ci aveva fermato avvicinarsi a noi. Una mano nella fondina e nell’altra una torcia elettrica. Si fermò di colpo quando vide spuntare da dietro il sedile l’ombra di un’altra testa. Mary si era svegliata e tirata su chiedendo “Che succede?” Lo capì da sola. Dopo un attimo di esitazione l’agente riprese la sua camminata, piano piano, lento lento. Non c’era da ridere a fare i poliziotti da quelle parti. Sorprendendoci puntò la pila sul finestrino dietro. La ragazza mise le mani davanti agli occhi, lui aprì lo sportello, puntò con la luce le ormai famose lattine di birra e disse: “Buonasera signori”. Inquadrò anche noi e ci chiese gentilmente di scendere. Per me aveva più paura delle sue vittime. Uscimmo dall’auto mentre l’altro suo collega ci raggiunse. Era giovane, non tanto alto e tarchiato, il primo invece era parecchio più vecchio, con due baffi grigi e pochi capelli. Lo vidi togliersi il berretto e passarsi una mano sulla testa.
“C’è della roba da bere in macchina”, disse rivolgendosi all’altro che ci stava squadrando. “Bene, prendi quella roba e mettila in macchina da noi. Non possiamo lasciare che la gente vada in giro per le strade a sbronzarsi e a fare un mucchio di casini. Noi siamo tutti i giorni e tutte le notti su queste maledette strade, da una parte all’altra dello Stato. Un sacco di poliziotti ci rimettono la pelle per gente come voi: chi spara, chi fa le rapine o chi si ubriaca.” Continuò scaldandosi. “E tutto per cosa? Per una paga da fame! Che credete? Anche noi vogliamo tornare a casa nostra la sera e abbracciare le nostre mogli e i nostri figli. Anche noi vogliamo passare le feste con le nostre famiglie, mangiando il tacchino e la torta! E invece no, ci tocca sempre fare gli straordinari per…”. “Adesso basta!”, redarguì aspro quell’altro. “Mi hai fatto venire in mente di aver promesso a mia nipote che sarei rientrato subito dopo il mio turno.”
Così, fermo e deciso, zittì il più giovane, che nervosamente si allontanò da noi di un paio di passi, quasi per prendere la rincorsa e tornare a una imprevista carica con una sventola violenta sul viso di Dan, che barcollò e si rimise in piedi, senza dire una parola. Io alzai le spalle e ci misi la testa in mezzo. Mi aspettavo lo stesso trattamento. Invece il ragazzo, perché era un ragazzo, tenendosi la mano indolenzita si avviò in fretta alla macchina e vi salì. Chiuse lo sportello così come un attimo prima aveva chiuso i conti con la sua frustrazione quotidiana. Nel silenzio che seguì ebbi anche il tempo di pensare che per me non era che un sordido esistenzialista. Uno che si angosciava nel considerare la sua limitatezza, che è della realtà umana.
“Bene ragazzi, andatevene di qua e cercate di non fare cazzate. Le birre le teniamo noi. Vi assicuro che è il minimo che posso fare. Un’ultima cosa,” disse rivolgendosi a una Mary impaurita, “tu sei qui perché lo vuoi o ti ci hanno costretta?” “No… no… sono con loro,” disse a mezzavoce lei. Dan girò intorno alla macchina con una mano sulla guancia e l’altra appoggiata al cofano. Dimostrando a quel modo tutto il suo disagio, montò su. Salutai il poliziotto con un cenno, quasi a ringraziarlo per averci risparmiato il peggio. D’altra parte lui mi era parso senza cattiveria fin da subito. Per una volta le cose si stavano mettendo al meglio per noi, che andavamo in una direzione benché il mondo andasse da un’altra parte. Avevo visto non molto tempo prima, in una metropoli del nord, orde di poliziotti agguerriti muoversi freneticamente per braccare qualcuno. Mi si accapponò la pelle e salii in macchina. Big Sur e i suoi fantasmi non si erano mossi di lì. Avremmo dovuto raggiungerli noi.
Ripresa la strada nessuno dei tre parlò più, almeno per un bel po’. Guardavamo fissi in avanti la notte oltre il vetro, gli alberi erano neri come l’asfalto che correva veloce sotto la macchina. Anche il tempo correva e l’alba arrivava con noi a El Sur Grande, così i messicani chiamavano quella terra, ricca di vegetazione, verde e selvaggia. Prima di noi solo i colonizzatori Pfeiffer Ridge, Post Summit, Cooper Point, Dani Ridge e Partington Cove. Diedi un’occhiata a Dan. Alla stranezza del suo volto. La bellezza di quella natura appesa alle prime luci del giorno e il drammatico incontro tra la terra e il mare in quel posto, mi fecero scoppiare dentro. Mary si stese dietro come per lasciarci soli, perché quello era il suo ruolo, la sua parte. Doveva restare ai margini e accompagnarci a un incontro. Chi avesse deciso questo non si sapeva. Ma io stavo capendo. Avevo al mio fianco un uomo almeno dieci anni più giovane di me, anche se quando mi lasciò ne aveva almeno cinque di più. La mia vita era continuata, per lunghi anni mi ero estraniato da tutto e da tutti, tornavo solo per pagare le bollette. La sua, di vita, si era fermata prima, all’età che dimostrava. Nel flashback di pochi attimi rividi le nostre vite. Mia e di mio fratello, che dopo molti anni dalla sua morte era venuto a cercarmi, simile a un angelo. Si voltò e mi guardò, senza cercare in me né un senso di eternità né un dio. Ma semplicemente come un fratello più grande guarda il fratello più piccolo. C’erano in quegli occhi: amore, desolazione, tristezza. Ma sopra ogni cosa la felicità di essermi stato vicino, ancora una volta, in un angolo di mondo che io avevo scelto. Dimenticai di vagare come uno spettro attraverso l’incubo della vita, non mi sentivo più né un miserabile, né indifeso né nudo.
[continua]


