
Undici racconti geograficidiArnaldo G. Savini |
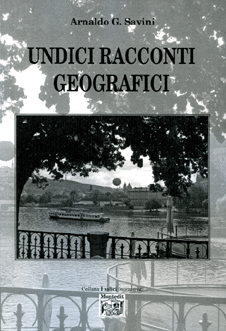
Collana "I Salici" - I libri di Narrativa
14x20,5 - pp. 86 - Euro 9,00
ISBN 978-88-6587-1225
Clicca qui per acquistare questo libro
In copertina: fotografia dell’autore
Premessa
Questi undici racconti sono stati scritti (eccetto «Un Natale» che è del 1988) tra la primavera del 2007 e quella del 2011 e sono nati, come molte cose letterarie, quasi per caso. Il caso o, diremmo meglio, la molla che ha fatto scattare in me l’idea, è stata la notizia, captata durante un telegiornale, del paradossale ladro di biciclette che ha dato lo spunto al racconto “Bologna-Modena e ritorno”. L’idea di partenza era quella di redigere, a corollario dei testi, delle cartine geografiche parafrasate, con le indicazioni dei luoghi e dei tragitti tra di essi; la faccenda è stata poi tralasciata per manifesta impossibilità realizzativa, tuttavia l’ispirazione di fondo è rimasta nell’impostazione dei pezzi. Nutro fin da ragazzo la passione per la geografia, materia purtroppo sempre più negletta sia nelle scuole (anche molti insegnanti, per loro esplicita ammissione, non la conoscono più) che nella vita di tutti i giorni, e la cosa mi pare ancora più insensata nella nostra epoca contrassegnata da continui viaggi e spostamenti non più solo tra città e città ma tra un continente e l’altro, fino a raggiungere le mete più remote e improbabili. Il fatto è che più che viaggiare oggi ci si fa trasportare, direi quasi catapultare sul luogo prescelto: si sta perdendo quel che di più bello c’è nel muoversi, il piacere del viaggio, dell’essere “in itinere”. Nei racconti qui proposti la meta non è il punto d’arrivo, anzi questo talvolta manca del tutto; non sono diari di viaggio ma cataloghi di luoghi, una sorta di manuale di geografia rielaborata secondo il ritmo interiore di pensieri e riflessioni. Ci sono posti legati a un ricordo, a un’impresa sportiva, a un’avventura vera o sognata, luoghi reali e immaginari o mescolanze fra di essi, addirittura luoghi che tali non sono più o non sono mai stati. Luoghi che diventano pretesti per raccontare cose disparate, nell’eterna ricerca di un altrove che, alla fine, si può trovare solo in se stessi.
Undici racconti geografici
BOLOGNA-MODENA E RITORNO (in manette)
Difficile capire perché vengono certe idee; probabilmente non c’è nulla da capire, vengono e basta, inutile lambiccarsi tanto il cervello. Così dev’essere successo a quel tale – lo chiameremo Alfa – che un giorno, andando per chissà quale n-centesima volta in treno da Bologna a Modena, non sapendo proprio più cosa inventarsi per movimentare ancora un po’ le sue giornate di sfaccendato, ha messo insieme tre o quattro concetti, li ha ben centrifugati in qualche remota zona degli emisferi cerebrali e ne ha ricavato questa bella pensata: “Tornare in treno è monotono, mi costa altri soldi e sono quasi al verde, è una bella giornata di mezza estate, ho appena quarant’anni e gambe buone, ho voglia di un’esperienza diversa e a suo modo esaltante, perché non scendere allora con apparente noncuranza alla stazione di Modena dove nessuno mi conosce, girare un po’ mescolandomi alla folla degli indaffarati viaggiatori, approfittare della confusione per scegliere una bella bici veloce ma non troppo lussuosa per non dare nell’occhio (c’è sempre qualcuno che non si fa gli affarazzi suoi), montare in sella con disinvoltura e… via! filare dritto lungo la via Emilia rettilinea fino a Bologna, una bella tirata di un quarantina di chilometri tagliando a mezzo l’ubertosa pianura e altre frescate del genere che avrebbero fatto poi la gioia di chissà quanti cronisti di provincia. Detto, fatto: certe cose – come si diceva appunto all’inizio – vanno fatte d’impulso, agite senza stare lì tanto a rifletterci sopra, altrimenti finisce che non le fai mai”.
Alfa dunque scende dal convoglio, si mescola alla folla sbracciata e anche un poco sbracata dell’agosto lasciandosi trasportare verso il centro quasi senza accorgersene, tanto che a un certo punto perde di vista l’aerea e svettante sagoma della Ghirlandina, suo vitale punto di riferimento. Si trova comunque in pieno centro, nel parcheggio di piazzale Roma. Inizia la ricerca del suo veicolo, quello che l’avrebbe riportato nella sua Bologna; ma non sarà una ricerca semplice. Gliene piacciono tante – e intanto una sbirciatina alle ragazze, gliene piacciono molte pure di quelle e lotta per non lasciarsi troppo distrarre. La scelta è ardua.
Inizialmente pensa a una mountain-bike, ce n’è esposta una gamma pressoché infinita; poi la sua attenzione si focalizza su alcuni velocipedi tradizionali, le cosiddette bici da città: quelle fanno al caso suo! Le gomme più sottili, la sella spaziosa, senza tutti quei cambi e moltipliche che rischiano farti scendere la catena a smanettarci su troppo. Ce n’è una bellissima, semi-nuova, praticamente è amore a prima vista; unico problema, un luchèt acsé! Come fare a liberarsi di quel catenone che la tiene bloccata al palo della luce? Non è uno scassinatore, Alfa, benché qualche piccolo precedente ce l’abbia, più che altro non dispone degli attrezzi del mestiere né della necessaria destrezza. È un semplice disoccupato, ex-manovale in una fabbrica di bottiglie che ha chiuso: chi usa più le bottiglie di vetro? A malincuore si allontana dall’oggetto del suo desiderio e si rassegna; non potendo scegliere deve accontentarsi della prima facilmente asportabile, fosse pure un ferro vecchio. Non ci mette molto a trovarla, in una viuzza laterale ce ne sono una decina appoggiate al muro: due sembrano senza chiusura. Alfa sceglie la meno peggio, una Legnano che potrebbe avere una ventina d’anni, ma tutto sommato in discrete condizioni. Ha un vecchio cambio sulla canna a tre velocità, forse incriccato ma tanto – riflette – per pedalare in pianura basta e avanza. Si avvicina circospetto, nella via ombrosa non passa nessuno. Alza lo sguardo a 360°, anche le finestre sembrano sonnecchiare. La abbranca deciso, come fosse il legittimo proprietario, sale e inizia a pedalare morbidamente, quasi con impaccio. Si accorge subito però che il mezzo risponde bene, la seduta comoda, perfino il cambio funziona. Un senso di ebbrezza lo pervade; supera di slancio Largo Garibaldi, punto nodale. Non c’è un gran traffico, così svicola agilmente e si ritrova già sull’Emilia. L’avventura ha inizio, trentanove chilometri di piacere e vento sulla faccia.
La pedalata è fluida, anche perché la velocità rimane bassa: non è allenato alle lunghe distanze, prudentemente evita di spingere a fondo. Sono le quattro di un pomeriggio di agosto, la gente è in vacanza, il traffico ridotto al minimo: poche auto, pochi camion, qualche furgone. Più che altro moto, che lo superano rombando rumorosamente. In meno di mezz’ora Alfa raggiunge Castelfranco, grosso paese agricolo della bassa modenese; si ferma un minuto per un bisogno fisiologico e riparte. Approssimativamente calcola una velocità media appena superiore ai venti all’ora, perciò quasi due ore per arrivare a destinazione. Si sente bene, decide di provare ad aumentare un po’: innesta il rapporto lungo – fino a quel momento stava sul medio e doveva vorticare le gambe – e affonda sui pedali. Fa caldo ma la fatica la sopporta bene; solo una leggera sete. “Mi fermerò a bere qualcosa al prossimo bar” pensa. Dopo poco nota un trombino dell’acqua a bordo-strada dal quale è appena ripartito un altro ciclista, uno serio però, a giudicare almeno dalla tenuta stile Giro d’Italia. Smonta in fretta, beve due sorsate e riparte. Il collega elegante non è molto avanti, la strada rettilinea gli permette di tenerlo a vista; non ha più di mezzo chilometro di vantaggio, meno di due minuti.
Ad Anzola la stanchezza comincia a farsi sentire, ma siamo ormai a due terzi del percorso; il ciclista di poco prima è avanti poche decine di metri, significa che il nostro ha compiuto un recupero formidabile, l’andatura è dunque aumentata decisamente. Appena fuori dall’abitato lo raggiunge e gli si mette in scia. Guarda l’orologio: le cinque e dieci, trenta chilometri in settanta minuti, niente male per un principiante. Siamo ormai alle porte del capoluogo, bisogna fare attenzione a non infilarsi in qualche svincolo e finire in tangenziale in mezzo agli autotreni: sarebbe un disastro. Ma Alfa conosce bene la sua città e non sbaglia. L’avversario invece, temendo forse l’oltraggioso sorpasso da parte di una normale bici da turismo, s’infila in una traversa sulla destra e scompare in Borgo Panigale. Alfa non ci fa quasi caso e continua a macinare strada con lena lungo l’Emilia Ponente; al centro non mancano più di tre chilometri. Infila Porta san Felice come una freccia, non rispettando nemmeno la precedenza: fortuna c’è poco traffico e nessun vigile. All’imbocco di via Ugo Bassi torna a consultare l’orologio: meno di un’ora e mezza. Ancora pochi minuti ed eccolo, trafelato e felice, in piazza Maggiore: sono le cinque e trentacinque. Si butta sulla poltroncina di un bar e ordina una birra fresca; è in uno stato di esaltazione e di appagamento al tempo stesso, le endorfine alle stelle. Sorseggia la bibita e intanto pensa che la prima cosa da fare è liberarsi (a malincuore) della bici. Guai se lo vedesse qualche conoscente con un mezzo così bello, si porrebbe subito la domanda: “Dove ha preso un barbone come Alfa i soldi per comperare una bici così?” L’appoggia semplicemente a un muro e si avvia a casa a piedi, non senza averle lanciato un ultimo languido sguardo come a una fidanzata irrimediabilmente perduta.
“Domani riposo, ma dopodomani miglioro il record” si propone mentre varca la soglia di casa. L’indomani invece è tutto un rottame, i muscoli gli dolgono, anche quelli delle braccia e del torace, perfino il collo e le varie giunture. Passa una notte agitata, rimane a letto tutta mattina, si sente caldo, misura la febbre: trentotto e due. Nel pomeriggio migliora, si alza alle quattro con una fame bestia; esce al supermercato sotto casa e fa provviste con i 50 euro rimasti della pensione di sua madre morta due anni prima: finché riuscirà a farsela dare, poi dovrà cercarsi di nuovo un lavoro. L’indomani sta ancora meglio, solo qualche residuo indolenzimento: decide di rinviare ancora.
Il giorno successivo è un leone; alle due e trenta, con un’afa asfissiante sale sul treno per Modena, gente in giro pochissima. Giunto in città, ricomincia la trafila della ricerca del mezzo a pedali. Questa volta nella viuzza non c’è nulla di buono e poi sono tutte sigillate a doppia mandata (evidentemente i modenesi hanno preso le loro brave contromisure). Dopo un’ora di indagini Alfa scova finalmente una mountain-bike decente e libera; ha due levette per i rapporti al volante, certo è più moderna di quell’altra. La leva di sinistra – quella della moltiplica – decide di non toccarla, per evitare che salti la catena, tanto è sulla ruota dentata grande che in pianura va benissimo. Il sellino è un po’ duro, ma ci si adatta. Sono le quattro e mezza quando riesce a partire, l’intenzione è di essere a Bologna entro le sei. Prudentemente si è portato una borraccia d’acqua ormai tiepida, in modo da non doversi più fermare a bere lungo la strada. A Castelfranco ha già un vantaggio di un paio di minuti sulla tabella di marcia, che ad Anzola salgono a cinque; alle porte di Bologna affianca due amatori sessantenni che si lasciano superare esterrefatti da tanta baldanza. Taglia l’ideale traguardo in Piazza Maggiore nel ragguardevole tempo di un’ora e ventotto, ben sette minuti meglio della volta precedente. È a suo modo un piccolo trionfo, la gente lo osserva incuriosita mentre si pavoneggia come un vincitore di giornata al Giro.
Nell’arco di un mese Alfa effettua altre quattro o cinque prestazioni, migliorandosi ancora di alcuni minuti; giunto a un’ora e diciannove tuttavia (una media quindi intorno ai trenta Km/ora) si pianta e comincia a peggiorare. Decide allora di cambiare, provando una distanza più lunga per aumentare la resistenza. Siamo a metà settembre e il clima più mite allevia parzialmente la fatica; anziché a Modena scende a Reggio, ventitré chilometri più a ovest. Lo aspetta perciò una pedalata di circa 62 chilometri; l’obiettivo è quello di stare nelle due ore, ma sa anche lui che è proibitivo. Fino a Modena riesce a stare in media, poi il ritmo cala progressivamente, deve fermarsi a bere al vecchio trombino perché la borraccia è vuota, le tre zollette che ha portato non bastano di certo a contrastare il calo di zuccheri. Le gambe sono sempre più molli, giunge davanti al Nettuno allo stremo delle forze, con la voglia di buttarsi letteralmente nella fontana: ha accumulato un ritardo di quasi un quarto d’ora.
Nel frattempo è un vigile urbano, Beta, ad avere i primi sospetti; è già qualche settimana che ha notato quel disperato arrivare in centro a tutta birra, sempre in sella a una bici diversa. Non ha difficoltà a prendere informazioni, oltretutto abita più o meno nella stessa zona, lo identifica facilmente. Un giorno decide di seguirlo a distanza, sale sul treno, lo pedina fino a Modena. Lo vede agguantare l’ennesima bicicletta da città e sfrecciare soddisfatto verso il capoluogo. Lascia passare qualche giorno, non sa cosa fare, prende tempo; capisce di avere a che fare con una persona innocua, alla fine il senso del dovere però prevale. Insieme a due colleghi organizza un mini-posto di blocco all’inizio di via Ugo Bassi. Alfa arriva sparato, dopo la debacle di Reggio si è ripreso, adesso è in media-record; quando si trova la paletta del vigile davanti alla faccia è disorientato, sulle prime pensa sia rivolta a qualche automobilista indisciplinato, rallenta un momento e poi prosegue. Sta per riprendere il ritmo ma poche centinaia di metri più avanti è un collega di Beta a placcarlo risolutamente, facendogli rischiare un ruzzolone: “Alfa fermati – gli intima a gran voce – sei in arresto”. Lui allora si blocca, ancora incredulo e pure contrariato per i modi bruschi con cui gli hanno impedito di migliorare il record. Dice solo:” Cosa c’è, andavo troppo forte?”
DOVE COMINCIANO LE COLLINE
Le colline cominciano dove la pianura finisce: detto così, il concetto è elementare. Ma c’è un punto preciso in cui la pianura finisce? Certamente no, almeno non in modo tanto netto, ci può essere tutt’al più una linea o una striscia di terra a segnare la demarcazione. Una linea ovviamente non retta ma zigzagante, ondulata, frastagliata, una striscia che ora si allarga ora si restringe, dunque entrambe imprecise, indefinite. In una certa zona hai l’impressione che le colline finalmente inizino, la terra prende visibili ondulazioni, sale di alcuni metri ma poi d’improvviso ritorna giù, dopo poco si spiana nuovamente. Non è dunque lì che cominciano le colline, lì c’è solo un abbozzo, un tentativo, un leggero innalzamento del suolo che parrebbe fine a se stesso. Poi la ricaduta, come una malattia che tutto annulla nel suo monotono ripetersi. La pianura è certo malata, di questa malattia tutta moderna, tuttavia è dura a morire, ha una fibra resistente; è simile all’entropia verso cui ogni forma vivente dotata di energia ineluttabilmente tende, prorogando però all’infinito il momento finale.
È certo più facile esistere piattamente, perpetuarsi senza sussulti; collina invece è variare, diversificarsi, imprigionare energia nelle zolle per poi esploderla in forme geometriche il più delle volte tondeggianti, altre lineari o spezzate. C’è maggiore spreco, ma è molto più divertente.
Colline ne esistono di vari tipi: moreniche, lento ammonticchiarsi nei millenni di scorie glaciali; marnose, accumuli calcarei suscettibili di sbrecciarsi e sfarinarsi in calanchi e orridi vertiginosi; metamorfiche, dense di scisti e conglomerati rocciosi. Non devono, per convenzione geografica, superare l’altezza di seicento metri, anche se spesso non è possibile contenere la tentazione di farsi montagna, ergersi altezzosamente sopra il livello consentito, elevarsi oltre la massa delle ex-consorelle. Eppure, di contro, esistono aree collinose vaste centinaia di chilometri quadrati e mai che nessuna sgarri in altitudine di un solo centimetro, pena l’espunzione dall’ordine di appartenenza. La pianura da una parte, col suo richiamo all’annullamento nell’indistinto, la catena montuosa dall’altra, con le sue vette scintillanti e inattingibili; loro là nel mezzo, a consistere in tale zona intermedia, sorta di terra di nessuno, delta che non può per definizione divaricarsi oltre. È una sfida la collina, saper rimanere in bilico come sopra un’immensa asse d’equilibrio. Quando il rischio è l’eccessivo innalzamento è necessario ricorrere a tutto il proprio autocontrollo, saper contenere questo surplus energetico che spinge ad attingere altre quote, a toccare cieli troppo remoti e rarefatti. Se al contrario c’è in agguato il cedimento, l’inopinato sprofondamento nel baratro di forre che portano diritte agli abissi della terra, allora bisogna saper resistere, fare appello a tutte le risorse disponibili per non indulgere alle seduzioni perfide di questi imbuti aperti, pronti a risucchiarti nei gorghi degli ipogei.
Le colline spesso mascherano la propria sorgente; a volte la linea di demarcazione è il breve corso di un ruscello, altre un filare di alberi, addirittura una pianta isolata. Basta un terrapieno, un piccolo corrugarsi del terreno a dare il via a un sipario di ondulazioni. Dall’albero può nascere un altro albero, quindi un boschetto; il bosco lentamente procede, si arrampica sulle pendici della collina, ne rafforza la struttura, ne ricopre la sommità. Talvolta il rilievo è spoglio, battuto dai venti, inospite e funge da spartiacque tra due vallate contigue, due solchi incisi dall’erosione millenaria; il cocuzzolo allora diventa luogo d’elezione di un castello, una fortezza posta nei secoli antichi a baluardo contro indesiderate intrusioni. Ci sono altresì zone collinari di cui nessun indizio lascia presagire il principio; sorgono così, inaspettate, senza un motivo che ne giustifichi la presenza, addirittura in spregio ad ogni logica previsione, come certi alberi allignano sui terreni meno favorevoli. Non si sa dove andranno a parare; alcune si può quasi dire che abortiscano, spegnendosi pochi metri più in là. Altre fioriscono rigogliose e incapaci di trattenere la loro esuberanza sfociano poi in catene montuose, picchi stagliati contro il blu o perennemente coperti da una coltre di nubi. Molte si arrestano a quote modeste, non più di 200-300 metri e mantengono questo standard finché possono, poi iniziano piano piano a decrescere fino ad estinguersi dentro un lago o in una landa paludosa.
Come molti viventi, anche le colline hanno le loro soglie psicologiche, limiti oltre i quali non è dato spingersi. La stessa soglia iniziale può avere un risvolto psicologico: per alcuni l’altura nasce in un determinato punto, per qualcun altro un po’ più in là, più a est o a ovest, per altri ancora manca un riferimento preciso e non si può parlare di un punto esatto, come per la sorgente di certi fiumi che ancora è oggetto di diatriba tra nazioni. Si può così affermare che certe colline, al limite, sono un’opinione, talmente basse e indifferenziate da confondersi con semplici cumuli terrosi, riporti di escavazioni intorno ai quali, nel tempo, è cresciuta una rada vegetazione. Colline artificiali per movimentare un parco, accogliendo le capriole dei bambini e le corse dei cani, facendo credere di essere dove non si è. Oppure colline come tumuli funerari, ammantate del mistero di antichi popoli scomparsi tra i flutti della storia.
Per chi è cresciuto in pianura, anche le appena percettibili ondulazioni di una marcita possono costituire un motivo di bio-diversità, un piccolo viaggio in ambiente esotico. Per un montanaro invece anche un colle di 500 metri sembra una depressione, una zona in cui la montagna si è affossata in una sorta di catabasi. Anche questa una questione psicologica, di approccio al problema, di diverso angolo visuale.
Se già arduo è stabilire il momento in cui la collina comincia, figuriamoci dire con sicurezza dove finisce. Naturalmente è anche facile affermare che la collina non finisce mai se è sufficiente un rilievo di pochi metri – o centimetri – a segnare la discontinuità col piano. Da un punto di vista strettamente geometrico, tuttavia, è la pianura a non esistere, pure qui stiamo nel campo delle convenzioni. Esiste semmai tutto un continuum di alti e bassi, innalzamenti e bradisismi, micro-salite e micro-discese che fanno delle terre emerse tutto un falsopiano. Ne sanno qualcosa i ciclisti, lesti ad avvertire nei muscoli il sovrappiù di sforzo che la pur minima salita comporta, o l’allentarsi della tensione appena ha inizio la discesa. Restiamo sempre di poco elevati rispetto al livello del mare e questa – nei giorni di calma di vento – è forse l’unica superficie realmente piana, per quanto piccole increspature siano comunque inevitabili. Ecco, qui forse il cerchio si può chiudere: non è infatti scorretto asserire che, a conti fatti, la collina non può finire che nella vastità del mare, come un fiume di terra sfocia in ampio estuario. Dal grande pelago, di tanto in tanto, si rialza come un’isola d’orgoglio, rinnovando all’infinito l’incorrotto mito di Atlantide.
[continua]


