
Manuale del disperatodiAlessandra Crabbia |
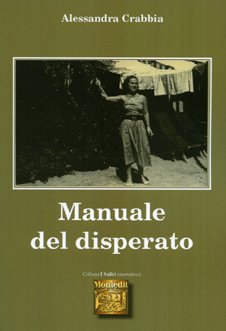
Collana "I Salici" - I libri di Narrativa
14x20,5 - pp. 122 - Euro 12,00
ISBN 978-88-6587-2789
eBook: pp. 93 - EURO 5,99 - ISBN 9788865873663
Clicca qui per acquistare questo libro
In copertina: «Adriana» fotografia di proprietà della famiglia Crabbia Ferrari.
Ogni somiglianza a persone, eventi, luoghi e nomi è
puramente casuale e frutto della fantasia dell’autrice,
che non si è ispirata a nessuna persona vivente,
né ad alcun fatto realmente accaduto
Prefazione
Alessandra Crabbia ha dentro di sé una ribellione incontenibile ed un caos emozionale così stupefacente che non riesco a concepire come il suo animo possa sopportarli.
Nelle sue parole, capaci di creare “emozioni” attraverso frammenti esistenziali che si ricompongono come a seguire un rito propiziatorio, troverete tutto ciò che vorrete.
Lei rappresenta l’essere umano agli albori del mondo, costantemente alle prese con la propria natura selvaggia e geneticamente attratta dal folle rimescolamento delle pulsioni.
Condurre le tensioni al limite ultimo, assaporare la contraddizione del vivere, sentire nel proprio sangue il senso di estraneità, fino a liquefarsi con il fuoco stesso che la divora.
Giorno dopo giorno, pagina dopo pagina.
Nasce in me il dubbio: raccontare ciò che potrete leggere in queste pagine incendiarie o tacere e lasciare a Voi la sorpresa.
Non v’è dubbio che il Tempo non si può sconfiggere, né annullare. Eppure, senza neanche accorgersene, ci si può abbandonare alle sue lusinghe: lei conduce “oltre” e tende al superamento del nulla, a fermare, nell’istante eterno, l’incanto dell’amore, unica via salvifica concessa all’essere umano.
Nelle sue parole vi sono la tragedia della vita, la grazia dell’Essere, la disperazione dell’esistere ed il piacere della carne: tutto diventa purificazione attraverso la scrittura, che permette di superare il fuoco divoratore e annullare ciò che è frutto delle inquietudini.
È come essere condotti, lentamente e profondamente, fino ad una piacevole incoscienza.
D’altronde, la cosa più difficile è mettersi completamente “nudi” davanti al mondo: significa essere capaci di andare controcorrente, senza lasciarsi sedurre dall’idea dominante, senza abbassare la testa davanti alle banalità e alle facili ma inutili aspettative del buon senso comune.
Seguendo questa linea di condotta è più importante soffermarsi su ciò che “sentiva”, dentro di sé, Alessandra Crabbia quando ha scritto ciò che leggerete: e leggerete senza sosta, come se una sottile attrazione spingesse ad andare oltre la pagina davanti ai vostri occhi.
Alessandra Crabbia racconta la storia di Abiura Locura e l’“estraneità” è un segno inciso nell’anima, presente fin dalla sua nascita: impronta distintiva di colei che non soggiace alle regole imposte, colei che non si sottomette alla visione ipocrita della vita né alle sue falsità. Le conseguenze possono essere un duro colpo, ma è il prezzo che si deve pagare.
L’estraneità come costante percezione di appartenere ad un mondo “altro” da quello in cui si trova a vivere, di essere parte integrante di una visione universale, protesa ad una dimensione dell’Essere che alimenta la sua energia dalla fonte primigenia della vita stessa.
Il senso di estraneità significa, quindi, essere “se stessa”, seguire la sua natura e le percezioni che nascono dalla sua dimensione naturale e magica, con la fierezza di essere ciò che è: selvaggia, indomabile come una pantera, una belva feroce che non si dà mai per vinta, fino all’ultima goccia di sangue che possiede nel suo corpo.
Il suo ambiente naturale non può essere altro che la foresta: la foresta come appartenenza e la cultura indio come visione e concezione della vita.
Non a caso, alla sua nascita, Abiura sarà accolta da Parau, colui che diventerà suo padre perché ogni essere della foresta merita di essere accolto e protetto. La simbolica figura del rabdomante Parau, capace di trovare l’acqua in sorgenti segrete con la sua forcella e garantire la vita al suo popolo, l’accompagna nella vita e le insegna a seguire le leggi del popolo della foresta, nonostante la presenza degli uomini bianchi che impongono con la violenza la loro cultura e la loro religione.
Il rabdomante Parau appartiene al “suo mondo, ha “l’odore della foresta” e non ha paura di nessun dio: “gli déi che salvano non sono mai esistiti”, ripete alla giovane Abiura.
E, poi, v’è la continua presenza della magia come contatto tra l’essere umano ed il mondo degli spiriti, il Regno dei morti, gli stessi “morti” che Miedo, la madre adottiva di Abiura, quotidianamente, evoca e contatta, quasi fosse lei ad offrire ai morti la possibilità di sentirsi ancora “vivi”, nel senso di permettere loro, con la sua “chiamata”, un temporaneo ritorno al mondo terreno.
La vita sofferta e tormentata di Abiura diventa simbolo della fatica di vivere: sudore e dolore, carne e sangue, amore e sofferenza, fino alla fine di tutto con la morte.
Abiura conoscerà Severo Lejos, che sarà l’unico vero amore della sua vita e gli chiederà anche di sposarla ma sarà giudicata pazza: “segnale occulto nella trama magica dei fenomeni”, che rimarrà tale perché il suo amore non sarà mai corrisposto. Severo Lejos, purtroppo, non è capace d’amare e vuole stare lontano dall’inquietante irrazionalità che Abiura porta con sé, cercando di raccogliere le vicende esistenziali e filosofiche della sua vita in un “manuale del disperato”, come a constatare, giorno dopo giorno, il suo male di vivere, la vita come “inferno privato”. Il suo rifiuto di amare è il segreto che gli garantisce un faticoso equilibrio psichico: e, per tutta la sua vita, cercherà di rendersi immune all’amore e alle sue follie.
Ma Abiura è una donna intelligente e capace di sentire che quell’amore non sarà mai possibile. La sua vita sentimentale vedrà l’acqua della vita passare velocemente: il suo corpo sinuoso ha una conturbante sensualità e i suoi occhi neri hanno una “fissità implacabile”; il suo animo possiede una selvaggia estraneità ed è indissolubilmente legata alla Natura in modo misterioso. Lei danza scalza il flamenco, canta e scrive poesie.
Conoscerà altri uomini, ma sarà inutile. È destinata alla tristezza infinita del vivere, “all’allegria dei disperati”. Ad una certa età, ormai cinquantenne, non è più il tempo dell’amore: si rende conto che è giunta l’ora di allontanarsi dal mondo del desiderio e di entrare nel mondo della “grazia d’esistere”. Ormai può dirsi libera, dopo anni d’amore inutili, dopo le sventure, le follie e le attese disperate: e, soprattutto, dopo aver resistito al rifiuto di Severo Lejos.
La parola di Alessandra Crabbia penetra nel profondo dell’anima, fino a sconquassarla d’ogni certezza: ma esistono veramente le certezze in questa vita?.
A volte, tutto pare legato ad un sottile filo sotterraneo che noi non vediamo, ma è lì. Presente e silenzioso, misterioso e subdolo: il “caso” giocherà a favore di chi vuole.
La sua narrazione è forte e vibrante: le vicende raccontate sembrano incidere la pelle, lacerarla, sezionarla con un bisturi e, poi, ricucirla con filo magico.
Alessandra Crabbia ha il coraggio di scrivere la cosa più tragica e devastante, al contempo, riesce ad illuminare tutto con l’essenza più autentica dell’amore.
Lei è sciamanica, conturbante e selvaggia. La sua lingua è infuocata, fino a dire: «Sii sempre libera perché sono solo cazzi tuoi». Eppure, mai dimentica, per un solo attimo, che «l’unico miracolo della vita è l’amore».
Massimo Barile
Manuale del disperato
«L’unica conoscenza accessibile agli umani,
è che la vita non ha alcun senso».
(Lev Tolstoj)
«Il manuale del disperato,
non deve essere letto come un libro,
ma ascoltato come la frenesia triste di un tango:
non c’è altro modo di capirne la musica stonata».
(Alessandra Crabbia, intervista del 20 settembre 2012)
«Addio, ogni mattina sei più bella del giorno dopo.
Ogni oggi è il tuo domani.
Ogni ieri è sepolto in questo specchio».
(Severo Lejos, Manuale del disperato)
Premessa
Il giorno in cui nacque Abiura Locura, i Dioscuri di giugno, lottavano infuriati in un cielo che doveva ancora decidere se sposare un sole ardente o una furiosa tempesta: il risultato parve a tutti una sorta di alba boreale stupefatta di se stessa, che non si era mai vista da secoli.
La levatrice, con il largo grembiule sporco di sangue, ma anche di sugo dei fagioli neri cucinati il giorno prima, atterrita dai lampi e dalle ventate impetuose che entravano dalle verande, insieme a terribili raggi crudi di sole incendiario, perse la testa e bestemmiò per la prima volta in vita sua, perché nella sua lunga e affollata carriera, mai aveva visto una nascitura così grassa e grossa e color ocra, e temeva che la sua sempre lodata professionalità, fosse oscurata da quel grasso feto meticcio, incapace di venire al mondo come si deve.
Questo impeto inverosimile della natura, questi sconvolti eventi meteorologici, erano l’insolito annuncio della nascita di Abiura, che li subì inconsapevolmente per tutta la vita, senza sapere di scatenarli a ogni sua emozione forte, perché era scritto che, in modo misterioso e insensato, Abiura e la natura fossero indissolubilmente legate.
La testa della neonata era uscita lucida e potente come un proiettile, ma a metà tronco, la neonata non ce la faceva proprio a sgusciare fuori, e pareva rassegnata a restare a vita a mezza strada, e al tempo stesso riluttante a entrare in un mondo, che a un primo colpo d’occhio, non le era piaciuto.
Nonostante sotto il letto fossero state messe le forbici, per scongiurare i dolori del parto e fossero state attaccate al soffitto le piume di pavone, che allontanavano gli dèi della morte, la levatrice interpretò i segni del cielo furente di cattivo auspicio, e cominciò a temere che nessuna precauzione magica poteva cambiare la volontà del diavolo, che rotolando nel cielo, sentenziava il suo malefico intento di morte.
Sudando per la disperazione, tirando e premendo il ventre della madre che urlava ammazzata dal dolore, finalmente, la tremenda e grassa creatura, schizzò fuori come un colpo di schioppo dalla natura straziata di sua madre Javela, che si sollevò su un gomito a guardare quell’obesa neonata, notando con sgomento che aveva lo stesso neo in mezzo agli occhi, sulla fronte, come il padre, e disse le uniche e ultime parole alla figlia, che squittiva indignata e offesa, sbalordita di esistere:
«Ti chiamerai Abiura. Mio padre sarebbe contento».
Poi, Javela ricadde sul cuscino, e si lasciò andare verso il fiume della morte, nel quale la conduceva l’inarrestabile emorragia che a fiotti la svuotò di una vita che non aveva mai capito, perché non c’era nulla da capire, mentre il cielo impazziva in una baraonda forsennata di tuoni tragici, allegri e arcobaleni.
Quel nome, così drammatico e insolito, era arrivato sulle labbra di Javela, nel delirio tumefatto del parto, perché la marea della morte imminente le aveva portato a galla il ricordo di suo padre Parau, che, in dialetto puelche, significa fedele.
Parau le aveva spesso narrato la vita lenta, mitica, pigra e spudorata dell’età dell’oro della foresta, le amache scosse dal vento frusciante, i furti d’amore da una capanna all’altra, le danze, i sortilegi e le leggende di quel mondo antico, prima dell’arrivo dei pelle-latte, i bianchi, che avevano costretto quei poveri cristi pigri, felici, nudi, sensuali e sonnacchiosi, a vestirsi e a demolire gli idoli di legno degli avi, costringendoli a vestirsi, a vergognarsi quando scopavano, a inginocchiarsi dinanzi a un pelle-latte di creta, appeso a una croce e con più piaghe di un tapiro riempito di frecce dopo la caccia: un dio sconfitto che esprimeva dolore, sangue e condanna, un dio morto come mai si era visto, anche se i pelle-latte sostenevano che in seguito era risorto.
Ma la garanzia di tale miracolo, non traspariva da quel cadavere appeso, e in più non aveva nessuna piuma d’onore al collo, né il suo uccello era esibito per confermare che era un vero uomo capace di figliare, e tra gli anziani si era diffusa la voce che quel pelle-latte di creta non fosse un idolo adatto da inserire tra gli altri dèi, perché non esprimeva nessun carisma, se non quello di portare una sfortuna da perdente terrificante.
Il fatto che i pelle-latte lo chiamassero “Salvatore”, era ancora più sospetto: intorno ai fuochi di sera, se ne parlava, dicendo che un simile dio che era stato squartato e appeso, non era un esempio di salvezza per un popolo come il loro, di cacciatori indomiti e fieri, che si sentivano ogni volta, salvi quando uccidevano gli animali di cui si cibavano, e chiedevano loro scusa prima di scuoiarli.
Se all’inizio i pelle-latte erano stati gentili e amichevoli, poi, come quando cade il fulmine da un cielo giallo, gonfio e muto, avevano costretto il popolo della foresta a vestirsi, a non fornicare apertamente, a credere nel “Salvatore” grondante sfiga.
Lentamente, la pigra, soave imperturbabile dolcezza del popolo aveva accettato queste nuove idee in pubblico, praticandole però privatamente, di nascosto: da questa violenza nacquero la perversione degli istinti, il concetto del peccato e il vaiolo.
Ma Parau, il fedele, non contraddisse il detto che nel nome sta il destino, e negò apertamente di aderire a tali oscuri e snaturati precetti: continuò a fornicare, a vivere nudo e cagò addirittura ai piedi della croce del “Salvatore”, non per spregio, ma per vedere se tale azione avesse scatenato una qualsiasi reazione d’ira da parte del nuovo dio sconfitto portato dai pelle-latte, che tra l’altro, e non si capiva il come e il perché, i pelle-latte avevano ucciso con le loro mani, non appena il “Salvatore” aveva rivendicato la sua natura divina, esercitando ogni sorta di magie sciamaniche.
Fu così che Il grande capo dei pelle-latte in tunica nera e con una gran croce rossa ricamata sul petto, aveva ordinato che Parau fosse catturato e punito, con grande sconcerto del villaggio, perché Parau il rabdomante era in grado con una forcella di trovare l’acqua e le sorgenti nascoste in ogni territorio, ed era un uomo fondamentale, perché garantiva la sussistenza della sua gente nella stagione secca.
Fu legato a un albero del pane e frustato a dovere, ma poiché non desisteva dai suoi principi granitici, gli bruciarono a forza i palmi delle mani sacrileghe e gli urlarono in continuazione una parola a lui sconosciuta:
“Abiura! Abiura! Abiura!”.
Parau restava immobile e impassibile agli sputi e ai calci dei pelle-latte, respirava lento, e si concentrava ad ascoltare il canto degli uccelli, il fruscio dei grossi serpenti, lo scrosciare delle brevi e violente piogge amazzoniche, l’urlo delle scimmie in amore, e quando l’uccello gli si armava, aspettava che calasse, pensando che nulla perdura, nemmeno quella tortura, perché non c’era cosa al mondo che fosse eterna.
Per una settimana restò legato al tronco, cagando e pisciandosi addosso, e nutrendosi di ciò che sua moglie Ara gli portava di nascosto di notte, piangendo e implorandolo di accettare il “Salvatore” come nuovo dio, perché tanto tutti sapevano che gli dèi non avevano mai risposto a nessuno, e mai, mai, avevano evitato malattie e carestie, chiusi nel loro criptico mondo sconsacrato, inaccessibile agli umani, quindi tanto valeva che lui accettasse il “Salvatore”.
Con la faccia pesta e tumefatta, Parau, fissò Ara e le disse:
«Moglie, tu che sei stata sull’amaca con uno di loro, dimmi, cos’hanno i pelle-latte più di noi?».
Ara ci pensò un attimo e poi parlò con cognizione di causa:
«Nulla di più,» disse «a parte l’odore acido, l’uccello troppo veloce, e la paura del “Salvatore”».
«Bene,» disse lui «io ho l’odore verde della foresta, il mio uccello è lento, e non ho paura di nessun dio che salvi: gli dèi che salvano non sono mai esistiti, sono le false favole dei deboli senza coglioni».
Detto questo, Parau continuò la sua privata resistenza, un po’ perché era nato testardo, un po’ perché aveva erroneamente attribuito a quella parola, “Abiura”, un significato di gloria ed eroismo: paradossalmente, era stata proprio quella parola incomprensibile a dargli la forza di resistere, perché per Parau, “Abiura” aveva il significato oscuro di valoroso.
Legato a quell’albero, una notte, sotto l’ultima luna prodigiosa e abbagliante, mentre Parau bruciava di febbre e stanchezza, gli comparvero gli antenati in lacrime, con le sacre piume del saluto, per annunciargli che era arrivata l’ora dell’addio definitivo al suo mondo della foresta.
Il mattino i pelle-latte trovarono l’albero del pane spoglio di Parau: le corde erano tagliate a terra e restavano solo i suoi escrementi.
Era fuggito, abbandonando la sua foresta per sempre, verso il popolo della città degli uomini, che vivevano in case di pietra, e usavano pezzi di ferro tondo scambiandoli per mangiare, uomini che non andavano a caccia ma in carrozze scoppiettanti e velocissime.
Le fughe dal villaggio degli uomini della foresta, erano rare e senza ritorno.
Se ne scappavano in fretta e furia solo gli sciamani che sbagliavano le previsioni e compromettevano le speranze, per non essere linciati dagli incauti consultanti del loro oracolo, o gli uomini incapaci di figliare, che per la vergogna avrebbero dovuto castrarsi per tradizione, o le donne che si erano stufate di mettere al mondo un figlio l’anno, rischiando di morire ad ogni parto, o gli assassini, per evitare la tradizionale condanna di essere fatti a pezzi lentamente, amputazione dopo amputazione.
Fuggì in una notte di luna nera, masticando foglie di coca, e correndo senza volgersi mai indietro, come una goccia d’acqua che cadeva dalle sue amate cascate opalescenti e fragorose.
Dopo due giorni, finì la foresta e vide la città, e qualche rada lacrima gli spuntò sugli occhi, perché sentiva nella gola stretta dal terrore, che l’animale selvatico, il giaguaro che era in lui, la bestia magica che udiva i pensieri e gli odori a chilometri, l’istinto della illimitata spontaneità, sarebbero morti in quelle case di pietra, tra quella gente che parlava sempre, mangiava male, e non sapeva amare.
La sua vita di uomo libero finì per sempre, e iniziò quella che lui chiamò per il resto della sua esistenza, “l’Estraneità”.
La moglie Ara non lo vide più, e Parau divenne a Santa Cruz il miglior rabdomante del secolo, trovando l’acqua sotterranea in ogni deserto, in ogni anfratto diroccato: imparò a usare i vestiti, a tenere a freno la lingua e l’uccello, a conoscere il valore dei pesos, e a parlare quella lingua forestiera, che lui biascicò sempre, incapace com’era di pronunciare la effe e la di.
Nascose in un baule chiuso a chiave ermeticamente, il suo perizoma di caccia fatto di semi intrecciati a fibre vegetali, lo stesso che si era conquistato nella cerimonia della pubertà, al tempo della sua vita tra il popolo della foresta, uccidendo e scuoiando un grosso cinghiale.
Teneva la chiave appesa al collo, e lo nascose sotto il letto.
Ma lui era un “Abiura”, quindi coerentemente non accettò mai il “Salvatore”, costruendo con le sue mani i suoi idoletti privati, che nascondeva nel baule, inginocchiandosi di notte alla luce del fuoco della cucina dinanzi al dio scimmia, al dio tucano, al dio giaguaro, alla maschera della morte e a quella della caccia.
Non masticò più foglie di coca, perché non doveva più correre per cacciare, ed iniziò a fumare il tabacco di grossi sigari aromatici, che lo intorpidivano e gli consentivano di sopportare “l’Estraneità”.
Si era costruito nel tempo una casa di legno, cercando di mescolare lo stile indio a quello dei pelle-latte, e il risultato fu stupefacente, per i balconi arricciolati, le curvature al soffitto degne di un dipinto di Van Gogh, i murales esterni ed interni con scene di caccia, giaguari appostati, tapiri in corsa e tucani dallo sguardo pietrificato, le amache appese tra una trave e l’altra, che però erano solo lì per bellezza, perché Parau si abituò a dormire su un letto, per scacciare almeno di notte “l’Estraneità”, e per dare a Javela prima, e a Abiura dopo, una parvenza di normalità borghese.
Incapace di legarsi a una donna del popolo della città, ebbe però una figlia, Javela, che in puelche significa “Raccolta sulla Soglia”, da una lavandaia che arrotondava il salario vendendosi di notte.
La sicurezza incerta della sua paternità, era stata confermata dai capelli lisci color dell’ebano e dagli occhi di lince della bambina, che aveva lo stesso colore ocra della pelle del padre.
Ma anche se non fosse stata sua figlia, Parau l’avrebbe accolta come figlia, perché la madre l’aveva rifiutata alla nascita, e gliel’aveva depositata davanti alla porta di casa, scomparendo per sempre.
Parau seguiva sempre le leggi del popolo della foresta, che ordinavano di accogliere e salvare tutti gli esseri indifesi e in preda ai pericoli di cui la vita è piena: la tirò su dalla soglia di casa e poiché nel suo cervello non esisteva nessun concetto di maternità e paternità, ma di compassione e salvaguardia della sacralità della vita, se la prese in casa, la allattò con latte di capra diluito, la pulì scrupolosamente dagli escrementi, le cantò le nenie del suo villaggio, e se la attaccò alla schiena finché Javela non fu in grado di camminare.
La gente di Santa Cruz si abituò a vedere Parau il rabdomante, con la sua magica forcella trova-acqua, che teneva la bambina in uno scialle legato sul dorso, pieno di amuleti e pietruzze contro la malasorte.
Pochi allora erano in grado di stupirsi o stigmatizzare, perché la gente d’allora sostava in una soave e violenta convivenza tra la scelleratezza allegra delle nuove razze e la moralità incerta e taciturna di quelle vecchie.
Così come aveva accettato la sua nascita, con la stessa imperturbabile rassegnazione, accettò la sua morte, vent’anni dopo, quando Javela morì di parto lasciandogli una nipote, Abiura.
Non gli interessò mai sapere chi fosse il padre, perché nella mente degli uomini della foresta, questo era un particolare irrilevante: essi accettavano la vita per quello che era, non per il possesso ereditario di qualcuno, perché la madre era l’unica depositaria della magia della nascita, e nessun diritto maschile era riconosciuto tra loro, che praticavano da migliaia di anni il libero amore.
Javela non confessò mai al padre di essere stata sedotta da Nicanor Lejos, il figlio del barone Quentin Lejos, e di aver concepito sua figlia nello sgabuzzino adiacente alla cucina dove lavorava come sguattera, nella gran casa baronale, piena di scale fulgide di marmo, di ritratti di avi appassiti e impassibili, di anfore d’argento, e di effluvi ottenebranti dei bei fiori carnosi che ornavano il patio con la disinvoltura che può dare solo la bellezza unita alla ricchezza.
Del resto Javela stessa non aveva mai compreso cosa l’avesse spinta a darsi con tanta energia a un ragazzo molle, viziato, instabile e corrotto come Nicanor, che l’aveva usata come si usa una puttana gratuita, con i pantaloni calati a mezza coscia e l’odore di sciacquatura di piatti e di papaya marcia nel retro della cucina. Forse ciò che l’aveva colpita, era quel neo che Nicanor il seduttore aveva in mezzo agli occhi, sulla fronte, come molti idoli di Parau.
Javela sapeva d’istinto e senza alcuna letteratura, che la vita è quel che è, e fa i fatti suoi navigando nel non senso insito in essa, per la qual cosa, ogni ribellione o ricerca di una qualsivoglia giustizia, è meramente vana.
La natura possiede tutte le doti per creare i capolavori più sublimi, le brutture più sconce, e le rarità più sconcertanti, in questo sta la sua esilarante e drammatica ironia che ci condanna sempre al dramma, alla sorpresa, o alla commedia, tutti noi sottoposti al suo giogo ineludibile e feroce: Abiura, nata da un sangue nobile, marcio e decomposto, e da uno animale, selvatico e pagano, divenne poi quella inquietante e estraniante mescolanza di genialità solida e di sconfortante lucidità esistenziale, che dimostrava come nella vita i risultati non conoscono né la matematica, né la logica, né le previsioni scontate.
Il barone Nicanor Lejos non seppe mai di aver concepito Abiura, né negli anni ricordò le sue intemperanze sessuali con una serva meticcia, che per lui aveva lo stesso valore di una vacca da monta: lui già aspettava un figlio da sua moglie, la baronessa Marisa Lorca, figlia del generale Severo Abuelo De Alcantar, una pallida, capricciosa e frigida creatura, dalle ciglia appannate e scialbe, e dal carattere isterico e imperativo, che viveva solo perché così le era capitato, e non sarebbe mai stata in grado di distinguere la realtà cruda della sua inconsistenza, dall’importanza che si dava.
In un gennaio gelido, in cui il capricorno svettava tra i santi del calendario, all’ora di pranzo, l’evanescente creatura dovette riconoscere che anche lei avrebbe dovuto partorire come tutte le altre donne del mondo, in mezzo alle urla da animale straziato, al sangue uterino e agli escrementi sfuggiti dalle spinte, e in un batter d’occhio le uscì dalla nobile vagina il bambino più raggrinzito, magro e inerme che si fosse mai visto, che nascendo, gettò un unico grido intelligente, composto e sobrio di allarme, e poi tacque subito, infelice di dover prender parte a una cosa così insensata come la vita.
La sofisticata e linda levatrice in trine e merletti, emise un gridolino, esaminando il triste e grinzoso bambino:
«Guardate, ha lo stesso neo in mezzo alla fronte del signor barone!».
Marisa guardò il neonato con interesse metafisico, e sentì la gelida corrente dell’orgoglio di casta percorrerle il corpo pallido e lattiginoso.
Guardò il marito Nicanor e disse senza esitazione:
«Si chiamerà Severo, come mio padre, e non se ne discute».
Nicanor Lejos avrebbe voluto dire qualcosa, ma proprio in quell’attimo, un vecchio grumo di sangue che era rimasto immobile per anni, si mosse vivace e mortale, per portare una creativa e terrificante embolia al suo baronale e banale cervello.
Non riuscì a proferire una parola: stramazzò al suolo, tirando le cuoia in modo del tutto conclusivo e aristocratico, con la rapida e sciolta eleganza che solo i ricchi possono detenere: quasi tutti i poveri, hanno destino di morti lente, buie e immerse nella tristezza del lento e ignobile marciume della carne, che non conosce la rapidità pietosa dell’estetica.
Da tutti questi avvenimenti stolti e irregolari, da queste due nascite oscuramente consanguinee, legate entrambe alla morte veloce come una folgore, s’intrecciarono poi molti destini profondi, magici e torturati, nell’arco di un secolo folle, nella città assatanata e avventuriera di Santa Cruz, sorta ai confini della grande foresta che taceva assorta nel suo mistero.
In seguito, questa storia arida, arcana e appassionatamente corrosiva, divenne per chi la visse, la subì, o semplicemente la narrò, una sorta d’ironico, struggente e stupefatto, manuale del disperato.
Primo capitolo
Ciò che lascia stupiti ancora oggi, è che la strepitosa evidenza del genio multiforme di Abiura Locura, fu sbadatamente data per scontata nei primi e ultimi sessant’anni della sua vita: i posteri non trovarono mai una spiegazione logica a tale oscuro, illogico e inspiegabile destino, meravigliandosi di come avessero fatto i suoi contemporanei a rifiutarsi di notare un fenomeno così lampante, e ad essere ciechi, sordi e muti dinanzi alle sue arti, battezzandola con quel cognome, Locura, Pazzia, non tanto per spregio, ma per darle quella connotazione sociale che lei non possedeva: ma l’invisibilità sociale di Abiura era la prerogativa logica della “Estraneità”.
Del resto Parau non aveva un cognome, perché non era usanza tra il popolo della foresta averne uno, visto che tutti i figli erano del popolo intero, e di unico presidio delle loro madri, perché il libero amore non garantiva a nessun maschio una paternità certa, pertanto ciò escludeva la tirannide dei padri padroni, le gelosie private e le guerre per la successione ereditaria di beni e titoli.
Santa Cruz era allora una città composta da una società prodigiosa, sorta vicino al grande fiume Pituma, patria di tristi immigrati da tutte le terre più povere del continente, di malviventi ripuliti dall’anonimato di una terra straniera, di puttane sagge e felici, di residuati della vecchia e ormai bolsa e ammanicata nobiltà iberica, di meticci senza radici che praticavano con passione l’artigianato indio, di avventurieri in cerca di una fortuna che non abitava da nessuna parte, di sicari prezzolati per tirar giù dalle spese i nemici altrui, di maghe erranti che con i loro riti alcolici e orgiastici, riuscivano a convincere i clienti che li avrebbero liberati da ogni perversa fattura e maledizione della sorte, giocando sul fatto che la casualità assolutamente imbecille dei destini, nel cinquanta per cento dei casi, funzionava davvero.
L’energia magnetica, carnosa, e oscuramente medianica della grande foresta pluviale vicina, soffiava il suo vento umido sugli spiriti della città, e toglieva il respiro, caricava le passioni di un peso arcano e mortale, e accendeva e spegneva le menti ritmicamente, come danze sotto i moribondi fuochi d’artificio, e tutta questa mescolanza di aromi spirituali potenti, esasperavano l’odio, l’amore, l’allegria e l’estasi, fornendo poi insieme a tutti questi eccessi, anche una rassegnazione silenziosa, implacabile e illuminata dinanzi alla sventura e la morte, considerate ineluttabili e olimpicamente invincibili.
Parau si prese in casa una donna, Miedo Corona, non per amore o per comodità sessuale, ma per il senso di compassione che sempre albergava nel suo cuore di uomo della foresta: pensò di restituire una famiglia a una donna così provata dal dolore e confinata ai margini della società per il suo talento oscuro.
Miedo aveva perso il marito e una figlia durante l’ultimo terremoto, da cui era l’unica sopravissuta (e si capirà in seguito il perché), ed era rimasta istupidita dal dolore, senza più alzarsi dal sofà dove giaceva muta, stringendo al petto le foto dei suoi amati, e parlando con loro in continuazione.
Perché il lavoro di Miedo era proprio parlar coi morti, e sulla soglia di casa sua si era sempre accalcata la gente che cercava il conforto degli estinti, o la scoperta di dove avessero nascosto denaro e gioielli, o rassicurazioni sulle loro malefatte.
Una notte, Parau, tornando a casa, l’aveva sentita piangere con tanto strazio, che il suo cuore indio aveva fiutato gli odori di morte e dolore così forti da bussare alla porta della donna.
Miedo aveva aperto, con il viso deformato dal pianto, i capelli neri lunghi fino alle ginocchia.
Si erano fissati lenti, capendosi in un attimo.
Lui l’aveva trascinata verso il letto senza una parola, e l’aveva fatta sedere, e atteso con pazienza che le lacrime cessassero.
Quando si era quietata, l’aveva svestita amorevolmente e scopata con tutto l’amore che aveva in corpo, per riportarla alla vita.
Poi erano rimasti sdraiati in silenzio nel buio, mentre la tenda della finestra volava alla brezza portata dal vento del sur, che espandeva con sé gli effluvi aromatici e carnali della grande foresta.
«Ce l’hai una figlia, e anche un uomo, se vuoi, Miedo» disse Parau nella penombra «Non sono quelli che la vita aveva scelto per te, ma il caso è sempre più forte del destino, non ci sono cazzi».
Mai vi fu matrigna più amorevole e coscienziosa di Miedo, e Abiura si abituò a vederla ricevere i clienti in cucina, con i lunghi capelli che spazzavano il pavimento, a fissarli con le orbite vuote, mentre sui fornelli cuocevano le trippe e le patate dolci, e a vomitare sul tavolo bava bianca retrattile, finché ecco, la sua voce si trasformava e timbri vocali baritonali o infantili uscivano dalla sua gola contratta: erano i defunti, che stanchi di essere morti, si prendevano una vacanza e chiacchieravano con i loro parenti, a volte incazzandosi a tal punto da rovesciare il tavolino e sbattere pugni violenti sul muro.
«Non aver mai paura dei morti,» le diceva Miedo abbracciandola forte «fanno tanto rumore perché qualcuno si ricordi di quanto hanno amato. Guardati invece dai vivi, che non fanno mai rumore perché nessuno si ricordi di quanto hanno odiato».
Era un bel mondo quello dei morti, pensava Abiura, perché potevano dire tutto ciò che volevano e scappare al momento giusto senza esser presi: inoltre il loro vigore, il loro serafico ottimismo, le loro risatacce e le loro predizioni li confermavano grandi teatranti, enfatici e poliedrici, sempre lodati e applauditi da tutti.
Spesso qualche morto si affezionava a Miedo più del dovuto, e restava fino all’ora di cena, facendo tintinnare i bicchieri e strappando la tovaglia, ma quando Miedo gli urlava la sciamanica frase “Vattene affanculo”, il morto impenitente se ne andava in un lampo, così com’era venuto.
Miedo fu poi la depositaria occulta di un secolo e mezzo di storia, seppellì tutti coloro che conosceva e che la precedettero: il problema di Miedo era che non riusciva a morire.
Diventò proverbiale nei suoi centocinquant’anni di vita, la sua straordinaria capacità di sopravvivenza: scampò miracolosamente a un camion che la travolse, a una tegola che le cadde in testa da un cornicione, a un tumore maligno all’utero, all’assalto di una muta di cani alsaziani ferocissimi, alla coltellata di un pazzo furioso, a una trave che le cascò addosso con incredibile tonfo nella cattedrale di Santa Cruz, a una bomba anarchica che esplose nel mercato della frutta, a una sparatoria tra bande rivali in cui si era trovata casualmente sotto tiro, al tifo, al vaiolo, alla setticemia, all’annegamento durante la piena del fiume Pituma, al crollo della casa durante i terremoti.
«Il fatto è che i defunti non vogliono che io muoia,» diceva ogni volta svegliandosi nell’ospedale dei poveri, tra lo stupore di medici e malati «perché se crepo io, i morti si annoiano e diventano tristissimi di non esistere. Sono fatti così, non sopportano di essere dimenticati, e mi salvano ogni volta per non sparire per sempre».
Il primo giorno di scuola, Abiura Locura, accompagnata da Parau, calzava i mocassini morbidi fatti dalle amorevoli mani del nonno, indossava un vestituccio di canapa da lui tessuto, con disegni tribali, e aveva al collo ogni sorta di pietruzze e amuleti contro il malocchio, il colera, il vaiolo, e i pidocchi: la bambina, grassa, distratta e simile a un idolo indio, suscitò l’ilarità immediata di tutti i compagni, ma questo non le diede nessuno sgomento né alcun complesso, perché aveva assorbito da Parau non solo la sua indifferenza alle norme sociali, ma anche la grande ed ereditaria “Estraneità”, che poneva entrambi su un piano dell’essere che sorvolava sopra la vita del popolo della città, come un falco pellegrino senza fissa dimora.
A sei anni, Abiura sapeva già suonare il banjo, danzare, dipingere murales incredibili, modellare statue con la creta, recitare a memoria le poesie che s’inventava, parlare indio puelche, spagnolo e inglès e cantare come un usignolo: tutte le arti avevano preso forma in lei in modo così dirompente, che parevano scaraventate nel suo corpo da un dio distratto e annoiato in un giorno di pioggia.
Eppure, come accade paradossalmente agli spiriti più talentuosi, le più grosse difficoltà nella sua breve esistenza furono sempre quelle di dare un ordine logico e sociale ai concetti più elementari, che richiedevano quella minima intelligenza spicciola comune a tutti i mortali, che ad Abiura mancava totalmente.
[continua]


